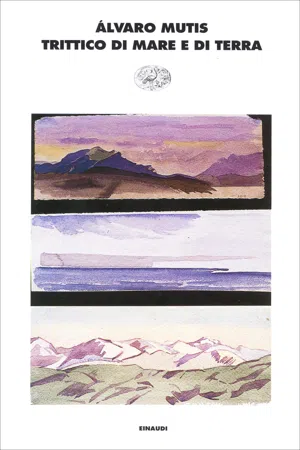![]()
A mio nipote Nicolás
![]()
Sinon l’enfance, qu’y avait-il alors qu’il n’y a plus?
SAINT-JOHN PERSE
C’è un episodio nella vita di Maqroll il Gabbiere che non ha quasi nulla in comune con quelli che ho narrato nel corso di questi ultimi anni ma che, comunque, comportò un cambiamento essenziale nel disordine delle sue avventure e gli consegnò, nella tappa finale dei suoi giorni, una sorta di serena rassegnazione nei confronti della contraddittoria fortuna del proprio destino e lo portò a esercitare, fino alle estreme conseguenze, la sua dottrina di accettazione senza riserve dei profondi segreti dell’innominabile. Non che la sua vita, dopo questa esperienza che mi accingo a raccontare, fosse priva di vicissitudini e incidenti della piú diversa natura e origine, solo che lo spirito con cui Maqroll li affrontò aveva infine perso quella carica di sfida, di tenace sfiducia senza ricompensa che aveva caratterizzato in precedenza il suo errare per il mondo.
Il fatto in sé può, forse, sembrare al lettore abbastanza normale e di ordinaria amministrazione nella routine familiare di alcuni di noi. Ma se si conosce il passato del nostro personaggio, ci si renderà immediatamente conto che quanto a noi può apparire episodio comune e naturale, per Maqroll fu un’esperienza del tutto insolita e ricca di sorprese che gli rivelarono un territorio fino ad allora inesplorato della sua vita sentimentale.
Avrei potuto raccontare il fatto in forma diretta e come narratore onnisciente e onnipresente. Ho preferito, invece, cercare di trascrivere le parole precise con cui Maqroll ci raccontò la sua esperienza. In tali parole, che annotai subito dopo averle ascoltate, si celano tutto il sordo dolore che gli costò quel particolare episodio ed anche i momenti rivelatori, di felicità senza ombre, che visse allora. Vediamo, quindi, come mi fu dato di conoscere questa storia.
Sono solito visitare Cartagena de Indias non appena il caso me ne dia l’opportunità, poiché conservo di questa città un ricordo cosí carico di nostalgia e cosí pieno di istanti che hanno segnato in modo indelebile il resto della mia vita, che non posso smettere di percorrere, ogni volta che mi è possibile, l’allucinato labirinto delle sue stradine ed estasiarmi, dal belvedere delle sue mura di austera arroganza militare, nella lenta danza del suo mare antillano. Quando ancora era tra noi il mio amato amico il pittore Alejandro Obregón, andavo sempre a fargli visita nella sua casa di calle de la Factoría dove intraprendevamo, con l’aiuto di una bottiglia di scotch che lui teneva da parte per gli amici, un lungo peregrinare nel nostro passato comune che si confondeva con i ricordi dell’infanzia, belgi i miei, tedeschi i suoi.
In una di quelle visite alla Città Eroica bussai alla porta di Alejandro nel momento in cui si scatenava uno di quegli acquazzoni interminabili e opprimenti che irrompono in città durante tutto il mese di ottobre. Mi aprí Alejandro in persona, sorridente e con un’espressione da bambino che ha ricevuto un regalo inaspettato.
– Cazzo! Sono felice che tu sia venuto. È la scusa di cui avevo bisogno per non dipingere e far festa con un buon bicchiere.
Entrammo nello studio e ci accomodammo nelle grandi poltrone di cuoio, che conoscevo bene, costellate di macchie di tutti i colori possibili, a denunciare la lotta del pittore con la materia dei suoi quadri. Dalla parete pendevano tele appena terminate. Una magia onirica emanava da quegli angeli dal corpo di fanciulla, adolescenti abbaglianti che scaturivano, tra penombre color malva, da una gamma di verdi che andavano dal piú delicato delle foglie appena germogliate fino al cupo della selva impenetrabile; il tutto al centro di un’esplosione di azzurri intensi e rossi che si trasformavano in luminoso arancione. Era la nuova maniera di Obregón, una nuova epoca della sua pittura che si accordava stranamente con quanto stavo allora scrivendo. Gli manifestai il mio entusiasmo per quei dipinti e lui mi rispose, con una luce particolare negli occhi azzurro acciaio che indicava un’estrema soddisfazione:
– Lo sapevo che ti sarebbero piaciuti. Queste angele mi appaiono ora in sogno e io le dipingo perché non mi sfuggano. Ciò che non torna nei sogni non ci accompagnerà nell’altra vita.
Ero abituato a queste enfatiche dichiarazioni del mio amico, sulle quali era meglio non investigare poiché si perdeva in discorsi ancor piú ingarbugliati.
La pioggia ci serví da pretesto per finire la bottiglia di Dewar’s che Alejandro aveva lasciato di fronte a me sul tavolo ingombro di pennelli e di tubi di colore spremuti fino in fondo. Parlammo, come ho detto, della nostra giovinezza ormai lontana e degli amici il cui ricordo ci serviva per rievocare zone del nostro passato condiviso. All’improvviso, Alejandro, nel pieno del vortice dei ricordi, mi chiese bruscamente:
– E ora, dove andrai?
Gli spiegai che sarei andato in Spagna per le vacanze.
– Bene, – mi rispose, – perché ho un incarico per te. Si tratta del nostro amico Maqroll. Ti faccio vedere qualcosa che ti turberà come ha turbato me.
Andò a un altro tavolo, anche questo ingombro di pennelli e tubi di colore, in un angolo del quale teneva una cartella con ogni sorta di scartoffie. Ritornò con una busta e me l’allungò senza dire nulla.
I francobolli erano spagnoli e il timbro postale era di Pollensa, a Maiorca. Conteneva una lettera scritta con quella calligrafia inconfondibile e transilvanica che fotografava subito il Gabbiere. Si trattava di poche righe scritte su un foglio di carta sulla cui intestazione si leggeva: «Parrocchia di San Jaume. Mosén Ferrán Alaró. Rettore». Diceva quanto segue:
«Alex,
Abusando dell’ospitalità del mio buon amico parroco, le scrivo queste righe che andranno come la leggendaria bottiglia per il mare. Questa volta la vita è riuscita a colpirmi nel punto giusto. Non sono cose di cui si può parlare per iscritto. Sono un po’ avvilito e sperduto. Nessuna delle strade che prima erano solite offrirsi alla mia inquietudine ora mi attrae. Se lei potesse venire qui, cosa che immagino abbastanza improbabile, mi sarebbe di grande sollievo raccontarle di che si tratta e gioire della sua compagnia. Lo stesso dico riguardo al nostro comune amico che continua laggiú a scrivere le mie avventure e a lasciare testimonianza delle mie sfortune. So bene che viene spesso in Spagna, mosso dalle sue simpatie per Al-Andalus, per i califfati omayyadi e per il regno di Maiorca, che sono la nostra passione. Se lo vede, gli mostri queste righe. È tutto, mio amato pittore di angele puberi e inquietanti. Nessuno piú di voi può capire ciò che si nasconde dietro queste righe.
Le manda un grande abbraccio il suo amico
Maqroll il Gabbiere».
Conoscendo come conoscevo il personaggio, mi fu chiaro che la lettera celava una richiesta d’aiuto appena dissimulata. Maqroll non era uomo incline a lamentarsi. Ogni tanto si limitava, piuttosto, a tirare due o tre maledizioni in turco o in francese e in questo modo recuperava la calma. Era evidente che ora si trattava di qualcos’altro.
Per quanto Maiorca non fosse nei miei piani di vacanze in Spagna, decisi di far visita al mio amico a Pollensa e lo dissi ad Alejandro. Questi commentò soddisfatto:
– Bene. Ora sono tranquillo. So che con una bella chiacchierata con lei le cose andranno meglio. Lei è l’uomo ideale per questo compito. E lo dico io che da tanti anni le racconto le mie sconfitte.
Un lieve rossore apparve sul volto abbronzato di Obregón. Era profondamente schivo, e a dire il vero non ricordavo di aver sentito da lui confessioni di questo genere. Almeno non apertamente. Da tempo mi ero reso conto che molti dei suoi ermetici e labirintici ragionamenti dovevano nascondere episodi sentimentali. La mia affettuosa pazienza nell’ascoltarli gli comunicava forse, per vie segrete, una certa complicità. La vera amicizia spesso poggia su questi occulti ma efficaci vasi comunicanti.
La pioggia cessò poco tempo dopo. Ci salutammo con lo stesso forte abbraccio silenzioso con il quale ci separavamo sempre come se non ci si dovesse mai piú rivedere. L’ultimo, di non molto tempo fa, lo conservo nella memoria con un dolore che non accenna a diminuire.
Mia moglie e io arrivammo a Maiorca in pieno autunno, ma il gregge di turisti portava ancora a spasso la propria germanica opulenza per le strade di Palma e la denudava, con orrore dell’assennato paesaggio dell’isola, su tutte le spiagge che poteva invadere. Carmen era riuscita a parlare da Barcellona con Mosén Ferrán e questi ci aspettava all’aeroporto. Era lí, grosso e sgraziato, passati di sicuro i sessant’anni, a darci il benvenuto con una cortesia un po’ campagnola, rivolgendosi a mia moglie in un catalano che si sforzava di evitare dosi eccessive di maiorchino. Il dialogo, a partire da quel momento, si svolse all’interno di quel codice. Io continuavo a parlare in spagnolo, comprendendo, ovviamente, quanto loro si dicevano, grazie all’allenamento di piú di un quarto di secolo di matrimonio con una catalana. Richiamò particolarmente la mia attenzione il volto espressivo del parroco, con le spesse ciglia scure, la bocca dalle labbra delicate, sempre con il sorriso spontaneo e ironico di chi ormai ha vissuto a sufficienza per dare importanza solo all’essenziale e lasciare il resto da parte con indulgenza per le miserie dei propri simili. Gli occhi scuri e sempre attenti, aperti di fronte all’interlocutore, denunciavano da lontano l’origine saracena degli abitanti dell’isola. La calda voce da basso profondo del simpatico sacerdote conferiva un’enfasi un po’ teatrale a tutto ciò che diceva. Prese con mano decisa la valigia di mia moglie e mentre ci dirigevamo a un taxi che ci aspettava per condurci fino a Pollensa, disse soddisfatto:
– Il nostro amico vi aspetta ed è molto contento della vostra visita. Mi ha chiesto di scusarlo per non essere venuto ad accogliervi, ma la sua ostilità nei confronti degli aeroporti qui si fa piú forte per colpa del turismo che ci invade.
Il taxi verso il quale ci dirigemmo era una vecchissima automobile che mi rese assai scettico sul fatto di riuscire ad arrivare fino a Pollensa. Nell’accorgersi del dubbio che avevo dipinto in volto, Mosén Ferrán si affrettò a rassicurarmi:
– Non si preoccupi. Questo taxi, cosí come lo vede, ogni settimana fa il giro dell’isola e non si è mai fermato per strada. L’artefice di tale miracolo è il conducente, mio nipote, che ha preferito le Seat alle macchine europee. Insomma, Dio sa come fa le cose. A Roger è andata molto bene, e anche a me, dato che sono il padrone di quest’anticaglia.
Il giovane conducente, che intanto sistemava le nostre valigie nel bagagliaio della macchina, ci sorrise allegro salutandoci con un gesto del capo tra il confidenziale e il distratto. Metteva in mostra le stesse sopracciglia di suo zio e aveva la stessa pelle olivastra, ma i suoi capelli, nerissimi e crespi, rivelavano senz’ombra di dubbio il passaggio su quell’isola degli eserciti dei califfi. Anche lui parlava con voce da basso, ma non cosí profonda come quella del consanguineo e con un accento ancor piú marcato.
Mosén Ferrán occupò il sedile accanto a suo nipote e noi salimmo su quelli posteriori. Rimanemmo in silenzio, attraversando la città ancora invasa dai turisti che ostruivano le strade e rendevano difficile il passaggio delle auto. Ormai in aperta campagna, tornò a sorprendermi la luminosità della notte maiorchina che mi trasmette sempre una sorta di ordine interiore, a cui anelo senza sosta e che rare volte conseguo. C’è qualcosa di omerico in quella lontana fosforescenza di mondi in placido viaggio nel pieno della notte mediterranea.
Cercai di portare il parroco sull’argomento Gabbiere per conoscere la sua opinione sulla malinconia che la lettera di Maqroll suggeriva e della quale gli parlai.
– Sarà meglio, – mi rispose con un tono tra il cordiale e il definitivo, – che sia lui in persona a raccontarle tutto. Come ho già ho avuto occasione di dire a sua moglie quando ci siamo sentiti telefonicamente, non si tratta della salute del Gabbiere né, ancor meno, di qualche impiccio di tipo economico. Sapete bene che quell’uomo è sempre senza un centesimo in tasca e quello che gli pagano per fare la guardia ai cantieri navali abbandonati e ai macchinari che vi riposano consumati dall’ossido e dal salnitro del mare gli è sufficiente per vivere in quell’austerità che sospetto sia stata una costante nella sua vita. È cambiato qualcosa in lui nel profondo dell’anima, anche se è indubbio che continui ad accettare i mutevoli decreti del destino e che sia aggrappato al suo perpetuo vagabondare. Ora si trova qui, apparentemente deciso a rimanerci per un tempo indefinito, anche se nelle simpatiche chiacchierate che diverse volte abbiamo fatto non perde l’occasione per ricordare, con evidente ansia, porti lontani o illusorie imprese nei piú sperduti angoli del mondo. Non c’è nessuna donna di mezzo, – aggiunse voltandosi verso mia moglie con un sorriso di complicità. – Ma non devo aggiungere altro poiché desidero che sia proprio Maqroll a raccontarvi quale sia stata la prova che ha dovuto superare e come questa abbia lasciato nella sua anima una sensazione di inutilità e di sconfitta piuttosto insolita in lui fino a oggi, a quanto mi risulta.
Passammo a parlare di altre cose. Chiesi all’illustre sacerdote della sua biblioteca sulla storia del regno di Maiorca. Con soddisfazione che non cercò di celare, mi informò che era la piú completa che potesse esistere di proprietà di un privato e cominciò a spiegarmi la sua curiosa teoria secondo cui tutta la storia dell’Occidente cristiano o ha origine a Maiorca, o è passata dall’isola nei suoi momenti critici. – A Maiorca, – affermò, – sono accaduti alcuni fatti chiave che hanno dato forma all’Europa moderna –. L’argomento, cosí impostato, offriva non pochi punti deboli o almeno difficili da provare ed ebbi la tentazione di discutere con Mosén Ferrán alcuni di essi. Ma il parroco di San Jaume si mise a parlare dei miei racconti che hanno come personaggio principale il Gabbiere e delle mie poesie in cui Maqroll parla della sua vita transumante. Mi segnalò che, a suo parere, mi manca ancora molto per scoprire il carattere del nostro comune amico e mi rimproverò, non senza discrezione, di non essermi soffermato abbastanza sulle teorie di Maqroll circa episodi storici che il Gabbiere, secondo il parroco, conosce meglio di quanto io lasci intendere nei miei libri. Cercai di spiegargli che ho sempre cercato, in questi casi, di evitare lo sviluppo di tesi storiche che avrebbero deformato lo spirito delle mie narrazioni e, ancor di piú, quello delle mie poesie. Si limitò a rispondermi che, se lo avessi fatto, avrei avuto l’opportunità di mettere in luce un aspetto della personalità di Maqroll che lui è solito nascondere alla curiosità della gente.
– Il Gabbiere, – disse, – è un anarchico nato che fa finta di non saperlo o che non riesce a vedersi come tale. La sua visione del transitare dell’uomo sulla terra è ancora piú ascetica e amara di quanto lasci intendere nel suo agire quotidiano. L’altro giorno gli ho sentito affermare qualcosa che mi ha sbalordito: «La scomparsa di questa specie, – mi ha detto, – sarebbe un notevole sollievo per l’universo. Poco dopo la sua estinzione, un totale oblio cadrebbe sulla sua storia nefasta. Esistono insetti capaci di lasciare testimonianze del loro passaggio meno effimere e fatali di quelle dell’uomo». Ho cercato, com’era ovvio, di ribattere con argomenti tratti dalla teologia e dalla storia, e lui si è limitato a rispondere, con quell’enfasi che gli è tipica, da uomo sul ponte di comando, con la quale sa tagliar corto a ogni discussione: «Lei, mio caro Mosén Ferrán, è corazzato da una fede e da una tradizione religiosa che la proteggono efficacemente da ogni dubbio. Anch’io lo sono stato in gioventú, ma la mia corazza è caduta in pezzi come una corteccia putrida. Lassú, sull’albero piú alto, posto d’osservazione del gabbiere, interrogando l’orizzonte, ogni mistero sfuma tra il passaggio degli occhioni e dei gabbiani e lo schioccare delle vele contro il vento. Niente resta in piedi dentro di noi. Mi creda». Comprenderete, ora, – proseguí il sacerdote, – che non mi ha concesso molte opportunità per continuare il dialogo su questa strada. Il fatto mirabile è che, tra tante macerie sentimentali e di ogni altro genere, sia riuscito a conservare la sua bontà ruvida e schietta. Questo è un altro degli enigmi del nostro amico.
Mi incuriosí quanto Mosén Ferrán conoscesse bene Maqroll e pensai, non senza una certa invidia, alle animate e interminabili chiacchiere durante le quali si era andata formando quest’amicizia sostenuta da comuni interessi su questioni storiche e sui semplici ma sempre inquietanti e rivelatori aneddoti del quotidiano vivere degli uomini.
Seguí poi, dopo le parole del sacerdote, un lungo silenzio. La testa di Mosén Ferrán cominciava a ciondolare per il sonno e il beccheggio dell’automobile. Mezz’ora dopo arrivammo a Pollensa.
Le luci della città si riflettevano nelle acque serene della baia. Gli yacht attraccati ai moli del Club Nautico dondolavano pigramente e i loro ormeggi gemevano con un suono flebile e sonnolento.
Scendemmo in un modesto albergo in cui Mosén Ferrán aveva prenotato una stanza con vista sulla spiaggia. La padrona era una sua lontana cugina, donna Mercé, signora piacevole e di poche parole, sempre vestita di nero a causa di una vedovanza tenacemente rispettata come uno speciale segno distintivo che metteva in risalto il suo bell’aspetto. Ci aveva preparato una cena che accettammo con entusiasmo per l’appetito che ci si era risvegliato durante il viaggio. Mentre ne venivano ultimati i dettagli, decisi di andare a salutare Maqroll. Il nipote del parroco mi accompagnò fino ai cantieri abbandonati dove il Gabbiere svolgeva le mansioni di sorvegliante.
Tra le costruzioni semidistrutte regnava un’oscurità assoluta. Il bacino vuoto mostrava apertamente i resti della sua antica struttura di concrezione e l’armatura di legno era crollata a causa delle intemperie. Una tettoia fatta di strati di zinco anneriti dall’ossido doveva essere il vecchio spazio destinato agli uffici. L’autista suonò appena il clacson. A una finestra del secondo piano, in parte coperta di cartoni che rimpiazzavano vetri rotti da chissà quanto tempo, si accese la luce di una lanterna a petrolio che ci illuminò per un istante.
– Scendo, – si udí l’inconfondibile voce del Gabbiere con il suo accento mediterraneo e cadenzato ma dall’impeccabile pronuncia. Nonostante o forse a causa di ciò, spesso lo si prendeva per un francese del Midi. Attraverso gli interstizi tra gli strati di zinco, vedemmo scendere la luce per scale che scricchiolavano in modo allarmante. Maqroll accese la lampadina protetta da una griglia metallica che si trovava sopra la porta d’ingresso. La luce illuminò in pieno e con brutale crudezza il volto del Gabbiere.
Non riuscii a mascherare l’impressione che mi provocò il suo aspetto. Non era come se gli anni lo avessero ghermito all’improvviso. Pensai piuttosto a un’altra di quelle febbri che spesso lo devastavano senza misericordia. Notò la mia reazione ma, con un pallido sorriso poco convincente, cercò di far finta di nulla. Salutò l’autista, ringraziandolo per avermi accompagnato, e mi invitò a entrare nell’edificio sconquassato. L’autista mi disse che avrebbe preferito aspettarmi perché queste erano le istruzioni di Mosén Ferrán e la cena sarebbe stata pronta da lí a mezz’ora. Il Gabbiere alzò le spalle in cenno di assenso e cominciammo a salire le scale che, a ogni passo, minacciavano di crollare. Nell’arrivare al primo pianerottolo entrammo in ciò che un tempo doveva essere un ufficio e che ora costituiva l’abitazione del sorvegliante.
Su un grande sofà foderato di pelle Maqroll aveva improvvisato il suo letto, e cioè due coperte piuttosto logore e un cuscino con macchie di origine incerta. Il Gabbiere posò la lanterna su un tavolo traballante ingombro di libri e andò ad accendere una lampada a gas che pendeva da un gancio al centro della stanza. Su quella che doveva essere stata una scrivania c’erano alcune tazze, due bicchieri e diversi barattoli di latta che dovevano contenere caffè in polvere, zucchero e altri alimenti. Tutto intorno a una piccola cucina da campo. Dalle pareti pendevano planimetrie di imbarcazioni dei piú diversi tipi e grandezze, dai grandi cargo a due ciminiere fino ai velieri a tre alberi. Si vedevano anche planimetrie di motori diesel e sezioni di scafi e di alberature, tutto in uno stato di...