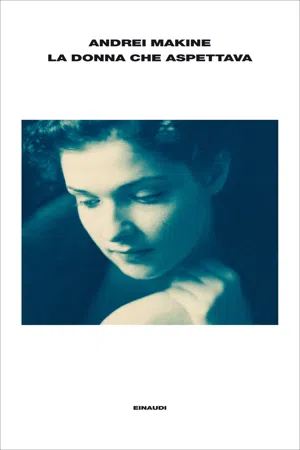![]()
1.
«Una donna cosí intensamente destinata alla felicità (fosse anche una felicità puramente fisica, un banale benessere carnale) che sceglie, quasi con leggerezza, la solitudine, la fedeltà verso un assente, il rifiuto di amare…»
Ho scritto questa frase in quel particolare momento in cui la conoscenza dell’altro (di quella donna, di Vera) ci pare acquisita. Prima ci sono la curiosità, la divinazione, la sete di confessioni. La fame dell’altro, l’attrazione per i suoi sotterranei. Decifrato il segreto arrivano le parole, spesso pretenziose e categoriche, che dissezionano, stabiliscono, classificano. Tutto diventa comprensibile e rassicurante. Allora può cominciare la routine di una relazione o di una indifferenza. Il mistero dell’altro è addomesticato. Il suo corpo è ridotto a una meccanica carnale, piú o meno desiderabile; il suo cuore a un inventario di reazioni prevedibili.
In realtà questa fase è una specie di assassinio, perché uccidiamo quella creatura infinita e inesauribile che abbiamo incontrato. Preferiamo aver a che fare con una costruzione verbale piuttosto che con un essere vivente…
Durante quei giorni di settembre, in un villaggio tra foreste che si estendono fino al mar Bianco, devo aver annotato riflessioni come: «una creatura inesauribile», «un assassinio», «la donna messa a nudo dalle parole»… A quel tempo (avevo ventisei anni), queste conclusioni mi sembravano molto acute. Aver indovinato la vita segreta di una donna che aveva l’età di mia madre, averne formulato il destino in poche frasi tornite mi riempiva di un piacevole orgoglio. Pensavo al suo sorriso, al gesto con cui mi salutava scorgendomi da lontano, sulla riva del lago, all’amore che avrebbe potuto offrire a tanti uomini e che invece non dava a nessuno. «Una donna cosí intensamente destinata alla felicità…» Sí, ero alquanto fiero della mia analisi. Ricordavo perfino che nel XIX secolo un critico aveva parlato di dialettica dell’anima per definire, negli scrittori, l’arte di sondare le contraddizioni della psicologia umana. «… una donna destinata alla felicità, ma…»
Quella sera di settembre ho chiuso il taccuino e guardato la manciata di mirtilli freddi e marezzati che Vera aveva versato sul tavolo in mia assenza. Nel riquadro della finestra, sopra le creste nere della foresta, il cielo tratteneva un pallore lattiginoso che lasciava intuire, a qualche ora di cammino, la pacata presenza del mar Bianco, già in attesa dell’inverno. La casa di Vera si trovava all’inizio di un sentiero che, attraverso forteti e colline, conduceva al lago. Ho pensato alla solitudine di quella donna, alla sua calma, al suo corpo (molto fisicamente, ho immaginato quel corpo femminile avvolto da una coltre di tepore, sotto la coperta, in una limpida notte di gelo) e a un tratto ho capito che nessuna dialettica dell’anima avrebbe saputo dire il segreto di quella vita. Una vita di gran lunga troppo limpida e dolorosamente semplice rispetto alle mie dotte analisi.
La vita di una donna che aspettava l’uomo che amava. Nessun altro mistero.
L’unico elemento enigmatico, o meglio aneddotico, era il mio errore: dopo il nostro primo incontro di fine agosto, durato pochi secondi, avevo rivisto Vera un’altra volta, all’inizio di settembre. E non l’avevo riconosciuta. Ero convinto che fossero due donne diverse.
Eppure mi sembravano entrambe «cosí intensamente destinate alla felicità…»
In seguito avrei imparato a distinguere il dislivello dei sentieri, il manto vivo degli alberi, nuovo a ogni svolta, le curve sfuggenti del lago di cui presto sarei stato in grado di seguire le sponde a occhi chiusi. Ma in quel giorno di fine estate cominciavo appena a conoscere la regione, camminavo senza meta, eccitato dall’idea di poter scoprire, oltre quella foresta di larici, un villaggio abbandonato o dalla sfida di un ponticello di legno semidistrutto da attraversare in equilibrio come un funambolo. Fu proprio all’ingresso di un villaggio dall’aria disabitata che la vidi.
Per un attimo credetti di aver sorpreso una coppia di amanti. Nella boscaglia che invadeva le rive del lago scorsi la luminosità di un fianco bianchissimo, il profilo di un torso teso dallo sforzo, sentii un respiro ansimante. La serata era ancora chiara, ma il sole radente e di un rosso scorticato striava la vista d’ombra e di fuoco, incendiando le foglie dei salici. Dal fondo di quello sfolgorio, quasi sfiorando il suolo argilloso con il mento, emerse un viso di donna, che subito si rovesciò all’indietro in un violento fiotto di capelli… L’aria era calda, umida. Gli ultimi residui della stagione, un’«estate indiana» portata per qualche giorno dal vento del Sud.
Stavo per passare oltre quando, preceduta da un improvviso sussulto di rami, la donna apparve, scrollò il capo in un vago cenno di saluto e si riaggiustò svelta il vestito tirato sopra le ginocchia. La salutai anch’io, goffamente, senza riuscire a distinguere bene il viso, su cui si alternavano raggi di tramonto e striature d’ombra. Ai suoi piedi, come il corpo di un annegato, era arrotolata una grossa rete da pesca che lei aveva appena tirato.
Per qualche istante restammo immobili, uniti da una complicità ambigua, simile a quella che nasce da un amplesso frettoloso in un luogo poco sicuro o da un crimine. Guardavo i suoi piedi nudi, rossi di argilla, e la massa della rete che si muoveva a scatti: i corpi verdastri di alcuni lucci si dibattevano con forza e sopra, aggrovigliata fra i galleggianti, si allungava la linea sinuosa, quasi nera, di ciò che in un primo momento scambiai per un serpente (probabilmente un’anguilla o un giovane siluro). Quell’ammasso di fili e di pesci gocciolava piano, l’acqua mista alla fanghiglia rossa fluiva verso il lago, come un sottile rivolo di sangue. C’era afa, come prima di un temporale. L’aria ferma ci imprigionava in una posa immobile, un’inerzia da incubo. E c’era la consapevolezza condivisa, istintiva e tacita, che tra quell’uomo e quella donna, in quel calar del giorno rosso e violento, tutto era possibile. Assolutamente tutto. Niente e nessuno per impedirlo. I loro corpi potevano stendersi vicino al groviglio della rete, concedersi l’un l’altro, abbandonarsi al piacere mentre le vite prese nelle maglie agonizzavano…
Me ne andai in fretta, con la sensazione di aver schivato, per vigliaccheria, il momento in cui il destino si incarna in un luogo, in un volto. Il momento in cui il caso ci lascia intravedere la sua oscura trama di cause ed effetti.
Una settimana dopo fu il castigo, un vento da Nord-est che portava la prima neve, come per vendicarsi di quei pochi giorni di Eden. Un castigo piuttosto mite, fatto di mulinelli bianchi, lucenti, vertiginosi, che confondevano le prospettive dei sentieri e dei campi facendo sorridere la gente, abbagliata dalle continue sventagliate di fiocchi. L’aria pungente e amara aveva il sapore della speranza nuova, della felicità promessa. Le bufere scaricavano raffiche di cristalli sulla superficie nera del lago, che inghiottiva quel bianco fragile nelle sue profondità. Ma le rive erano già imbiancate di neve, e gli sfregi fangosi che il nostro camion lasciava sulla strada erano subito rimarginati.
L’autista con cui spesso andavo da un villaggio all’altro si dichiarava ironicamente «la prima rondine del capitalismo». Otar, georgiano, sui quarant’anni, fondatore di una pellicceria clandestina e finito in prigione in seguito a una denuncia, ora godeva della libertà condizionata ed era addetto alla guida di quel vecchio camion dalle sponde tarlate, in quella regione del Nord. Eravamo a metà degli anni settanta, e «la prima rondine del capitalismo» riteneva di essersela cavata piuttosto bene. «Oltretutto qui ci sono nove femmine per ogni maschio», ripeteva spesso, con uno scintillio negli occhi e il sorriso ingordo.
Parlava sempre e soltanto di donne, viveva per loro, e immaginavo che perfino il suo commercio di pellicce fosse stato pensato per poterle vestire e svestire. Detto questo, Otar, intelligente e perfino sensibile, esagerava sicuramente il suo credo di donnaiolo sapendo che quella era l’immagine dei georgiani in Russia: amanti ossessionati dalle conquiste, maniaci del sesso, ricchi e triviali. Impersonava quella caricatura come spesso agli stranieri capita di scimmiottare i cliché turistici del proprio paese d’origine. Per non deludere la platea.
Al di là di quella recita, e in tutta naturalezza, Otar considerava il corpo femminile l’unica cosa per cui valesse la pena vivere. E non poterlo confidare a un amico indulgente sarebbe stata la tortura peggiore. Volente o nolente, avevo assunto quel ruolo. Per gratitudine Otar sarebbe stato disposto a portarmi al polo Nord.
Nei suoi racconti, non so come, riusciva sempre a evitare la ripetizione. Eppure si trattava immancabilmente di donne desiderate, sedotte e possedute. Le prendeva sdraiate, in piedi, accucciate nella cabina del camion, addossate al muro di una stalla nella ruminazione sonnolenta delle bestie, in qualche radura ai piedi di un formicaio («Avevamo tutti e due le chiappe massacrate da quelle maledette formiche!»), dentro bagni di vapore… Il suo linguaggio era crudo e fiorito al tempo stesso: cosí spaccava «quel gran culo come un’anguria» e con il vapore «le tette crescono, si gonfiano, sul serio, lievitano come la pasta del pane»; o ancora: «l’ho spinta contro un ciliegio, gliel’ho ficcato dentro e l’ho sbattuta cosí forte che le ciliegie ci piovevano addosso, eravamo tutti rossi di succo…» In fondo era un vero poeta della carne, e la sincerità della sua estasi di fronte al corpo femminile salvava le sue storie dalla monotonia dei coiti.
Un giorno commisi l’imprudenza di domandargli in che modo avrei potuto capire se una donna era pronta ad accettare le mie proposte.
– Se ha voglia di scopare? – esclamò dando una sterzata. – Ma è semplicissimo, devi solo farle una domanda… – Da buon attore prolungò la pausa, visibilmente felice di istruire un giovane sprovveduto. – Basta sapere se mangia aringa affumicata.
– Che cosa c’entra l’aringa?
– Beh, se mangia aringa affumicata avrà sete…
– E allora?
– Se ha sete, berrà molta acqua.
– Non ti seguo…
– Se beve acqua piscerà, sei d’accordo?
– Sí, e allora?
– Beh, se piscia dovrà pur avere un sesso.
– Questo è ovvio, ma…
– Se ha un sesso, ha voglia di scopare!
Scoppiò in una lunga risata che coprí il rombo del motore e mi assestò alcune pacche sulle spalle, dimenticando la strada spazzata dalla bufera. Era proprio il giorno della prima neve, all’inizio di settembre. Eravamo appena arrivati in un villaggio dall’aria deserta che non riconobbi. Né le isbe trasfigurate da strati di fiocchi, né le sponde del lago ricoperte di bianco.
Otar frenò, prese un secchio e andò verso un pozzo. Il suo camion, antidiluviano, consumava tanta acqua quanta benzina. – Come quelle che mangiano aringa salata, – scherzò strizzandomi l’occhio.
Stavamo per rimetterci in marcia quando comparvero. Due donne, una alta e abbastanza giovane, l’altra anziana e minuta, risalivano il pendio che dal lago conduceva alla strada. Avevano appena fatto un bagno nella piccola isba dal cui camino si alzava ancora un velo di fumo. La vecchia camminava a fatica, lottando contro i colpi di vento e sottraendo il viso alle raffiche di neve. La sua accompagnatrice sembrava quasi sollevarla. Portava un lungo cappotto militare, di quelli che un tempo si usavano nella cavalleria. Aveva la testa scoperta (forse, sorpresa dalla neve, aveva ceduto il proprio foulard all’anziana) e sotto il panno grezzo del cappotto il suo collo sembrava di una delicatezza quasi infantile. Giunte sulla strada presero per il villaggio. Ora le vedevamo di fronte. In quell’istante una folata piú violenta delle altre spinse indietro un lembo del lungo pastrano e per un attimo vedemmo il biancore del petto, che la donna subito ricoprí, chiudendo seccata i risvolti del cappotto.
Otar guardava fisso attraverso la portiera aperta, senza mettere in moto. Aspettavo i suoi commenti ripensando a «le tette che con il vapore si gonfiano…» Ero sicuro di dovermi sorbire qualche tirata ridente e salace. E per la prima volta sentivo che un simile discorso, per quanto scherzoso e innocente, mi avrebbe disturbato.
Ma Otar non si muoveva, le mani sul volante, gli occhi rivolti alle due ombre femminili che a poco a poco svanivano sotto la bufera…
La sua voce risuonò insieme alla frizione e agli schizzi di fango sotto le ruote: – Benedetta Vera! Lei aspetta! Aspetta all’infinito! Si è rovinata la vita con quest’attesa! Ucciso o scomparso, che differenza fa… Uno piange, siamo d’accordo, butta giú una bella dose di vodka, d’accordo, porta il lutto, benissimo, è la tradizione, ma poi deve ricominciare a vivere. La vita continua, merda! Quando è partito per il fronte, nel ’45, Vera aveva sedici anni, e da allora aspetta, perché sulla sua morte non ha mai ricevuto nessun documento affidabile. Si è sepolta qui, con tutte quelle vecchie dimenticate dal mondo che raccatta mezze morte nel bosco. E aspetta… Sono trent’anni, cazzo! E hai visto com’è ancora bella…
Tacque. Poi mi lanciò un’occhiata feroce e con voce sferzante gridò: – Questa storia non ha niente a che fare con l’aringa salata, razza di coglione!
Stavo per ribattere sullo stesso tono pensando che l’insulto fosse rivolto a me, ma non dissi niente. Dalla disperazione con cui colpí il volante capii che ce l’aveva con se stesso. Il suo volto perse il colorito abbronzato, si spense. In lui, lo sentivo, c’era un violento rifiuto a capire quella donna; e al tempo stesso, da montanaro qual era, provava per quell’attesa il rispetto quasi sacro che si riserva a un voto, a una promessa…
Restammo in silenzio finché non arrivammo in città, il capoluogo del distretto, dove lo salutai. Sulla piazza centrale, coperta di neve fangosa, una coppia di giovani sposi circondati di parenti stava scendendo la scalinata di un palazzo amministrativo per infilarsi nella prima auto di un corteo infiocchettato. In cielo, oltre il tetto piatto, oltre una bandiera rossa sbiadita, passava un vivace triangolo di oche selvatiche.
– Sai, forse Vera non ha tutti i torti, – disse Otar rispondendo alla mia stretta di mano. – E poi non sta né a me né a te giudicarla.
Non cercavo di «giudicarla». Semplicemente, qualche giorno dopo quell’incontro sotto la neve, la vidi camminare in lontananza, lungo la sponda del lago.
La giornata era gelida e tersa – il regno dell’autunno, dopo gli ultimi spasmi di un’estate che si era dibattuta tra la canicola e le tempeste di neve. La neve si era sciolta, il terreno era duro e asciutto, le foglie dei salici scintillavano, lamelle d’oro nell’aria azzurra. Sentivo che quei campi assolati mi accettavano, cosí come l’ombra compatta della foresta o le finestre di qualche isba, che sembravano scrutarmi con benevolenza e malinconia.
La riconobbi, sulla sponda opposta: un tratto scuro che solcava quell’incendio freddo e dorato. La seguii a lungo con lo sguardo, sorpreso da un pensiero semplice che vanificava ogni altra riflessione sul suo destino. «Ecco una donna di cui so tutto, – mi dicevo. – Ho tutta la sua vita davanti a me, condensata in quella sagoma lontana che costeggia il lago. È una donna che da trent’anni, cioè da sempre, aspetta l’uomo che ama».
L’indomani volli raggiungere le rive del mar Bianco. Una delle anziane abitanti del villaggio mi indicò il sentiero quasi inghiottito dalla foresta e mi assicurò che lei stessa, da giovane, ci arrivava in mezza giornata – per cui io, con le mie gambe lunghe… Mi persi a un passo dal litorale. Pensando di aggirare una collina mi ritrovai in una torbiera umida, a sguazzare in mezzo a rigagnoli che emanavano un forte odore di palude. Il mare era vicinissimo, a tratti il suo alito spazzava via l’afrore dell’acqua stagnante… Ma il sole stava calando, dovevo rassegnarmi a rientrare.
Il mio ritorno assomigliava alla fuga dopo una sconfitta. Nient’altro che sentieri sconosciuti, disordinati cambiamenti di rotta, l’assurda paura di perdermi davvero, e poi tutte quelle tele di ragno e il sale del sudore che dovevo levarmi dalla faccia.
Il villaggio e il lago emersero all’improvviso, nel momento piú insperato, come da un sogno. Un sogno calmo, rischiarato dalla pallida trasparenza del tramonto. Mi sedetti su un grosso blocco di granito che un tempo doveva aver segnato i confini di una proprietà. In qualche secondo sopraggiunse la fatica, cancellando perfino l’irritazione per aver mancato la meta. Mi sentivo svuotato, assente, come se di me fosse rimasto solo quello sguardo lento, che scivolava senza peso sul mondo.
Nel punto in cui il sentiero per il villaggio incontrava la strada che portava al capoluogo vidi Vera. A quell’incrocio, fissato a un palo, c’era un piccolo cartello con il nome del villaggio, Mirnoe. Un po’ piú in basso era inchiodata una cassetta delle lettere che, a parte quando arrivava il giornale locale, era quasi sempre vuota. Vera si avvicinò al palo, aprí il battente di latta, infilò la mano nella cassetta. Per quanto fossi lontano, sentii che quel gesto non era meccanico, non lo era ancora diventato…
Ricordai il nostro primo incontro, fugace, a fine agosto. La grossa rete da pesca, lo sguardo di una sconosciuta, il suo corpo accaldato per lo sforzo. La mia certezza che tutto tra noi fosse possibile. E la sensazione di aver perso un’occasione. Lo avevo annotato nel mio taccuino. Adesso quegli appunti mi sembravano assolutamente incongrui. Quella donna che c...