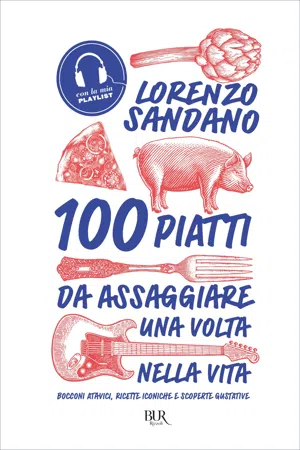KEBAB
Divinità pagana per gli studenti squattrinati, manufatto miracoloso nel post-sbronza, patrono dei guerrieri della notte. A qualsiasi ora. Per qualsiasi credo, polo geografico o deriva culturale.
Il kebab è un alleato leale e costante, paradigma di un world wide gastronomico, arrotolato in una piadina da mille e una notte. In Europa, attecchisce nel cemento di una Berlino anni Settanta: idea di due cuochi turchi, che ribaltarono in verticale lo spiedo della ricetta tradizionale (“kebab” significa sostanzialmente “arrostito”) per cuocere e imbottire i celeberrimi panini, gli stessi che mi allietarono rocambolesche serate berlinesi, sbaragliando l’altrettanto noto curry wurst. La sua accordatura, però, ha lontane origini mediorientali: carne di montone infilzata in spade di guerrieri persiani e consumata con pane naan o azzimo, poi mutata e diffusa con variegati ceppi carnivori e prefissi (shish, seekh, čelow, döner) in India, Iran, Grecia, Turchia e l’intero bacino del Mediterraneo. Un cibo nomade e cosmopolita, che ruota intorno al globo alla pari del suo benevolo piedistallo appuntito.
In sua untuosa compagnia, ho svoltato le nottate più fosche e le albe più allucinate della mia adolescenza. Scorpacciate a orari improbabili, barcollando sulle vetrine del kebabbaro di Colli Albani. Che trip! Tra i tanti ricordi succosi, eleggo quello che me lo fece scoprire: un concerto degli Ska-P, ad appena sei anni, vissuto “a cavacecio” sulle spalle di mio padre. Protetto, scrutavo dall’alto il groviglio di corpi che saltellava nel centro sociale, a tempo col 2-tone e con i rivoltosi vocaboli ispanici. Ero troppo piccolo per carpire il senso di mescolanza etnica e integrazione strillato sul palco, ma mi piaceva.
Come mi piacque al primo morso quel cibo ignoto offertomi da papà. Quasi una traduzione culinaria delle tematiche delle canzoni, affettate in falde di agnello e riposte all’interno di una soffice pita con salsa bianca e piccante d’ordinanza. Non il miglior kebab della vita, ma un’iniziazione libertina a quel gusto etnico in levare. Saziante e senza frontiere.
VIENNOISERIE E PATISSERIE
In principio è il richiamo olfattivo a ipnotizzarmi: burrosità seducenti fuse a fragranze color vaniglia e a croste caramellate appena eruttate dal forno. Segue il corteggiamento estetico, che si dipana lungo volumetrie lievitate dai cromatismi ambrati, allineate sui bancali con grazia geometrica, come i pulsanti di una tastiera. Scenario struggente, che mi fa piombare nell’indecisione al momento della scelta. Le grida frenetiche di chi attende in fila mi sollecitano bruscamente al giudizio. Supero il blocco, comincio a sognare: uno strappo gentile sulla sfoglia di quel croissant e ogni corsa delle lancette pare azzerarsi. Soffice, croccante, setoso, filante e finemente unto.
Dal primo ingresso nel mondo della viennoiserie e patisserie a Parigi, in adolescenza, il mio rapporto con queste opere d’arte bianca è pura ossessione. Un rito di contemplazione glicemica, che adotto per riappropriami del tempo sottratto. Transitare dalle marmitte isteriche della routine agli aromi primari e rincuoranti di una pasticceria è il mezzo che il mio inconscio ha elaborato per troncare gli affanni delle meningi e lasciar correre pensieri distesi.
In Francia, l’amore per questi impianti dolciari mi portava a rimbalzare come un tossico da un indirizzo all’altro, alla ricerca del miglior pain au chocolat, con l’insistenza martellante di una cassa techno. Riconnesso al suolo natio, ho scovato il parallelo perfetto tra quelle soavi atmosfere e il trambusto metropolitano: Pavé a Milano.
Boutique propagatrice di attimi e dessert emozionali, ove ogni allarme temporale viene sistematicamente interrotto. Il fine è immergersi, scordando l’urgenza di alzarsi, campionando estasianti creazioni dall’accento francofilo: millefoglie gravide di crema e intrecci sfogliati di brioche dai BPM inebrianti; tarte au citron che accendono elettroniche sequenze palatali e saint-honoré con l’intensità incalzante di una drum machine. C’è anche spazio per una sacher fixata al metronomo.
Assorto e assorbito in un rave di volti deliziati, abilitato soltanto a godere, nell’andatura di un tempo che raramente possiedi.
LIÈVRE À LA ROYALE
Uno stendardo nero lucente, che si erge selvatico, sventolando l’orgoglio della gastronomia francese, stemma culinario che raggruppa stirpi di cacciatori e tradizioni noblesse senza distinzioni. Modello di ricette arcaiche, lunghe e laboriose, che descrivono apparati stagionali nei loro succhi, una pietanza regale e ribelle: la lièvre à la royale.
Per la storia, è opera del celebre cuoco Carême, secondo alcune novelle nasce invece alla corte del Re Sole: ghiotto di cacciagione e malato ai denti, chiese di escogitare un piatto per poter apprezzare la carne senza l’onere di masticarla.
Un rotolo di lepre disossata e imbottita di tartufi e foie gras, glassata a specchio con una salsa fitta e addensata allo stremo, che emana violente percussioni di selvaggina, marinature vinose ed effluvi bellici di sangue ridotto. Un gusto duro dallo spartito erudito, che mi rimanda al vagabondaggio debuttante nella Ville Lumière. Io, punkettone ingenuo e sgualcito, che trovava il fegato di sedersi nelle più altisonanti insegne trois étoiles, venni fulminato, al primo accordo, dalla composizione brutale e fine di quel medaglione di lepre tout noir.
Passione mai addomesticata, che mi ha indotto negli anni a cacciarla anche lungo perimetri italiani. Tra i primi a proporla, Luigi Taglienti: cuoco di origini liguri, votato alla cacciagione e a esercizi affilati, speculare all’essenza della ricetta, per il suo approccio simultaneamente militaresco e trasgressivo dinnanzi ai fuochi. La sua versione richiede diversi giorni, ma li vale tutti. L’animale viene prima frollato e appeso a grondare resti umorali, poi spolpato di spalle e cosce che si amalgamano al ripieno di maiale, tartufo nero, erbe e lobi di fegato grasso. Le ossa, marinate in vino rosso e aromi, sono tostate in funzione di una salsa coagulata col sangue stesso della lepre. L’esemplare farcito, ricucito, porzionato e cotto è nappato integralmente dal lucido intingolo sanguigno. Un look trionfale e vellutato da tarte au chocolat, che rivela sapori robusti e appuntiti, dalle profondità indomabili.
TACOS
Dischi ondulati, porosi e duttili, con interminabili gradazioni di colori, strutture e condimenti, gravitanti sul terroir messicano, come i presunti UFO intercettati dalle civiltà precolombiane. Sorvolando tesi di fantascienza, i tacos sono il vero fulcro della gastronomia made in Mexico. Risultato di usanze millenarie, scaturite da un ingrediente sacro come il mais, considerato dai Maya l’elemento con cui gli dei plasmarono l’uomo. Già impiegato da popolazioni azteche per realizzare tortillas cotte su pietre roventi, a mo’ di primitivi cucchiai commestibili. L’approdo dei conquistadores converte la ricetta alla carne suina e a contaminazioni in salse variopinte, innescando l’evoluzione graduale in cibo ambulante, frutto di impasti e cotture variabili, ripiegato e addizionato a un panel incalcolabile di farce: agnello o montone (cotti lentamente, in forni scavati sotto terra); frutti di mare; purè di patate, fagioli; cotenne di maiale; cavallette e molte altre ancora.
Tra i miei preferiti c’è il taco al pastor, figlio di influenze libanesi: maiale marinato nella spezia achiote e arrostito allo spiedo. Adoro il flow versatile e democratico dei tacos, consumati a iosa gongolando tra food truck e chioschetti sparpagliati per il globo. Latito nell’esperienza indigena, lo ammetto, ma in attesa di colmare questa lacuna ho scovato un’autorevole alternativa anche a Roma: La Punta.
Cristian Bugiada è un barman self made dal talento vulcanico, innamorato del Messico e dei prodotti culturali che ne derivano. Con un gruppo di soci ha fondato un ritrovo dal puro groove messicano nel cuore di Trastevere, dove tacos e mezcal dominano la scaletta di offerte. Azzannare il suo taco poblano mi fa schiacciare il tasto play a tavoletta sul rap mariachi di S...