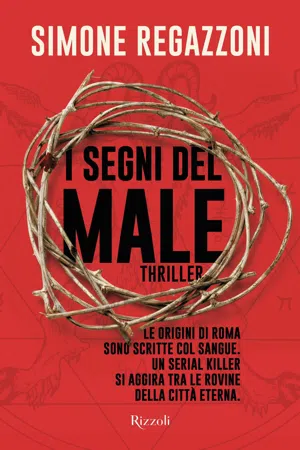Neve sulle auto in coda sul raccordo anulare.
Neve sul Colosseo e i Fori Imperiali.
Neve sulla fontana di Trevi.
Neve su Castel Sant’Angelo e lungo le sponde del Tevere, sul Verano e sulla basilica di San Pietro.
Vista dall’alto, Roma era un pulsare di luci multicolori in un turbine bianco, per la gioia dei turisti che si scattavano selfie con i monumenti storici avvolti nella bufera.
Tra quelle foto ve ne erano alcune che, al momento della pubblicazione su un profilo Instagram, non avevano destato particolare attenzione: tre like nelle prime cinque ore.
Il giorno seguente, dopo l’esplosione del caso, e milioni di visualizzazioni, il profilo era stato oscurato.
La foto ritraeva un uomo con addosso una pelliccia e sul capo una testa di lupo nel sito archeologico del Lapis Niger, nell’area del Foro romano. Insieme alle foto alcune parole, in una lingua sconosciuta ai più.
QUOI HON / SAKROS ES / ED SORD OKA FHAS / RECEI IO / EVAM / QUOS RE KALATO / REM HAB / TOD IOUXMEN / TA KAPIAD OTAV M ITER PE / M QUOI HA / VELOD NEQV / IOD IOUESTOD LOVQVIOD QO
Alle 22 il vento che accompagnava la nevicata si era fermato: i fiocchi avevano preso a danzare secondo una traiettoria perpendicolare, lentamente, simili a cenere.
Roma era avvolta in un silenzio surreale.
Una città di ghiaccio pronta a addormentarsi.
Attorno alle 22.10, secondo le ricostruzioni del patologo forense, l’assassino aveva iniziato la sua opera.
Lento, metodico, preciso.
Aveva impiegato circa due ore.
Nessun raptus. Calcolo e attenzione maniacale ai dettagli.
Una scena del delitto controllata.
La perfezione dell’orrore.
La sofferenza portata all’estremo, e oltre: in quello spazio dove non c’è più nulla di umano, solo il dolore della carne viva.
Il tempo impiegato per uccidere e infierire sulla vittima era stato calcolato incrociando i dati dell’autopsia e quelli di alcune telecamere di sicurezza collocate all’esterno del sito archeologico.
I resti del corpo erano stati scoperti solo a tarda notte, dopo una telefonata anonima alla polizia.
Erano adagiati vicino a un altare sotterraneo risalente all’epoca della Roma arcaica.
I circa cinque litri di sangue della vittima erano stati fatti fuoriuscire dal corpo, ma ne restavano solo poche tracce sulla scena del delitto.
Un massacro.
Un rito.
Compiuto dall’uomo che su Instagram si era registrato come “Romulus”.
Il nome di un efferato serial killer morto otto anni prima.
Roma, 21 dicembre 2020
Da dove proveniva quella musica?
No surprises.
Versione acustica: chitarra e pianoforte.
Ci vollero alcuni secondi perché si ricordasse dov’era.
Si svegliò.
Cercò a tastoni il cellulare sul comodino: controllò il numero. Restò alcuni istanti, come incantata, ad ascoltare la voce di Thom Yorke. Poi rispose, interrompendo bruscamente la suoneria dei Radiohead. Portò il cellulare all’orecchio. La sveglia sul comodino segnava le 2.10 della notte.
«Rakar, perché non rispondi? Ti ho chiamata tre volte!»
Giulia si mise a sedere sul letto, senza avere la forza di parlare. Effetto della melatonina che usava da troppi anni. Un rumore proveniente dal corridoio la fece voltare di scatto, i sensi all’erta.
Si guardò attorno, evitando di accendere la luce.
Un miagolio.
Sorrise.
Luna, la sua gatta norvegese, saltò sulle coperte e le si avvicinò, la schiena inarcata in cerca di carezze. Giulia iniziò a passarle le dita dietro la nuca. Era morbida, calda.
«Maledizione, mi stai ascoltando?»
«Sì, sì…» Uno sbadiglio interruppe le sue parole. «È che di solito provo a dormire a quest’ora.»
Aveva la voce impastata.
«Tra dieci minuti ti mando un’auto.»
«Cosa…?»
Giulia, ancora intontita, non capiva cosa stesse succedendo.
«Rakar, abbiamo un cadavere.»
Luna le si accoccolò tra le gambe.
«Non credo sia la prima volta.»
Ci fu silenzio, poi il tono di voce del commissario Ettore Santià cambiò, come se fossero entrati in un territorio diverso.
«C’è bisogno di te.»
Giulia smise di accarezzare Luna.
Il commissario Santià aveva riattaccato senza aggiungere altro.
Non era necessario.
Si alzò; i piedi nudi sul parquet freddo.
Riprendere il contatto con il mondo.
Sapeva cosa l’aspettava.
Andò in bagno, la gatta la seguì miagolando.
Aprì il rubinetto dell’acqua fredda, fissò il tappo sul fondo del lavandino, appoggiò le mani sul bordo e lasciò che l’acqua lo riempisse fino all’orlo. Teneva la testa bassa, evitando di guardarsi nello specchio sopra il lavabo: i capelli biondi a coprirle il volto. Trasse un profondo respiro e immerse la testa fino alle orecchie nell’acqua fredda.
Come cadere in un lago ghiacciato.
I capelli ondeggiavano nell’acqua, simili a un anemone di mare.
All’improvviso ogni rumore scomparve, tranne il battito sordo del suo cuore che accelerava. Sapeva cosa sperava di vedere: le linee di luce ondeggianti sul fondo di una piscina comunale in un pomeriggio di giugno. Aprì gli occhi. Osservò il tappo nero di plastica che chiudeva il lavandino attraversato da una sottile ragnatela di crepe: non aveva mai cambiato i sanitari di quella vecchia casa.
Trattenne il fiato, la testa indolenzita per il freddo.
Restò così quasi un minuto, poi una serie di bolle d’aria cominciarono a uscirle dalla bocca.
Sollevò la testa di scatto, la bocca aperta per riprendere fiato. Una parte dell’acqua traboccò dal lavandino. Luna fece un balzo all’indietro. Il volto di Giulia, riflesso nello specchio, mostrava tutta la sua stanchezza.
Restò a guardarsi ansimando.
L’acqua che sgocciolava dal volto e dai capelli cominciò a inzupparle la canottiera nera che aderiva al suo corpo muscoloso e perfettamente allenato.
Osservò i lividi sulle braccia e le spalle, traccia dell’ultimo allenamento di Mixed Martial Arts. Per un istante ricordò la sensazione di quando, dopo il trauma, aveva sofferto di depersonalizzazione: si ritrovava a osservare il suo corpo dall’esterno, come se non le appartenesse e avesse vita propria.
Continuò a guardare nello specchio senza asciugarsi.
Non si prendeva eccessiva cura del proprio aspetto estetico. Nessuna particolare acconciatura: i capelli raccolti in una coda o in una treccia. “Alla vera bellezza non servono trucchi” le aveva detto una volta sua nonna, quando ancora era una ragazzina.
E Giulia era decisamente bella.
Zigomi alti, occhi color ghiaccio, tagliati leggermente a mandorla: non c’era bisogno di sapere che il cognome Rakar era sloveno per capire che quella bellezza fredda ed elegante veniva dall’Est. I nonni paterni di Giulia erano originari di Cerknica, un piccolo comune sloveno non distante dal confine italiano. Giulia conservava solo uno sfocato ricordo di una visita ai nonni all’età di sei anni, un anno prima della tragedia. Avevano passeggiato sul lago ghiacciato che prendeva il nome dalla cittadina: il lago di Circonio. E il nonno le aveva raccontato che si trattava di un lago magico, frequentato anticamente da streghe e stregoni, perché aveva il potere di apparire e sparire.
Giulia si asciugò la faccia e i capelli e uscì dal bagno.
Andò in cucina: c’era ancora l’odore di olio fritto del cibo cinese con cui aveva cenato davanti al computer guardando su Netflix la serie tv The OA.
Versò un po’ di crocchette nella ciotola di Luna, che smise di miagolare e di interessarsi alla padrona. Poi aprì il frigo su cui si distinguevano i segni di vecchi adesivi staccati. Bevve due lunghe sorsate di latte freddo direttamente dal cartone.
Guardò dietro la porta a vetri: stava ancora nevicando, ma la bufera era cessata. La strada era deserta. Il termometro segnava cinque gradi sotto zero.
La felpa nera con il cappuccio e i pantaloni cargo verde militare li aveva buttati sulla sedia la sera prima: li indossò, insieme agli anfibi tattici in goretex.
I membri della Squadra mobile lavorano in borghese.
Felpe, pantaloni cargo e anfibi erano la sua divisa.
Poi si infilò un giubbotto nero, guanti e un cappello di lana dello stesso colore. Da ultimo ...