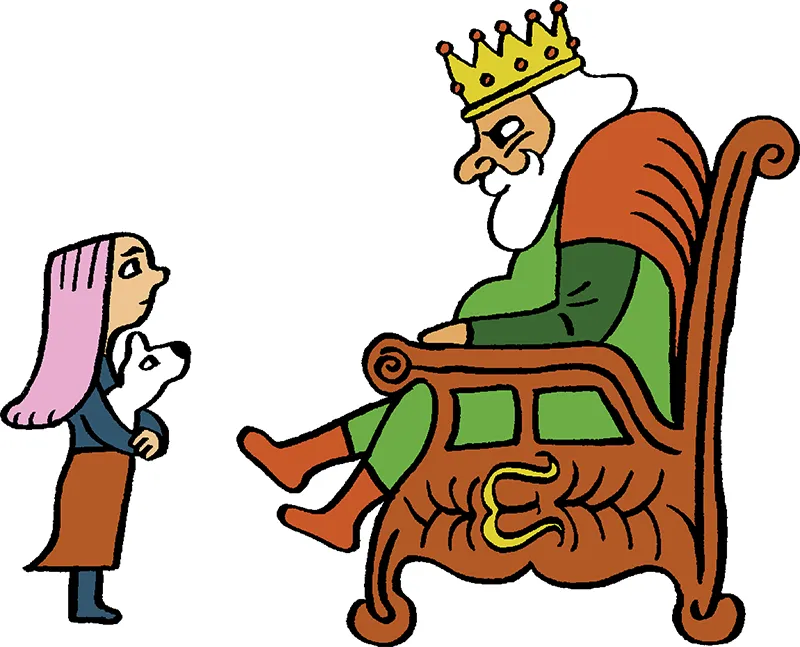Ti dicono che è andato tutto benissimo. Che non c’è niente di cui preoccuparsi. Eppure lì rimani, in una stanza d’ospedale, tra un letto, una sedia di plastica scomoda e altre persone nella tua stessa situazione. Nelle orecchie solo il pigolare di macchinari il cui funzionamento non ti è ancora chiaro e voci, urla, pianti e incitamenti di uomini e di donne il cui funzionamento ti è ancora meno chiaro.
Fermo. Immobile. Con davanti agli occhi una manciata di chili assemblati di braccia, gambe, nasi, orecchie e organi vari chiamati con approssimazione «bambino» a cui sai già che dovrai dare la tua completa dedizione. A partire da subito. Da quando quegli occhi si aprono, devi abdicare a ogni legittimo sospetto e abbracciare senza remore la pratica dell’atto di fede. Ti devi fidare che sia andato tutto bene. Ti devi fidare che non ci sia nulla di cui preoccuparsi. Ti devi fidare che sia tutto normale. E ti devi fidare molto perché – diamine – in un neonato nulla è normale: non è normale come si muove, come dorme, come mangia, se mangia, come riempie il pannolino. Non è normale il colore della sua pelle, non è normale il colore degli occhi, la forma della testa, le dimensioni delle braccia. Non è normale come piange. Non è normale nemmeno come respira.
Tu chiedi se è tutto normale e loro ti rispondono che è un bel bambino. Che è carino. Ma tu non vuoi avere un giudizio estetico. Vuoi che qualcuno ti rassicuri così come hanno fatto fino a pochi istanti prima che nascesse. Vorresti che qualcuno ti dicesse che va tutto bene, che è tutto normale. E che continuasse a dirtelo, di sua spontanea volontà, durante quella notte che passi tra un letto, una sedia di plastica scomoda e altre persone nella tua stessa situazione a fissare un esserino che ha tutta la parvenza di non riuscire a vivere senza il tuo aiuto.
Vorresti che te lo ripetessero allo sfinimento, che va tutto bene. Che è tutto normale. Perché ai tuoi occhi tutto normale non è. E hai la bruciante impressione che non lo sarà mai più.
C’era una volta, a ovest di Asti e a nord dell’India, il piccolo ma significativo regno del Giampà. Come ogni regno, anche il regno del Giampà aveva un re che, nel momento in cui state leggendo questa storia, si chiamava Evaristo ed era diventato re da poco. Il precedente sovrano, che guarda caso era anche suo padre, aveva deciso di andare in pensione prima del previsto per dedicarsi alla pesca senza esca, senza amo e ‒ perché no? ‒ spesso anche senza canna, lasciando a Evaristo il trono.
«Se ho qualche dubbio, posso chiamarti?» aveva chiesto Evaristo al padre.
«Sul lago il telefono non prende» aveva risposto quello, caricando la sua sdraio multicolore a cui era molto affezionato nel bagagliaio della station wagon marrone.
«Allora io come faccio?» aveva incalzato Evaristo con una voce tra il pietoso e il piagnucolante.
«Ti farai consigliare da qualche consigliere. Il regno è pieno di esperti» aveva risposto secco il re, facendo un ampio gesto con la mano per indicare tutto il circondario.
«E come faccio a scegliere l’esperto giusto?» aveva allora chiesto Evaristo.
Ma il re era già partito, sollevando un gran polverone tutto in giro e più di qualche dubbio nella testa del figlio.
Ora, non dovete pensare che Evaristo fosse un re di quelli che non hanno voglia di fare nulla: era, al contrario, estremamente pieno di idee e di progetti per il suo regno. Solo che dalla sua non aveva nient’altro che del buon senso e della buona volontà: due doti eccellenti (e quanto mai rare) che fanno di una persona «una brava persona» e di un governante «solamente una brava persona». Il che non è un problema in sé, ma in un Paese lo può diventare.
Appena asceso al trono, Evaristo aveva preso varie iniziative personali che, a detta sua e sulla carta, avrebbero dovuto avere straordinari effetti sulla popolazione ma che, alla fin fine, si erano rivelate dei fiaschi colossali. Aveva abolito le tasse, trovandosi senza soldi per pagare maestre d’asilo, spazzini, professori, medici ai quali la felicità di non pagare le imposte non bastava a dimenticare gli stipendi che non arrivavano. Aveva deciso di regalare a tutti i cittadini un sacco di patate al mese per dar loro qualcosa da mangiare, mandando su tutte le furie i produttori di patate che non riuscivano più a vendere quello che coltivavano. Aveva provato con il pane, ottenendo la stessa reazione dai panettieri, e con la pastasciutta, creando un’insurrezione dei coltivatori di grano. Alla fine si risolse, nel pieno della vergogna, a farsi consigliare da alcuni governi dei Paesi limitrofi, arrivando infine a distribuire, ogni mese, un sacco di promesse che, come tutte le promesse, lasciavano le pance vuote e le orecchie piene, creando quel tipo di illusione sensoriale che rende superflue molte esigenze. Compresa quella di essere davvero felici.
Assai demoralizzato da questo percorso individuale così poco brillante, Evaristo decise quindi di giocare l’ultima carta a sua disposizione, dando vita a qualcosa che fosse universalmente riconosciuta come un’opera buona: decise di creare una biblioteca.
Non doveva essere una biblioteca qualunque, però. Doveva essere il vanto dell’intero regno del Giampà e l’invidia di tutti gli altri. Doveva, nelle idee di Evaristo, non solo contenere le migliori edizioni dei più celebri capolavori della migliore letteratura internazionale, ma doveva essere anche di una perfezione architettonica plateale. Evaristo voleva che la sua biblioteca fosse uno di quegli edifici che le persone si fermano a guardare con le mani dietro la schiena, chiedendosi prima con stupore come è stato realizzato e poi con ammirazione chi lo ha realizzato.
Per il progetto della biblioteca, Evaristo aveva deciso di indire un grande concorso tra tutti gli architetti del regno del Giampà. Ognuno avrebbe proposto la sua idea e la migliore sarebbe diventata la Grande Biblioteca Evaristica.
«Le piace Evaristica?» chiese Evaristo a uno dei funzionari del regno.
«Moltissimo, maestà» disse il funzionario.
«Mi dici così perché è bello davvero o perché sono il re?»
«Mi scusi, maestà. Credo che mi stiano chiamando» gli rispose quello e si dileguò, lasciando il sovrano con un dubbio enorme e con centinaia di idee da vagliare.
Evaristo passò intere settimane guardando, ponderando, valutando: da tutta la mole di progetti che erano pervenuti ne scelse cinquanta. Poi venti. Poi dieci. Poi cinque. Poi uno solo che arrotolò sotto il braccio e portò con sé in un ristorante fuori mano. Giunto lì, ordinò il risotto al sugo rosso (che gli piaceva molto) e, mentre aspettava di essere servito, srotolò il progetto per studiarselo ancora qualche minuto. Quando il piatto arrivò con il suo carico fumante, chiese al cameriere che lo aveva servito se gli sembrasse buono.
«Il risotto?» chiese stupito il cameriere.
«Ma no, il progetto! Secondo lei è il migliore che potessi scegliere?» chiese Evaristo.
«Non saprei, dipende da come erano gli altri» disse il cameriere che, con un leggero inchino, si congedò.
Quando il cameriere tornò per prendere l’ordinazione del secondo, Evaristo gli chiese: «Ma così, a pelle, le sembra un buon progetto?»
«Non saprei. Non sono un architetto. Come contorno patate al forno o cicorietta ripassata?»
Evaristo ordinò patate al forno, ma non era del tutto convinto né delle patate, che si rivelarono bruciacchiate, né della sua scelta architettonica. O meglio, era sicurissimo di ciò che aveva scelto, ma non sapeva se ciò che aveva scelto fosse davvero il progetto migliore.
Si ricordò delle parole del padre e chiamò un esperto. Non ci volle molto per trovarne uno, così come non ci volle molto affinché l’esperto gli confermasse che il progetto era davvero buono. Ne chiamò un altro, giusto per essere sicuri, e il nuovo esperto riconfermò il parere del precedente esperto. Visto che il padre gli aveva sempre detto che due pareri van bene, ma tre sono una certezza, chiese a un terzo, che certificò il giudizio degli altri due.
Evaristo si decise allora a iniziare i lavori. Ma in lui qualcosa continuava a bruciare, prima lentamente, come una fiammella, poi come un incendio che divampò quando, a lavori iniziati, il capocantiere gli sottopose un problema che necessitava di una variante in corso d’opera. A causa di uno strano avvallamento del terreno, si sarebbe dovuta spostare una scala. Evaristo chiese all’architetto che aveva fatto il progetto cosa fare, il quale suggerì uno spostamento a destra della scala
«Ma sarà altrettanto bellissima come prima?» chiese Evaristo.
«Certo» disse l’architetto.
«Certamente» affermò il primo esperto per validare l’affermazione dell’architetto.
«Non saprei, diciamo che è una soluzione come un’altra» aggiunse il secondo esperto chiamato a certificare il parere del primo esperto che doveva validare l’affermazione dell’architetto.
Il terzo esperto non venne nemmeno convocato.
Evaristo convocò d’urgenza l’architetto per chiedergli un’altra soluzione che fosse più folgorante, più imponente, più incredibile, ma soprattutto che convincesse tutti gli esperti.
L’architetto fece un nuovo progetto per la scala. Seguì altro giro di consultazioni. Questa volta tutti furono concordi che la nuova soluzione era la migliore possibile. Ma Evaristo non ne era ancora del tutto convinto. E non fu convinto di molte altre cose. Ogni volta che c’era una piccola modifica da approvare, ogni volta che c’era una decisione da prendere, ogni volta che una piccola crepa appariva sull’intonaco appena steso, ogni volta che una piastrella veniva posata, Evaristo attivava un giro di consultazioni cercando esperti in lungo e in largo. E più esperti contattava, più i suoi dubbi aumentavano.
«Le viti satinate vanno bene?»
«Le sedie in stile impero vanno bene?»
«Le lampadine a luce calda vanno bene?»
«Le maniglie in ottone vanno bene?»
Tanti erano i dubbi e tanto era il tempo che gli operai passavano fermi in cantiere in attesa che il re approvasse questo e quello. Ma il re non era più sicuro di niente anche se, al contempo, voleva essere davvero sicuro di tutto.
«Le finestre con i doppi vetri vanno bene?»
«L’intonaco a vista va bene?»
«Il pavimento in larice rosso va bene?»
«Le tende in panno vanno bene?»
«Lo schedario elettronico va bene?»
***
Erano passati ormai cinque anni da che la prima pietra era stata posata e la Grande Biblioteca non aveva ancora un tetto, né alcun libro aveva ancora trovato rifugio tra le sue mura. In compenso, le domande a cui Evaristo doveva dare risposta si erano andate ad assommare e assommare e ormai il re viveva chiuso nel suo castello, circondato da migliaia di fogli e da migliaia di esperti.
Un bel giorno di agosto accadde che una signorina straniera dai capelli rosa e con in braccio un cagnetto bianco dalla faccia simpatica passò davanti al cantiere aperto. Vedendo gli operai fermi, sudati per il caldo, annoiati e con le facce aspre di chi ha bevuto qualcosa di sgradevole, chiese che cosa stessero facendo. Gli uomini le spiegarono per sommi capi la questione. La signorina dai capelli rosa chiese allora quali fossero le domande che tenevano il cantiere bloccato. Gli operai risposero in maniera polifonica e scoordinata, riportando solo alcune delle domande che ancora necessitavano di una risposta.
«Le sedie ergonomiche nere vanno bene?»
«Il capitello romanico delle sei colonne va bene?»
«Il marmo delle sei colonne va bene?»
«E le colonne? Le colonne vanno bene?»
La signorina dai capelli rosa ascoltò le domande, poi rimase in silenzio qualche secondo, guardò negli occhi il cagnetto e, dopo aver sospirato profondamente, partì a passo spedito verso la casa del re.
Si fece annunciare come una nuova esperta, la più esperta tra tutti gli esperti, ricevendo immediatamente l’accesso diretto alla sala di consultazione del sovrano.
Evaristo la attendeva davanti alla platea di tutti i consiglieri. Era stanco, un po’ gobbo e con due profonde occhiaie scure. Senza nemmeno lasciarle il tempo di presentarsi, chiese: «Allora, lei che è l’esperta tra gli esperti, mi dica cosa va bene e cosa no di questo mio progetto…»
Esattamente otto minuti e venticinque secondi dopo il suo ingresso nel castello del re, la signorina dai capelli rosa uscì con il cagnetto in braccio.
Dodici minuti e qua...