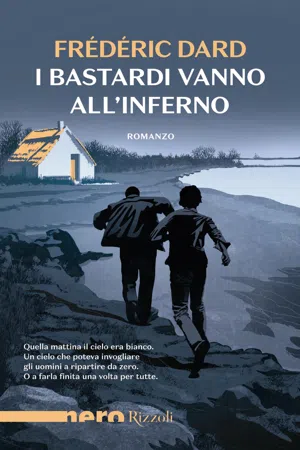Il corridoio era a forma di T.
Sui due lati, le porte delle celle si succedevano con disperante regolarità. Guardandole una in fila all’altra, le sbarre finivano per confondere la vista.
L’ambiente era male illuminato da un lucernario posizionato molto in alto, oscurato dalle inferriate e dal muro di fronte.
Si udirono rumori di passi, amplificati dall’eco del corridoio. Da tutte le celle sbucarono delle mani aggrappate alle sbarre. E tra le mani, dei volti emaciati. Era strano, perché l’ombra nascondeva il resto del corpo e i prigionieri assomigliavano a teste di angeli malefici inchiodate su un fondale notturno, con i pugni al posto delle ali.
Apparve il corteo. Erano in quattro. Martin, il secondino zoppo, procedeva leggermente in disparte rispetto al gruppo, facendo tintinnare le chiavi. I due nuovi arrivati camminavano davanti, ammanettati insieme, come una coppia di buoi. E il Fetente chiudeva la marcia, con un dolce sorriso stampato in faccia, nascosto da un fiore che masticava in continuazione.
Passando davanti agli altri prigionieri intenti a osservare la scena, si divertiva a dare dei colpi di manganello sui pugni stretti attorno alle sbarre. Il tutto senza smettere di sorridere e senza mai perdere la sua aria da Lord Mayor.
Giunti in fondo al corridoio principale, svoltarono nel troncone laterale, dove Martin aprì una porta e si scostò per lasciare entrare i nuovi arrivati. I due penetrarono nella cella, il primo tenendo la mano ammanettata dietro la schiena per non intralciare il compagno.
Martin richiuse la porta. Un rumore quasi doloroso, il rumore della libertà che va in pezzi.
I due rimasero immobili, sempre come una coppia di buoi, immobili e tristi, a guardare in fondo alla segreta dove sedeva un terzo detenuto. Non si erano ancora abituati alla penombra, lo distinguevano appena.
«Giratevi!» biascicò il Fetente.
Rassegnati, si voltarono lentamente, facendo attenzione a non impigliarsi nella catena.
Da dietro le sbarre, il capo secondino sembrava più grasso. Solo la divisa riusciva a contenere quel corpo voluminoso e flaccido, un po’ ripugnante. Sembrava un ammasso di interiora.
«Le mani!»
I nuovi arrivati alzarono il polso ammanettato. Il Fetente infilò le manone gonfie e lisce attraverso le sbarre e aprì le manette.
«Vi levo i gioielli» annunciò. «Se fosse per me, ve li lascerei… La gente come voi ha un’aria più distinta con un braccialetto.»
Si lasciò andare a una grassa risata.
«Ma il regolamento è il regolamento» sospirò.
Rimase un istante a osservare i due detenuti. Avevano il volto coperto di ecchimosi. Quello di destra teneva un occhio semichiuso perché aveva un taglio sull’arcata sopraccigliare. Quello di sinistra aveva il labbro superiore spaccato.
Il Fetente continuava a masticare il fiore. Dal ventre gli uscì una sorta di risata interiore che lo fece sussultare.
«Be’, ragazzi, ve le hanno date di santa ragione!»
I due continuavano a non muoversi. Erano come insensibili, inebetiti, con le larghe spalle incurvate.
«Potete strofinarvi i polsi» li avvisò cortesemente il Fetente.
E siccome i nuovi arrivati non seguivano il suo consiglio, il capo secondino aggiunse: «Non vi preoccupate, lo fanno tutti».
Fece uno sguardo cattivo. Ovvero i suoi occhi si fecero più sporgenti, un po’ più bianchi, un po’ più fissi.
I due rimasero immobili.
«Come preferite, bastardi…»
Martin si allontanò lentamente lungo il corridoio. A una a una, le mani dei prigionieri lasciarono le sbarre e i loro volti pallidi svanirono nell’ombra.
«Bene, devo comunque avvertirvi di due cose» disse il capo secondino. «Due cose importanti, che vi saranno utili. La prima: mi chiamo Duroc, ma non c’è bisogno di ricordarselo perché qui tutti mi chiamano il Fetente… e tra non molto capirete perché!»
Si abbandonò di nuovo alla sua risata viscida.
«La seconda: non mi piacciono le teste dure… O meglio, sono io che non piaccio a loro. Quando vedo arrivare dei tipi come voi, con la faccia già malridotta, è più forte di me!»
All’improvviso, infilò l’intero braccio nella cella e riuscì nella difficile impresa di schiaffeggiarli tutti e due, uno di diritto, l’altro di rovescio… Probabilmente erano anni che perfezionava quel numero, perché il gesto fu incredibilmente rapido.
«È più forte di me» ripeté con una vocina sottile, comicamente in contrasto con la sua stazza. «Come quando un cane vede un albero e gli viene subito voglia di pisciare. A me di alzare le mani… Capite?»
Siccome i due galeotti non rispondevano, urlò: «Avete capito?».
«Per quanto mi riguarda, ci sento perfettamente» mormorò il più basso dei due.
«Anch’io» fece l’altro. «Di questo, non posso lamentarmi!»
Il Fetente sputò il fiore nella cella. Poi, con gesto disgustoso, si passò la punta della lingua sulle grosse labbra fameliche.
«Avete l’aria sveglia, voi due. Bene, staremo a vedere! Staremo a vedere…»
Stava per andarsene, ma si fermò.
«Un’ultima cosa: il tizio laggiù in fondo è sordomuto… Un sordomuto che ha ucciso la moglie. Spero che andrete d’accordo. Nel caso in cui non dovesse funzionare, devo avvertire tutti e tre che la direzione non ama le risse.»
Li guardò a lungo, uno dopo l’altro.
«Buona giornata.»
Girò i tacchi e si allontanò fischiettando.
Quando il Fetente se ne fu andato, i due nuovi arrivati rimasero in piedi per un po’, uno accanto all’altro, senza guardarsi in faccia. Poi scattò qualcosa. Il tempo che passava su di loro senza sfiorarli all’improvviso li strappò al loro stupore di prigionieri, trascinandoli nella sua corsa vuota. Per la prima volta si scrutarono. E lo fecero con ferocia, come due animali che si fronteggiano. Alla fine uno dei due – quello con l’occhio tumefatto – alzò le spalle e si mise a esaminare la cella. C’erano tre tavole di legno, con sopra un pagliericcio e una coperta. Il Muto occupava quella in fondo.
L’uomo con il labbro spaccato indicò con un cenno del capo i due giacigli vuoti.
«L’unica libertà che ci resta» ridacchiò «è quella di sceglierci il letto. Ha preferenze?»
L’altro si lasciò cadere sulla branda più vicina.
«Non siamo in treno» sospirò. «Qui, il senso di marcia…»
Allungò le gambe e incrociò le braccia dietro la testa.
«Mi chiamo Frank» aggiunse dopo un attimo. «Frank qualcosa, non ha più importanza. Il cognome l’ho lasciato all’ingresso… sul registro. Il bello di questo posto è che puoi fare a meno dello stato civile…»
Il compagno si coricò di pancia sull’ultima branda rimasta. Stese le braccia lungo il corpo e rimase con la faccia sprofondata nel pagliericcio maleodorante. Puzzava di grasso e sporcizia. Era un odore acre e persistente, ma non così sgradevole quando ci si abituava… Il problema era abituarsi.
«Io sono Hal» disse infine, con voce sorda, appena percepibile.
«Puoi darmi del tu» aggiunse. «Prima o poi ci arriveremo comunque, quindi tanto vale cominciare fin da subito.»
«Grazie. Naturalmente, vale lo stesso per te» rispose Frank.
Il Muto non aveva battuto ciglio. Era rannicchiato sul letto, e contemplava i suoi nuovi compagni di cella con sguardo rassegnato. Era un omino magro e giallo, con i capelli grigi, un grosso naso aquilino e delle sopracciglia spesse e folte.
Hal si mise lentamente sui gomiti e strizzò l’occhio al Muto. Si sentiva vuoto come un corpo morto.
«Insomma» disse ad alta voce, «oggi siamo un po’ così, ma da domani ci faremo l’abitudine.»
Frank ebbe un sussulto: «L’abitudine a cosa?».
Il compagno fece un vago gesto della mano.
«Ma… a tutto! Alla prigione, al resto… Io mi abituerò a te, tu a me… Nella vita tutto si sistema!»
«Mi stupirebbe…»
«Cosa, ti stupirebbe? Di abituarti a me?»
«Sì» disse con cattiveria Frank. «E anche che nella vita tutto si sistemi! Certi giorni ha una faccia che te la raccomando…»
Indicò il Muto.
«Toh, guardala lì che faccia ha la tua vita, razza di imbecille.»
Invece di offendersi, Hal sorrise. Il Muto si sforzava di capire di cosa stessero parlando, perché era chiaro che lo avevano tirato in mezzo. Ma i nuovi arrivati lo disorientavano, non erano ...