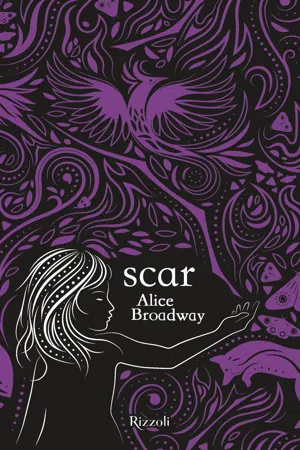All’alba è Mel a svegliarmi. Dall’aspetto sembra essersi vestita in tutta fretta.
«Ti hanno mandato a chiamare» mi dice.
«Così presto?» Mi strofino gli occhi, soffocando uno sbadiglio.
Mel annuisce. «Facciamo una colazione veloce, poi andiamo.»
Speravo che avremmo attraversato il museo e la piazza, in modo da cogliere almeno un barlume di sole, ma invece passiamo dalla porta in fondo al corridoio e percorriamo il passaggio sotterraneo che arriva fino alla prigione. Mentre camminiamo nel freddo tunnel penso al Santo e alla statua che si erge da qualche parte sopra di noi e immagino di essere schiacciata dai suoi pesanti piedi bronzei. Gli eroi della mia infanzia ora incombono su di me come figure da incubo e di incubi, ormai, me ne intendo.
Jack Minnow ci aspetta all’ingresso della prigione. Sia la postura sia la sua espressione comunicano tranquillità, sicurezza, arroganza.
Cosa stavi facendo ieri notte?, penso. Lui non dice una parola e si limita ad aprire la porta e farci strada.
È chiaro che oggi dovrò visitare la prigione.
Le guardie ci fanno entrare attraverso pesanti porte chiuse a chiave e a ogni nuovo corridoio aumenta la sensazione che ci stiamo allontanando dalla luce e dalla speranza. Alla fine raggiungiamo le celle. Sono buie e simili a caverne. Non consentono nessuna privacy, sono solo spazi tetri separati da sbarre. Alcune racchiudono due o tre persone. Nessuno ci guarda negli occhi mentre passiamo.
È un luogo da cui trasuda l’abbandono di ogni speranza: tutto questo potenziale, tutte queste vite sono segregati qui e lasciati a marcire. In fondo al corridoio ci sono altre porte che si aprono su stanze private, forse riservate agli interrogatori. L’ultima cella con le sbarre è più buia delle altre. In quest’angolo d’inferno non possono esistere né luce né colori.
Jack Minnow si ferma e fissa lo sguardo all’interno della cella.
«Non ti starai nascondendo, spero, tatuatore» lo deride. «Vieni avanti e fatti vedere.» Intuisco un movimento strascicato nel buio, seguito da un gemito. Obel. Si avvicina strisciando, gli occhi stretti per proteggersi dalla debole luce.
Obel è come un angelo a cui hanno strappato le piume. Ha i capelli lunghi, sporchi e arruffati; puzza, e ha le labbra secche e screpolate. Le braccia che mostravano tutto il proprio vigore quando tenevano l’apparecchio per tatuare ora sono scarne e grigiastre. Tutto quanto è grigio.
Ogni colore lucido e splendente, ogni parola, ogni forma e immagine sono appassiti come un fiore colto e lasciato morire lentamente. Tutti i suoi marchi stanno sbiadendo e gli spazi vuoti si stanno allargando come un incendio in una foresta.
Quando osservo più da vicino la mano con la quale sapeva creare mondi, quella spezzata dalla rabbia di Minnow, vedo che le fratture alle dita non sono mai state ricomposte e che la contusione è ormai diventata un gonfiore permanente. La cicatrice rossa e bluastra sembra voler mostrare tutta la rabbia e il furore che l’hanno causata. I suoi nuovi marchi non sono tatuaggi ma lividi dalle sfumature più diverse.
Obel, il mio Obel, è stato distrutto, e la sua pelle racconta tutta la storia.
Mi piego sulle ginocchia e allungo una mano attraverso le sbarre. Lui si lascia toccare.
«Saresti dovuta fuggire via.» Ha la voce rauca, non so dire se per la sete o per le grida. Sembra frastornato, confuso e piccolo. Dà l’impressione che qualcosa dentro di lui sia stato rimpiazzato da un bambino la cui anima non si adatta al confine delimitato dal suo corpo.
«Sono al sicuro» gli sussurro vicino all’orecchio; non so dire se è vero ma ha bisogno di un po’ di speranza. «E ti aiuterò.» Un’altra promessa che non ho modo di mantenere. Ma non gli posso dire la verità, non posso dirgli che sono impotente quanto lui.
Obel cerca di mettersi in piedi, tirandosi su. È debole. Mi costringo a guardarlo ancora, per vedere bene quanto è cambiato. È l’ombra dell’uomo che era prima. Con un brivido di paura mi dico che non posso permettere che Gull subisca lo stesso trattamento. Mi guardo attorno, come se potessi trovare una via di fuga o un modo per cambiare le cose, ma ovviamente non vedo altro che sbarre e porte chiuse.
Poi, in una cella lì accanto, intravedo Connor Drew, il padre di Oscar. Non l’avevo più visto dal giorno in cui fu marchiato pubblicamente con un corvo. Mi sembra che siano trascorsi anni, eppure era solo lo scorso autunno. Fu la vista della sua marchiatura a riportare a galla il lontano ricordo di mio padre con quell’identico marchio da dimenticato. I nostri sguardi si incontrano e lui mi fa un cenno. Ricordo che Oscar mi disse che suo padre gli aveva raccontato di me: era lui che aveva cercato di aiutare mio padre, trafugando e nascondendo il suo marchio dopo la sua morte.
Un rumore di passi interrompe il nostro contatto visivo, e un uomo vestito di nero si avvicina.
Jack Minnow mi guarda. «Non ti ho portata qui solo per una commovente rimpatriata. C’è un lavoro che va fatto.» Sembra che vedere Obel così debole riempia lui di vita. Risplende letteralmente in quest’oscurità. Un parassita che si nutre dell’infelicità altrui.
Obel ha lo sguardo fisso e rivolto al suo, sbatte appena le palpebre. Ogni respiro sembra spremere energia fuori dal suo corpo. Anche nella penombra vedo gli occhi di Minnow brillare di piacere nell’osservare come ha ridotto quest’uomo.
«Ho bisogno che tu lo renda presentabile.» Minnow si volta e mi rivolge un sorriso subdolo. «Dagli una ripulita e ridipingigli quei marchi. Non m’importa come ci riesci, fallo e basta. Hai tre giorni.» Guardo Obel, confusa, poi torno a voltarmi verso Minnow, che sorride. «Forza tatuatrice, mostraci quanto sei brava.»
E con queste parole se ne va. Mi accorgo che anche Mel è sbalordita e che lo fissa con il volto pieno di confusione. Qualche momento più tardi arriva una guardia della prigione con del cibo, buon cibo, non la sbobba della prigione.
«Ritornerò a fine giornata» mi dice Mel. Sembra che voglia dirmi qualcosa di più, forse persino che voglia restare, ma poi scuote la testa e se ne va. La guardia apre la porta della cella e io entro, sperando di riuscire a preparare Obel in tempo. In tempo per che cosa, non ne ho idea.
Chiedo dell’acqua calda, teli puliti e oli, e lavo la pelle di Obel.
Pelle. È diventato un tema ricorrente nella mia vita.
Ho strofinato olio sulle deboli braccia di papà agonizzante, facendo splendere i tatuaggi che gli ricoprivano la pelle raggrinzita dalla malattia.
Ricordo la sensazione della mano di Oscar al nostro primo incontro, le sue dita che mi tenevano stretta, mi portavano con lui, lontano dalle domande del personale del museo. Ricordo quando abbiamo bevuto insieme in quella piccola caffetteria dai vetri appannati dal caldo, cercando di capire quanto di noi potevamo rivelare l’uno all’altra.
Basta. Non pensare a lui.
Ricordo il primo marchio che ho fatto sotto l’occhio vigile di Obel. Amavo il ticchettio e il ronzio dell’apparecchio che avevo in pugno mentre con la mano sinistra tenevo ferma la pelle di quella donna pallida e con la destra la tatuavo. Una foglia per un bambino. Un marchio proibito per una vita perduta. Obel che mi coinvolgeva volontariamente nella sua rete di ribelli, sperando che l’avrei aiutato a tessere qualcosa di meraviglioso.
Ricordo frammenti di ceramica che mi attraversavano la mano e il sangue nell’acqua dei piatti.
Le vesciche sulla pelle di Gull, che aveva tentato di tatuarsi con acqua e cenere.
La mano forte di Karl che mi tirava verso di sé mentre litigavamo, le sue dita che affondavano nella mia spalla mentre scivolavo e cadevo.
L’odore di lavanda sulla pelle mentre mamma mi faceva il bagno, da piccola.
I miei marchi che si sviluppavano da soli, mostrandomi la mia storia prima ancora che io capissi quale sarebbe stata.
Penso a queste cose mentre lavoro, così non devo pensare a Obel. Mi prendo cura di lui come se fosse un cliente dello studio, un estraneo. È come quando papà era ammalato: l’avevamo perduto a poco a poco, vedendolo sbiadire finché non ci era rimasto che una traccia diluita di lui, il ricordo di un aroma.
Ma non è la stessa situazione: Obel non sta morendo. Per due lunghi giorni ripulisco la sua pelle dal lerciume e lo nutro con pane e acqua, sorsi di birra e fette di mela. Una volta eliminata la sporcizia mi sembra di vederlo riemergere. La schiena riacquista forza, i denti affondano nella mela e il succo gli cola sul mento. Le spalle si raddrizzano, gli occhi si fanno più limpidi e con un sospiro lo sento sussurrare il mio nome. Sorrido. Che te ne pare di questa resurrezione, Longsight?
Le guardie mi portano del balsamo per la sua pelle piagata, tronchesine per le unghie e abiti puliti.
Il secondo giorno gli domando perché è ancora qui, cos’hanno in programma per lui.
«Non lo so» mormora. «Non ne ho idea.»
A queste parole Connor Drew scoppia in un’aspra risata nella sua cella scura come l’inchiostro. «Non fare il finto tonto, Obel» lo provoca. «Perché Longsight dovrebbe tenere un tatuatore sotto chiave? Un tatuatore che è totalmente sotto il suo controllo, che può essere costretto a fare qualunque cosa gli si chieda?»
Si fa avanti e si appoggia alle sbarre. Sotto la barba lunga e gli strati di sudiciume nei suoi lineamenti rivedo Oscar. Distolgo lo sguardo.
«Che cosa vuole Longsight, allora?» chiedo a entrambi, provando a mantenere un tono cortese e sforzandomi di nascondere la paura. «Perché ti vuole pulito e marchiato di fresco? Obel… che sta succedendo?»
Obel si limita a fissare Connor con astio.
«Non è ancora finita. Sei un combattente» mormoro, e gli strofino del balsamo sulla mano destra. Le ossa si sono aggiustate in malo modo, lasciandogli le dita deboli e bloccate. Gli chiedo di muoverle, di stringermi la mano, e lui gira la testa da un’altra parte. Le sue dita tremano mentre prova a fare il pugno. I polpastrelli non arrivano neppure a sfiorargli il palmo.
«Le dobbiamo risistemare» gli dico. Trattarlo in modo così materno è strano e mi fa pensare a sua madre, Tanya, a Featherstone, e a come le spezzerebbe il cuore vederlo in questo stato. Ha perso sia Obel che Gull.
Mi domando dove sia lei e spero che sia viva. Deve esserlo, Longsight aveva detto che era al sicuro.
In caso contrario la colpa sarebbe solo mia.
Più tardi quello stesso giorno prendo le forbici e inizio a tagliargli i capelli. Quando ho incontrato Obel per la prima volta aveva i capelli rasati, poi li ha lasciati crescere e li portava raccolti e ordinati. Adesso sono una massa disordinata e arruffata.
So che non sto facendo un gran lavoro – sono troppo corti sulle orecchie e irregolari sopra gli occhi – ma continuo a tagliare, eliminando i grovigli.
«Vuole che io ti marchi» dico a Obel. «Che ti dipinga com’eri prima. Perché?»
«Perché vuole una marchiatura pubblica.» Per lo shock quasi lascio cadere le forbici, ma Obel solleva una mano. «Non su di me: vuole che io faccia una marchiatura. Non so su chi, con cosa o perché. “Un insegnamento nuovo” ha detto. Aspetta, ha detto… Ha detto che “eliminerà il dolore delle persone”.» Scrolla le spalle. «Farò quello che vuole.»
«Obel» lo rimprovero. Odio il ton...