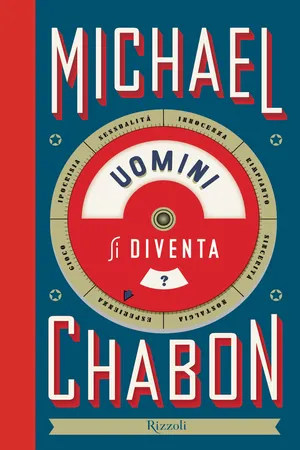Stavo leggendo, su un numero di «Discover», dell’Orologio del lungo presente. Ne avete mai sentito parlare? Sarà un sistema di giganteschi computer meccanici, lenti, semplici e ingegnosi, che segnerà l’ora, il giorno, l’anno, il secolo, il millennio e la precessione degli equinozi, collegato a un enorme planetario meccanico in grado di seguire l’immenso ticchettio dei sei pianeti interni lungo la loro grande orbita a molla. L’Orologio del lungo presente sarà alto almeno diciotto metri e costerà decine di milioni di dollari e, una volta completato, progettatori e finanziatori – tra i quali il visionario ingegnere Danny Hillis, un pioniere del concetto di elaborazione a elevato parallelismo, il mahatma del Whole Earth Catalog, Stewart Brand, e il compositore inglese Brian Eno (una delle mie divinità personali) – intendono nasconderlo in una grotta del Great Basin National Park, nel Nevada, raggiungibile da qualunque direzione soltanto con una dura scarpinata di almeno un giorno. Ah, e funzionerà per diecimila anni. Grossomodo l’arco di tempo che ci separa dai primi produttori di utensili in terracotta, tra i più antichi esempi di tecnologia a noi pervenuti. Diecimila anni vuol dire il doppio di quelli della piramide di Cheope e quasi il doppio di quelli del corpo mummificato preservato dai ghiacci delle alpi tirolesi, una delle mummie più antiche mai ritrovate. L’Orologio del lungo presente è progettato per continuare a funzionare, grazie a regolare manutenzione umana, per tutto quel tempo, anche se, durante i periodi in cui non ci sarà nessuno a occuparsene, troverà il modo di procedere da solo. Ma anche qualora non dovesse durare così tanto, anche se si rompesse dopo metà o un quarto o un decimo del tempo previsto, il folle marchingegno avrebbe già ampiamente assolto al suo dovere. È possibile anzi che l’Orologio realizzi il suo obiettivo principale prima ancora di essere ultimato o addirittura senza nemmeno essere costruito. Scopo dell’Orologio del lungo presente non è quello di misurare il passaggio della razza di creature che l’ha concepito verso un futuro ignoto. Il suo scopo è riportare in vita e rafforzare l’idea stessa del Futuro, farci ricominciare a pensare al Futuro con la stessa intensità di un tempo, se non nello stesso modo, e reintrodurre l’idea che il futuro non sia soltanto qualcosa che lasciamo in eredità (benché questo sia vero, che ci si soffermi a rifletterci o meno). Il futuro è anche qualcosa che noi, nel senso più ampio del pronome di prima persona plurale, ereditiamo.
A rigor di termini, avevano ragione i Sex Pistols: non c’è futuro, né per voi, né per me. Il futuro, per definizione, non esiste. «Il Futuro», con o senza lettera maiuscola, è sempre e soltanto un’idea, un’ipotesi, uno scenario possibile, l’abbozzo di un congegno folle che potrebbe funzionare oppure no. Il Futuro è una storia che raccontiamo, una narrazione fatta di speranza, paura o meraviglia. Ed è una storia che nelle nostre vite manca da parecchio tempo.
Diecimila anni da oggi: siete in grado di immaginare quel giorno? Okay, ma lo fate? Pensate davvero che il Futuro arriverà?
Se l’Orologio funziona come deve – se resiste per tutto quel tempo – credete che ci sarà un essere umano ad assistere alla sua fine o addirittura a piangerla? Qualcuno che riconosca la portata dell’impresa, la precisione del congegno, la sua immensa antichità? E fra cinquemila anni? O anche solo cinquecento? Riuscite ad ampliare l’orizzonte delle vostre previsioni sul mondo, sul nostro complesso di civiltà e culture, oltre l’arco della vita dei vostri figli o delle due o tre generazioni successive?
Mi ha sorpreso, leggendo dell’Orologio del lungo presente, constatare da quanto tempo non dedicassi il minimo pensiero a come sarà il mondo tra diecimila anni. In passato era un luogo immaginario che la mia mente bazzicava spesso. E non solo frequentando regolarmente il Futuro nelle pagine dei romanzi o dei fumetti di fantascienza o guardando un telefilm come I Pronipoti (1962) o un film come L’altra faccia del pianeta delle scimmie (1970). La storia del futuro mi veniva raccontata, quand’ero ragazzo, non soltanto dall’arte e dai media popolari, ma anche dall’architettura pubblica e domestica, dal design industriale, dai libri scolastici, dai parchi giochi a tema, e da istituzioni come musei ed enti statali. Percepivo la storia del Futuro osservando il profilo da navetta spaziale della Studebaker Avanti, i fornelli senza fiamma Jenn Air, il paesaggio di Tomorrowland dagli oblò della monorotaia di Disneyland o le tesserine di plastica che ruotavano dentro l’orologio a lettura rapida Seth Thomas di mio padre. Ricordo che una volta, in prima media, feci una ricerca sulle colture idroponiche; se allora qualcuno avesse cercato di convincermi che nel 2005 avremmo ancora coltivato la verdura nella terra, mi avrebbe spezzato il cuore.
Anche trent’anni dopo aver trovato la sua espressione più pura sulle copertine di riviste pulp come «Amazing Stories», ma soprattutto all’esposizione universale di New York del 1939, la narrazione culturale collettiva del Futuro rimaneva prevalentemente ottimistica, improntata agli imminenti benefici della tecnologia e alla filantropica meritocrazia computerizzata dei «fellows with compassion and vision», i «visionari compassionevoli» cantati da Donald Fagen. All’alba degli anni Settanta, però, il Futuro non era più soltanto fattorie subacquee e vacanze in famiglia su Titano. A volte poteva essere davvero deprimente. Ammesso che un olocausto nucleare non avesse spazzato via tutto quanto, l’umanità sarebbe stata schiava dei computer, in virtù degli ineluttabili sillogismi della «Macchina». L’infanzia mi dischiuse una serie di cupi pronostici, perfettamente esemplificati dalla trilogia hestoniana inauguratasi con il primo Pianeta delle scimmie (1968) e proseguita con 1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra (1971) e 2022: i sopravvissuti (1973). Le immagini di un futuro distopico abbondavano nei dischi rock dell’epoca, come Diamond Dogs di David Bowie (1974) e 2112 dei Rush (1976), e il futuro delineato da scrittori di fantascienza degli anni Settanta come John Brunner era implacabilmente o ironicamente desolato.
Nel complesso, le storie sul Futuro erano caratterizzate da un’affascinante ambiguità. Se il rovescio della medaglia del meraviglioso futuro dei Pronipoti poteva essere una storia di tirannia tecnologica esercitata sul mondo intero da multinazionali autoritarie, quello del mostruoso paesaggio mutazionale post-apocalittico evocato in 1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra era lo splendore semibarbarico e l’assoluta (per quanto pericolosa) libertà d’azione che trovai tra le pagine di un classico dell’avventura a fumetti come Kamandi: l’ultimo ragazzo sulla Terra di Jack Kirby (1972-76). Quell’ambiguità e il suo fascino, la tensione mutevole tra le luminose promesse e le minacce del Futuro, rappresentava di per sé una storia dei modi – ora bizzarri, ora tragici – in cui l’umanità (e, implicitamente, la cultura americana e i suoi valori, per quanto bizzarri e tragici) sarebbe sopravvissuta malgrado tutto. Oi pop stinitip, recitavano i successori degli yankee nell’episodio di Star Trek, «Le parole sacre» (1968); in qualche modo, erano riusciti a conservare e adorare come formula sacra il preambolo della Costituzione americana, erforaun ion ferfe, astablirgiu. Era sufficiente che arrivasse il capitano Kirk a versare un goccio d’acqua interpretativa sul documento liofilizzato dal tempo e lo stile di vita americano sarebbe rifiorito.
Non ho idea di che fine abbia fatto il Futuro. È come se avessimo perso la capacità o la volontà di immaginare qualsiasi cosa al di là del prossimo centinaio d’anni o giù di lì, come se fosse venuta a mancare la fiducia fondamentale nel fatto che, all’indomani di quel giorno non così distante, un futuro ci sia ancora. O forse abbiamo smesso di parlarne nel momento in cui, con i suoi microchip e i suoi notiziari ventiquattr’ore su ventiquattro, il futuro è arrivato. Ci sono giorni in cui apri il giornale e ti sembra scritto a sei mani da James G. Ballard, Isaac Asimov e Philip K. Dick. Riproduzione sessuale umana senza materiale genetico maschile, virus digitali, furti di identità, pompieri e minatori robot, controllo degli eventi climatici, ingegneria dell’umore farmaceutica, rapida estinzione delle specie, presidenti degli Stati Uniti comandati mediante scatolini installati tra le scapole, imperi ad aria condizionata nel deserto dell’Arabia, governo delle multinazionali, televisione-realtà: ci sono giorni in cui sembra che il futuro immaginato nella seconda metà del Ventesimo secolo fosse una specie di lista di cose da fare, e che da allora siamo stati troppo occupati a spuntarne le voci e a preoccuparci di ampliarla. Nel frattempo, quel poco che è rimasto da fare – colonizzazione interplanetaria, computer senzienti, semi-immortalità della coscienza mediante backup o trapianto del cervello, governo globale (fascista o illuminato) – è stato rappresentato e ri-rappresentato così tante volte nei film, nei romanzi e in televisione che ha finito per sembrarci, paradossalmente, già realizzato, già conosciuto, vissuto e superato. In altre parole: passato.
È questo il paradosso che sta alla base della nostra perdita di fiducia o di interesse riguardo al futuro, paradosso che a sua volta ha prodotto una collettiva incapacità culturale di immaginare quel Futuro, o un qualsiasi futuro, al di là di un paio di secoli o del vuoto di una catastrofe planetaria. Il futuro è stato tratteggiato così spesso e così a lungo, nei termini e nello stile di così tanti periodi storici, da Jules Verne in poi, che a un certo punto l’idea stessa di Futuro – insieme all’appetito culturale che la accompagnava – ha finito per apparire antiquata, fuori moda, non più praticabile né realizzabile. Uno dei punti di svolta, in questo senso, potrebbe essere stato Guerre Stellari (1977), ambientato com’è in un passato remoto, con i suoi duelli da Far West e le battaglie aeree da Prima guerra mondiale, i riferimenti voluti allo stile e alle convenzioni di Metropolis (1927) e ai vecchi telefilm di Flash Gordon. Dopo Guerre Stellari, tutti i Futuri cinematografici hanno attinto pesantemente ai Futuri immaginati in epoche storiche precedenti. Anche quella che, almeno negli Stati Uniti, è forse la narrazione del Futuro più seguita e culturalmente predominante – la visione cripto-cristiana della Fine presentata nei libri della serie «Left Behind» di Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins – deriva da un immaginario e da un bagaglio di storie preesistenti, che in alcuni casi hanno ormai quasi duemila anni.
Se chiedete a mio figlio maggiore che opinione abbia del Futuro, vi risponderà che il mondo è destinato a finire, punto. Novantanove su cento per il riscaldamento globale, dice – inondazioni, uragani, desertificazione – ma la sua visione dei giorni a venire non esclude nemmeno pandemie virali, caduta di meteoriti o un qualche scambio nucleare. Magari non domani, né fra un anno. Il ragazzo è perfettamente in grado di prodursi in uno slancio ottimistico verso la settimana prossima, le prossime vacanze, il suo prossimo compleanno. È sul mondo tra cent’anni che non nutre la minima speranza. Mio figlio sembra considerare la fine di tutto, di ogni sforzo e risultato umano, come un fatto scontato. Ha la sensazione di vivere nell’ultima pagina, se non nell’ultimo paragrafo, di un lungo, strano e sconcertante libro. Se alla sua età qualcuno mi avesse detto che un ragazzino del futuro si sarebbe sentito così – non solo, che per certi versi avrebbe considerato la nostra estinzione giusta, e la scomparsa degli esseri umani una fortuna per il mondo – sarebbe stato anche peggio che sentirmi dire che il mondo non avrebbe mai prodotto megafattorie idroponiche, colonie umane su Marte, zainetti volanti per tutti. Quello sì che mi avrebbe davvero spezzato il cuore.
Quando ho raccontato a mio figlio dell’Orologio del lungo presente, lui mi ha ascoltato con attenzione, e poi siamo andati a vedere le foto sul sito Internet della Long Now Foundation. «Ma la gente esisterà ancora, papà?» mi ha chiesto. «Sì» gli ho risposto senza esitazioni. «Certo che esisterà.» Non so se sia vero, non più di Danny Hillis e dei suoi colleghi, con i ticchettanti orologi delle loro speranze e i planetari della loro fantasia. Ma scegliendo di avere dei figli – generandoli, amandoli, insegnando loro ad amare il mondo e ad averne cura – i genitori scommettono, consapevolmente o meno, sull’Orologio del lungo presente. Scommettono sui loro figli, e sui figli dei loro figli, e su tutti quelli che verranno dopo di loro, di qui al Centotrentesimo secolo. Se non credi nel Futuro, senza riserve e con lo spirito di un sognatore, se non sei disposto a scommettere sul fatto che qualcuno verserà una lacrima quando, infine, tra diecimila anni, l’Orologio smetterà di funzionare, allora non vedo come tu possa avere dei figli. Se hai dei figli, non vedo come tu possa non fare tutto quanto è in tuo potere per assicurarti di vincere la scommessa, e che loro e i loro nipoti e i nipoti dei loro nipoti ereditino un mondo la cui perfezione non potrà mai essere raggiunta da creature la cui capacità di immaginare perfezionamenti è sconfinata e libera. E non vedo come chicchessia possa costringermi a pagare la scommessa qualora, alla fin fine, dovessi perderla.
Ho incontrato David Foster Wallace una sola volta, alla University of California, Los Angeles, nell’ottobre del 2004, quando partecipammo, insieme ad altri scrittori, a una raccolta fondi per la campagna elettorale di John Kerry. Dubito che scambiammo più di ventinove parole, nessuna delle quali memorabile, almeno per me. Mi sembrò timido e a disagio nel contesto: il grande retropalco della Royce Hall, un sacco di persone che andavano e venivano, Cheney che dibatteva con Edwards dentro un televisore in un angolo, e Wallace da solo, che si preparava a uscire sul palco e a sostenere, perlomeno con la sua presenza fisica, davanti a un pubblico piuttosto numeroso, il ticket destinato alla sconfitta. Nel mio ricordo indossa l’immancabile e sempre improbabile bandana, ma è un’immagine che potrebbe essere stata influenzata da troppe foto ufficiali. Ebbi l’impressione che a turbarlo fosse la natura dell’evento e il fatto di prendervi parte. Non che non desiderasse la sconfitta di Bush. Sembrava semplicemente insospettito da tutta la faccenda – un’elezione presidenziale nel Ventunesimo secolo – e dal ruolo che in essa lui avrebbe svolto. Con me e con mia moglie fu di una gentilezza e di un’educazione esemplari, ma devo ammettere che mi intimidiva. Se avevi letto la sua formidabile opera, e soprattutto Infinite Jest (che per ben due volte non ero riuscito a finire), allora era davvero difficile, almeno per il sottoscritto, non pensare che Wallace sarebbe stato capace di sfruttare le tue risorse, trovare cose da dire su di te e spiegare la persona che eri, più di quanto fino a quel momento fosse riuscito a te. Ebbi la sensazione di averlo deluso, o che fosse deluso dal fatto che era evidente quanto mi importasse ciò che pensava di me. Sentii, nei due minuti in compagnia di David Foster Wallace a me assegnati dal destino, di avere in qualche modo tradito le sue aspettative. Di certo, quando quella sera come da programma salì sul palco dopo di me, per leggere un racconto (mi pare, o comunque un brano, che parlava di uno strano bambino e della sua brutta festa di compleanno), la prima cosa che disse al microfono fu più o meno: «Ah, fantastico: un altro bianco con gli occhiali». Forse era deluso da entrambi.
Posso dunque affermare che io David Foster Wallace non lo conoscevo. Lo consideravo un mio collega, dal quale però mi separavano varie distanze coestensive: di spazio, estetica, temperamento. I suoi saggi mi procuravano un piacere intenso e non avrei esitato a definire la sua opera fondamentale, se non tra le più importanti del nostro tempo. Ma da alcuni giorni la sua morte occupa il centro dei miei pensieri, come se, in un mondo più felice, avessi avuto la possibilità di conoscerlo come amico. Continuo a ripensare a lui in quell’ultimo istante, giorno, anno della sua vita, cercando di capire e di vedere, e di immaginare, impresa terribile, la serie finita di pensieri che l’ha portato a togliersi la vita.
Il mio primo impulso è quello di affermare che il suicidio è un’idea estranea al mio modo di pensare. Immagino che dipenda in gran parte dal caso e dal semplice fatto di essere nato così. Finora, toccando ferro, non ho mai sofferto così tanto, né sono sprofondato così in basso, da desiderare che la mia vita, la mia preziosa vita, avesse fine. Nei momenti peggiori, nelle ore più cupe e vulnerabili, più vicine alla perdizione, ho sempre trovato il conforto di una voce calma che dentro di me sussurrava: niente, nemmeno il dolore più insopportabile, dura per sempre. Possiedo quello stupido ottimismo che è per un quarto inesorabile e per metà insensato: un tratto pericoloso, e spesso a suo modo fatale. Eppure l’immagine del suicidio riempie il mio lavoro dal primo all’ultimo libro. L’autoreclusione, la negazione di sé e la speranza, illusoria o reale, di fuga dal dolore della vita rappresentano un filone tematico centrale nelle Fantastiche avventure di Kavalier e Clay. La trama del Sindacato dei poliziotti yiddish ruota interamente intorno al mistero di una persona che sceglie di togliersi la vita. Uno dei protagonisti di Gentlemen of the Road sfugge quasi con regolarità al suicidio, solo grazie alla sua pipa di semi di cannabis e alle attente cure del suo migliore amico, mentre il Grady Tripp di Wonder Boys non è mai riuscito a separarsi dall’ombra dello scrittore horror August Van Zorn, morto suicida. È un tema sul quale torno in continuazione, con una frequenza che, a questo punto, considerata la mia presunta estraneità all’atto del suicidio, risulta difficile da spiegare.
Mia moglie soffre di disturbo bipolare, cosa che talvolta le procura una sofferenza e una disperazione tali da proiettare una luce accattivante sulla prospettiva dell’oblio. Quando entra in crisi, io me la immagino come un bambino che si raggomitola su se stesso davanti a uno specchio a tre ante, come quelli nei camerini dei negozi di abbigliamento, con il passato e il futuro che si perdono in lontananza, in un’infinita e confusa prospettiva di giorni identici, e la testa che puntualmente ostacola la visuale. All’inizio del 2005, mia moglie pubblicò sul blog che aveva all’epoca un post in cui, con calma e metodo, descriveva la natura del disturbo bipolare II, i problemi e i benefici imprevisti che comportava. Nel post citava due volte una statistica secondo cui, tra le persone affette da disturbo bipolare II, una su quattro finiva per uccidersi.
Quel giorno mi trovavo a Little Rock, Arkansas, abbastanza depresso a mia volta, (senza offesa per Little Rock) perché il cielo era grigio e faceva freddo, e perché George W. Bush era ancora, e sembrava dovesse rimanere per sempre, presidente degli Stati Uniti, e perché ero da solo a Little Rock (scusami, Little Rock) e lontano da casa. Ero andato a visitare la biblioteca presidenziale Clinton, allora appena inaugurata, dov’erano esposte due mappe elettorali in cui si vedevano le ampie aree blu che avevano scelto Bill Clinton nel 1992 e nel 1996, una vista che mi aveva riempito di meraviglia e di sconforto. Dopodiché, ero tornato nella mia triste camera d’albergo sotto la pioggia. Il mondo era soltanto cielo grigio e pareti rivestite di cartone pressato, e la mappa di Tutto sarebbe sempre stata rossa, rossa, rossa. Avevo provato a telefonare a casa, ma non c’era nessuno. Quindi, come se, così facendo, potessi stabilire un contatto con lei, mi ero collegato a Internet ed ero andato sul blog di mia moglie.
Quello che lessi mi sconvolse e mi fece preoccupare. La chiamai sul cellulare, e lei rispose, ma stava facendo sette cose contemporaneamente, guidava la macchina mentre asciugava il naso a qualcuno mentre si precipitava a un appuntamento mentre parlava con me. Sembrava in forma; teneva duro, faceva quel che c’era da fare, se la cavava anche in mia assenza. Terminai la telefonata con la sensazione di aver avuto una reazione eccessiva al suo post. Mi convinsi che, essendo anch’io un po’ giù di morale, avevo letto tra le righe, immaginato i segnali del suicidio o che, se anche quei segnali c’erano, era impossibile che lei li avesse percepiti sul serio. La sua tendenza a estremizzare gli stati emotivi ...