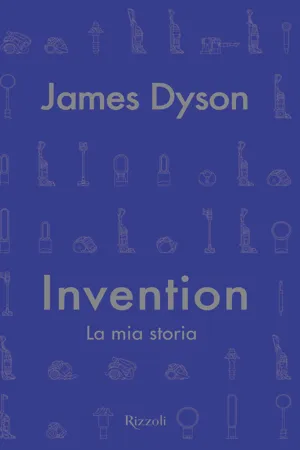Ci sono momenti – lunghi momenti – in cui il mare, il cielo e la sabbia delle spiagge del Norfolk settentrionale si fondono fino a formare un orizzonte apparentemente infinito. E di mattina, quando la marea si abbassa e il terreno sotto i tuoi piedi riflette il cielo sconfinato come uno specchio gigantesco, si ha la sensazione di muoversi in uno spazio etereo, privo di confini o limiti visibili.
La prima cosa in cui scoprii di essere bravo, una cosa che avevo imparato da adolescente, era la corsa di resistenza. Una volta superata la barriera del dolore, scoprii di avere la determinazione, o la semplice cocciutaggine, necessaria per continuare a correre. La corsa, di prima mattina o a tarda sera, in quel paesaggio dalla bellezza incantevole, si rivelò più di una sfida rituale. Era una fuga dalla scuola, accompagnata dall’illusione che tutto fosse possibile.
Non che avessi le idee particolarmente chiare. Quando lasciai la scuola a diciotto anni, il preside Logie Bruce-Lockhart scrisse a mia madre: «Ci dispiacerà separarci da James. Non riesco a credere che non sia dotato di molta intelligenza e prevedo che, in qualche modo, la farà emergere altrove». A me scrisse invece: «L’aspetto dello studio, anche se dobbiamo fingere che sia importante, conta relativamente poco. Te la caverai molto meglio se non avrai mucchi di noiosi diplomi pieni di conoscenze teoriche che ti pendono dal collo. Buona fortuna alla scuola d’arte». All’epoca apprezzai la doppia negazione nella lettera a mia madre e sperai di riuscire a far emergere qualcosa ma, come lui, non avevo idea di dove sarebbe potuto succedere. Riflettendoci in seguito, pensai quanto fosse confortante che un preside non esitasse a dire che la vita non ruotava solo intorno ai risultati scolastici.
Bruce-Lockhart, un uomo gentile, vivace e spiritoso, era un paladino dell’individualità. Un vero campagnolo che amava la musica, gli uccelli e la pittura ad acquerello, aveva conquistato cinque vittorie nella Scottish International Rugby Union e prestato servizio nella Household Cavalry quando, nel bel mezzo dei combattimenti, la sua autoblindo si era addentrata in territorio tedesco nei giorni più duri della Seconda guerra mondiale. Sarebbe diventato un amico fedele. Lo vidi per l’ultima volta poco prima che morisse nel 2020.
La scuola era la Gresham’s a Holt, una graziosa cittadina del Norfolk – remota e, in quel periodo, ancora in gran parte priva di automobili – dove mio padre era direttore del dipartimento di Studi classici. Fondata durante il regno di Maria la Sanguinaria, aveva istruito numerosi giovani uomini molto peculiari e anticonvenzionali – specialmente tra i due conflitti mondiali –, che poi avevano conosciuto sia la fama sia il disonore. Tra loro figuravano i poeti W.H. Auden e Stephen Spender, il compositore Benjamin Britten, l’artista Ben Nicholson e suo fratello Christopher – un eccellente architetto che morì in un incidente di volo a vela nel 1948 –, e la famigerata spia Donald Maclean. Aveva frequentato la Gresham’s anche Lord Reith, il fondatore della Bbc.
Tra gli studenti della scuola si annoverano diversi illustri ingegneri e inventori, tra cui Sir Martin Wood – che sviluppò i magneti superconduttori utilizzati nell’mri (Magnetic Resonance Imaging, «tomografia a risonanza magnetica»), uno strumento fondamentale negli ospedali e nei laboratori odierni – e Sir Christopher Cockerell, l’inventore dell’hovercraft. Poi c’è Leslie Bayens, l’ingegnere aeronautico che sviluppò l’aereo a motore meno potente del mondo, il leggero Carden-Baynes Auxiliary del 1935.
Negli anni Sessanta, quando ero adolescente, avevo tuttavia rallentato il ritmo dei miei studi. Non che fossi pigro. Anzi, mi tuffai in quasi qualunque attività extrascolastica. Sport di ogni tipo. E anche la musica. A nove anni avevo deciso di suonare il fagotto perché non l’avevo mai sentito nominare, perché era diverso e perché prometteva una nuova sfida. Poi ci fu il teatro, in cui mi cimentai sia come attore sia come scenografo, anche se la mia idea per i volantini del nostro spettacolo, Il critico di Sheridan, non ricevette una buona accoglienza. Li avevo prodotti sotto forma di rotoli di pergamena anziché di fogli piegati, per evocare lo spirito – o almeno così credevo – del tardo Settecento. «I tuoi volantini fanno pena, Dyson» disse il direttore. «I volantini dovrebbero essere piatti.» Punto e basta. Il mio ultimo dramma scolastico fu La tempesta, in cui interpretai Trinculo accanto al Calibano di Tim Ewart, il futuro conduttore di News at Ten su Itn.
A scuola, l’arte non era una materia tenuta in grande considerazione. All’ultimo anno delle superiori, un consulente di orientamento professionale – un ex funzionario della Raf con i baffi a manubrio – mi suggerì, dato il mio amore per i vasti spazi aperti, di riflettere sull’eventualità di diventare agente immobiliare. «O forse» dissi io «chirurgo.» Feci visita a un agente immobiliare a Cambridge, che mi consigliò di fare l’artista. Sostenni anche un colloquio al St George’s Hospital a Hyde Park Corner, prima del suo trasferimento a Tooting, dove mi fecero capire che forse sarei stato più soddisfatto se avessi intrapreso la carriera… artistica.
Benché l’idea di diventare chirurgo avesse un fascino innegabile, seppure fugace, il mio unico grande amore, a parte la corsa di resistenza, era l’arte. Dipingevo seriamente, o almeno così credevo, da quando avevo otto o nove anni. Ciò che desideravo davvero era frequentare la scuola d’arte. Fin dall’incontro con il consulente alla Gresham’s mi guardo bene dal dare o dall’accettare consigli, che possono anche essere dettati dalle migliori intenzioni, ma spesso sono sbagliati. L’incoraggiamento è un altro paio di maniche. A mio parere, se il suggerimento è in armonia con l’istinto, allora potrebbe essere valido. Più che altro dovrebbe essere una riconferma.
L’arte, tuttavia, non era il percorso di studi o lo stile di vita che i miei insegnanti avevano immaginato per me. Dato che mio padre Alec era un professore di materie classiche, mio fratello maggiore Tom studiava materie umanistiche a Cambridge e mia sorella maggiore Shanie stava ottenendo risultati universitari altrettanto brillanti, pareva che la mia carriera scolastica fosse a dir poco già scritta. Inoltre ero bravo in latino e adoravo il greco e la storia antica. Però ero il terzogenito e, come molti terzogeniti, avevo sentito fin dall’inizio il bisogno di dare prova di me stesso andando per la mia strada.
Entrai alla Gresham’s quando avevo solo otto anni. Dal 1946 avevamo affittato una casa vittoriana accanto alla scuola, piena di spifferi e gelida in inverno. Mio padre, un borsista di Cambridge che aveva insegnato in Kenya e combattuto in Abissinia, era tornato dal servizio militare in Birmania con il reggimento Northants nella XIV armata di Bill Slim, o armata «dimenticata». Era il 1946, e lui ci aveva rimesso i denti e i capelli. La guerra in Birmania era stata estremamente feroce e il papà – menzionato due volte nei dispacci – si era ritrovato nel bel mezzo dei combattimenti a Imphal e nelle giungle zeppe di cecchini. Aveva combattuto al fianco delle truppe indiane, africane, cinesi e americane, nonché di milizie delle tribù shan, chin, kachin, karen e naga. I britannici, con alleati e truppe provenienti da molte parti del mondo oltre all’Europa, rappresentavano una minoranza tra coloro che avevano sconfitto i giapponesi in Birmania e sulle colline di Naga.
Ricordo mio padre come un uomo eclettico e sempre allegro. Guidò il corpo cadetti della scuola con il grado di maggiore, fece l’allenatore di hockey e di rugby, e mi insegnò ad andare in barca a vela sui Norfolk Broads. Mi svegliava la mattina presto per approfittare della marea sigiziale a Morston. Lo fece anche dopo una notte di tempesta nel 1954, quando l’acqua aveva allagato le piane di marea, le paludi e le valli del Norfolk settentrionale. Non era solo questione di salire in auto e precipitarsi a recuperare la barca. La nostra macchina, una vecchia Standard 12 con motore Jaguar, richiedeva infatti un avvio a manovella durante il quale subiva un violento contraccolpo, e si guastava spesso. Fu sicuramente un’avventura.
Mio padre suonava il flauto tenore in un gruppo, produceva drammi scolastici – ho ancora le sue note a margine in alcuni volumi in miniatura di Shakespeare – e amava sia gettare il piombo fuso per creare soldatini sia lavorare il legno nel suo laboratorio. Scrisse un libro per bambini sull’India, intitolato The Prince and the Magic Carpet, illustrandolo con incantevoli acquerelli. Per fortuna, i miei nipoti ascoltano estasiati quando glielo leggo e ripetono in coro le parole magiche per far volare il tappeto. Mio padre era in grado di inventare poesiole spontanee ed evocative. Nel suo necrologio, un membro del personale sottolineò quanto tutti apprezzassero «il suo senso dell’umorismo, che spesso sconfinava nel rabelaisiano». Era un fotografo amatoriale che sviluppava le proprie stampe, raccogliendole in preziosi album. Era sempre impegnato in attività che ci coinvolgessero, come dar da mangiare ai polli, farci sporgere dai predellini dell’auto o truccare gli attori della Gresham’s School.
Quando conobbe mia madre Mary, lei aveva solo diciassette anni. Suo padre era un uomo leggermente distaccato, il parroco di Fowlmere, nel Cambridgeshire, e sua madre era una donna dalle forti inclinazioni artistiche, capace di dipingere acquerelli meravigliosi. Il mio nonno paterno era un illustre direttore scolastico in pensione che viveva con la nonna nella vicina Thriplow. I miei genitori si conobbero a un evento sociale e si sposarono in tutta fretta nel 1941, durante la guerra. La luna di miele fu breve. Mio padre, naturalmente, era nell’esercito. Avendo dovuto rinunciare all’università dopo aver frequentato la Perse School a Cambridge – non so come i suoi genitori abbiano potuto permettersela –, mia madre si arruolò volontaria nella Waaf (Women’s Auxiliary Air Force). Mappava le posizioni degli aerei in una vasta regione dell’Europa da Tangmere, nel West Sussex. Questa base della Raf, un importante campo d’aviazione strategico dalla battaglia d’Inghilterra in poi, diventò popolare grazie ai film di guerra in cui Winston Churchill guardava giù da un balcone verso la mappa sottostante.
Mia sorella Alexandra («Shanie») nacque nel 1942 e mio fratello Tom nel 1944. Erano figli della guerra. Io venni al mondo nel 1947. A casa nostra, nel Norfolk in tempo di pace, non c’era la tv, il riscaldamento non era mai sufficiente, non avevamo giocattoli nuovi e, semmai, c’erano pochissimi beni di consumo. I soldi bastavano appena per sopravvivere. Eravamo nell’era dell’austerità e, fino al mio settimo anno di vita, anche delle tessere annonarie. Coltivavamo le verdure e raccoglievamo le uova delle nostre galline. A volte andavamo a Holt a vedere un film al Regal. Da bambini, tuttavia, avevamo qualcosa di ancora più divertente e davvero inestimabile: l’accesso libero, per l’intera durata delle vacanze, al parco della Gresham’s, ai suoi campi da gioco e da tennis e alla piscina. Quella scuola, si dice, ha più ettari che studenti. Inoltre le sconfinate spiagge del Norfolk, spesso deserte, non erano molto lontane.
La grande casa vittoriana era divisa tra tre famiglie. Noi bambini formavamo una specie di tribù sul modello della Banda dei cinque, del Club dei sette e di Swallows and Amazons, ed eravamo tutti figli di insegnanti della Gresham’s. Io ero il più piccolo e dunque, credo, avevo qualcosa da dimostrare. Ero anche il più mingherlino della mia tribù e della mia classe. Crebbi tutto d’un colpo quando avevo quindici anni. Da ragazzini, mentre correvamo qua e là per la Gresham’s, facevamo tutte le cose che oggi verrebbero disapprovate o addirittura proibite perché considerate troppo rischiose. Costruivamo tunnel pericolanti, ci arrampicavamo su alberi altissimi e, il più delle volte, eravamo sudici, trafelati e coperti di graffi. Creavamo i tunnel scavando ciascuno la propria tana e poi collegandole con fossi disseminati di ceppi o travi e sormontati da pezzi di lamiera ondulata. Fu un’interessante palestra di costruzioni e, per quanto possa sembrare sorprendente, nessuno rimase sepolto vivo. Erano giorni davvero idilliaci.
Nel 1955, quando avevo otto anni, stavamo rientrando da Polzeath, in Cornovaglia, di ritorno da una vacanza sulla spiaggia che fino a quel momento avrei ricordato soprattutto per le fastidiose vesciche che mi erano comparse sul fondoschiena. Ci fermammo per un picnic a Dartmoor. Mi incamminai da solo lungo un sentiero per esplorare il felceto. Girando un angolo, vidi mio padre vomitare convulsamente. Prima che potessi parlare, ordinò: «Non dirlo alla mamma». Era tipico di lui non voler allarmare gli altri. Provai immenso amore e compassione mentre raggiungevamo il resto della famiglia.
Il papà morì nel 1956, quando io avevo nove anni e lui quaranta. Ne aveva trenta quando era rientrato dalla Birmania. Tre anni dopo gli avevano diagnosticato un cancro alla gola e ai polmoni. Faceva lezione a scuola parlando con un megafono. Jim Wilson, un ex alunno, scrisse nell’«Old Greshamian Magazine» del 2016 che «ripensandoci, si riconosce prontamente il suo coraggio nel continuare a insegnare usando un microfono e due casse per amplificare la voce. A quei tempi eravamo forse in grado di apprezzare la temerarietà e la determinazione che ciò doveva richiedere?».
Mio padre passò gli ultimi giorni al Westminster Hospital. Ci aveva detto addio stringendo una valigetta di cuoio mentre gli facevamo ciao dalla porta di servizio. Partì per la stazione di Holt e prese il treno per Londra. Fu l’ultima volta che lo vidi. La sua allegria coraggiosa mi fa venire un nodo alla gola ogni volta che ricordo quella scena. È impossibile immaginare le sue emozioni mentre ci salutava sapendo che forse stava andando incontro alla morte. Il momento fu ancora più tragico perché gli anni che aveva passato a combattere in Birmania erano stati un lunghissimo viaggio in mare lontano dalla sua giovane moglie e dalla famiglia.
Sessant’anni non sono riusciti a addolcire né questi ricordi né il rimpianto che il papà non abbia potuto vedere i suoi tre figli crescere e sposare persone meravigliose. Sarebbe stato felicissimo di giocare con i suoi sette nipoti. Tutto questo diventò ancora più straziante quando osservai uno dei miei nipoti, Mick, all’età che avevo io quando mio padre morì. Mick è affettuoso, intelligente e controllato, ma in quel periodo dormiva ancora con il suo arruffato cagnolino di peluche. Era troppo vulnerabile per perdere suo padre. Mi rendo conto di quanto mi sia mancato il mio mentre guardo Mick giocare a ping-pong con Ian, che è un papà creativo e amorevole.
Io, Tom e mia madre stavamo mangiando una zuppa di asparagi quando squillò il telefono quel giorno del 1956. Quando la mamma rispose, ebbi una premonizione inconsapevole. È sorprendente, perché non sapevo che il cancro fosse mortale. Temevamo per Shanie, che era in collegio. Come avrebbe fatto a metabolizzare la notizia da sola?
Avevo appena iniziato a frequentare la Gresham’s ed eccomi nella cappella della scuola qualche giorno dopo, con i pantaloni corti e le ginocchia bitorzolute, per il servizio funebre di mio padre. Per ragioni che non riesco a capire, invece di sedermi con la mia famiglia ero in una fila di sedie con tutti gli altri ragazzi – miei coetanei –, ignari del perché fossero stati trascinati a una funzione che, per quanto li riguardava, era una perdita di tempo. Fu un’esperienza traumatica. Mi sento ancora a disagio quando ci penso. Non volevano essere irrispettosi, ma si trattava di mio padre.
Soffrivo per la perdita devastante del papà, del suo affetto, del suo umorismo e delle cose che mi aveva insegnato. Temevo il futuro senza di lui. Siccome di recente ero entrato anch’io in convitto, lontano dalla mia famiglia, d’un tratto mi ritrovai solo. Evitai di piangere o di esternare le emozioni, limitandomi ad assumere un atteggiamento stoico. Da allora, una parte di me cerca di compensare quella separazione dolorosa e ingiusta dal papà e gli anni di vita che perse. Forse dovevo imparare rapidamente a prendere decisioni autonome, a fare affidamento su me stesso e a essere disposto a correre qualche rischio. Poche cose avrebbero potuto essere peggiori della morte di mio padre in quel momento.
Il generoso Logie Bruce-Lockhart e la sua gentilissima moglie Jo avevano fatto in modo che io e Tom potessimo accedere al convitto in cambio di una retta simbolica, permettendo così a mia madre di andare a lavorare. Fece prima la sarta e poi l’insegnante. In seguito, quando era già in età matura, scelse coraggiosamente di iscriversi a Cambridge per conseguire una laurea in inglese. Fu lei a crescermi dopo la morte di mio padre e a influenzare i miei studi infantili. I miei erano sposati da quindici anni, ma avevano vissuto insieme solo per tre anni prima che il papà si ammalasse. Ciò potrebbe spiegare la capacità della mamma di sopravvivere da sola mentre allevava tre figli e studiava per due titoli universitari.
Era alta un metro e settantasette. Non ricordo che abbia mai avuto difficoltà con la disciplina. Con me, tuttavia, era benevola, affettuosa e indulgente, sebbene non quando si trattava di soldi, perché non ne avevamo molti. La mamma era molto incoraggiante. Era un’avida lettrice, capace di reggere il confronto con i professori della Gresham’s, e parlava un francese impeccabile pur non essendo mai stata in Francia. Quando finalmente ci andò, ci portò con sé sulla sua Morris Minor. Mentre campeggiavamo in una tenda economica, mi mostrò, oltre a molti altri tesori, gli archi rampanti della cattedrale di Chartres, i tetti di tegole di Vézelay e i bellissimi e austeri monasteri cistercensi dell’abbazia di Le Thoronet. Ci accampammo vicino alla Dordogna e nuotammo nel fiume molto prima che quella zona della Francia diventasse colonia britannica.
Decisi a vivere bene con poco, a casa raccoglievamo il finocchio marino nelle paludi di Stiffkey e dissotterravamo noci di mare dalla sabbia. Andavamo alle prime delle opere di Benjamin Britten, che viveva nel Suffolk, e ai concerti diretti da lui. Mia madre metteva su gli lp di Kathleen Ferrier e Peter Pears. Leggevamo, giocavamo ai mimi e alle costruzioni. I soldatini di piombo, i modellini di aliante e gli aeroplanini a gasolio erano la mia specialità. Non giocavo con i soldatini né li collezionavo. Quello che mi piaceva era crearli, usando le attrezzature di mio padre per sciogliere il piombo in un crogiolo e per versare il pericoloso metallo fuso negli stampi.
Nel 1957, quando mia madre decise di seguire la sua vocazione, andò al Norwich Teacher Training College per un corso biennale, probabilmente con una borsa di studio. Insegnò alla Sheringham Secondary Modern prima che la Runton Hill, un’ottima scuola privata femminile, le offrisse un posto da insegnante e direttrice in un nuovo convitto. L’idea di farle visita in un collegio per sole ragazze non mi dispiaceva affatto.
Nel 1968, tre anni dopo la mia partenza per la scuola d’arte, la mamma decise di iscriversi a un corso di laurea al New Hall, a Cambridge. Essendosi sposata in tempo di guerra, doveva essersi pentita di non aver completato gli studi e di non aver avuto la possibilità di andare a Cambridge come avevano fatto mio padre e mio fratello. Nonostante ciò deve essere stato deprimente per lei sopravvivere grazie all’ennesima borsa di studio e alloggiare in seminterrati, come facevo io a Londra. Pur essendo malata ed essendo stata ricoverata prima e durante gli esami finali, si laureò con il massimo dei voti. Quindi insegnò inglese alla Fakenham Grammar School per cinque anni felici, dedicandosi anche alla produzione di drammi teatrali. Per un’amara ironia del destino, nel 1978 ricevette una diagnosi di cancro al fegato e morì di lì a poco.
Ora mia moglie sostiene che ho ereditato la sua determinazione e il suo spirito guerriero. Mia madre aveva grandi aspettative. Era anche di vedute molto larghe e aveva un’eclettica cerchia di amici di tutte le età. Amando le conversazioni su qualunque argomen...