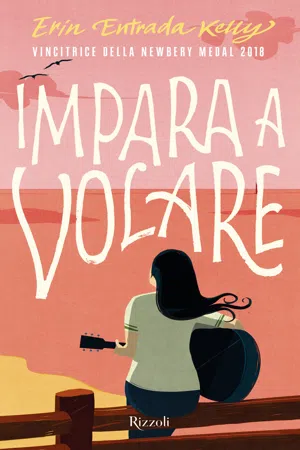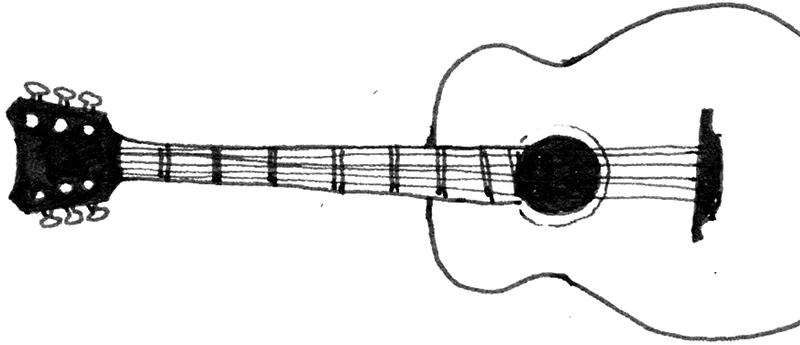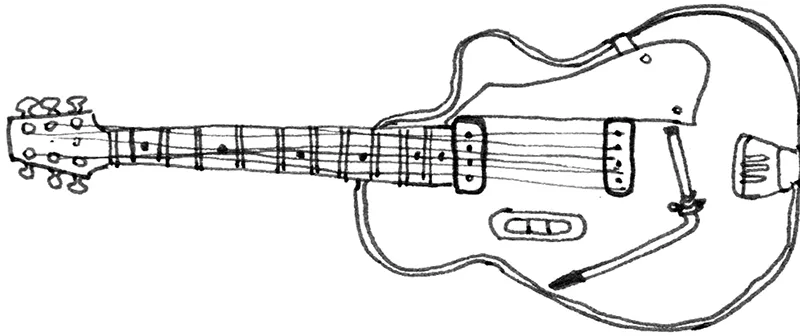AChapel Spring, in Louisiana, nevicò per la prima volta dopo vent’anni il giorno in cui ci trasferimmo in America. Mia madre disse che era il segno che una nuova stagione della nostra vita stava cominciando. Anche se avevo solo quattro anni, ricordo ancora che mi abbracciò forte e mi disse che ci aspettava qualcosa di meraviglioso: una vita da vere americane.
Quando si comincia una nuova vita bisogna eliminare tutto di quella vecchia – perlomeno secondo la mamma – perciò, il giorno in cui nevicò, mia madre non aveva niente che venisse dalle Filippine, tranne una Bibbia cattolica e una fotografia di sua nonna. Io avevo portato una vecchia cartolina e una cassetta dei Beatles. Abbey Road, per la precisione. Mio padre ci aveva scritto sopra il suo nome con il pennarello nero molto, molto tempo prima. H. Yengko. Alcune lettere si erano cancellate, ma a me il suo nome sembrava più chiaro che mai. Avevo preso la cassetta al volo prima che lasciassimo il nostro barangay, cioè il nostro quartiere, perché era l’unica cosa che mi stava in tasca.
Per tanto tempo non ho potuto ascoltare la cassetta perché non avevo un walkman, ma l’anno scorso ne ho trovato uno per dieci centesimi in un mercatino dell’usato e così finalmente l’ho sentita. Si vedeva che mio padre l’aveva ascoltata molto perché la cassetta era crepata e i nomi delle canzoni erano sbiaditi, ma ho capito subito perché l’ha consumata. Quando ascolti i Beatles per la prima volta non puoi più tornare indietro. Sono il migliore gruppo rock che sia mai esistito, secondo me. George Harrison è il mio Beatle preferito. Suonava soprattutto la chitarra solista, ma cantava anche e scriveva canzoni.
Se potessi fare una domanda a papà, gli chiederei chi era il suo preferito. Vorrei poter chiedere alla mamma se lo sa, ma a lei non piace quando parlo di mio padre, e ancora meno quando parlo di musica. Credo che la mamma sia l’unica persona al mondo che non ha una canzone preferita. La mia canzone preferita di sempre è “Blackbird” – dei Beatles, ovviamente – ma la mia seconda preferita per ora è “Sunshine Life for Me”, scritta da George e suonata dal mio terzo Beatle preferito, Ringo Starr.
Forse mia madre non ha una canzone preferita, ma ha delle storie preferite. Una riguarda il giorno in cui arrivammo in America. Il giorno in cui nevicava. Me l’ha raccontata la mattina della festa di Alyssa Tate, mentre girava il riso fritto all’aglio che sfrigolava in una pentola, e si sistemava il grembiule. Era quello bianco con su scritto MABUHAY FILIPPINE! in spessi caratteri rossi. Mi è sempre sembrato strano il fatto che prima non vedesse l’ora di diventare americana, ma quando siamo venute a vivere in America si è circondata di cose che venivano da casa. Abbiamo un Santo Niño nella vetrinetta, pancit e adobo di pollo in frigorifero e quel grembiule. Un grembiule stupido.
Quando racconta la storia del nostro arrivo qui dopo la morte di mio padre, non dice mai “dopo che tuo padre è morto”. Dice invece “dopo quello che è successo”.
Non erano caduti nemmeno tre centimetri di neve quando arrivammo a Chapel Spring quel giorno, ma il ghiaccio ci scricchiolava sotto i piedi mentre la migliore amica di mia madre, Lita, ci accompagnava alla nostra casa gialla con due camere da letto in Oak Park Drive. Visto che faceva freddo e c’era la neve per terra, chiesi se stava arrivando Babbo Natale.
«Te lo ricordi, Apple? Te lo ricordi?» Mia madre ha sorriso verso la pentola di riso. L’odore di aglio riempiva la casa.
Ho messo la lattuga nella mia ciotola ma non ho detto niente. Guardavo le sette carotine nell’insalata. Mia madre sa che non le mangio più, ma continua a rifilarmele comunque.
Ricordo il giorno di cui parlava. Ricordo che il cappotto nuovo mi pesava e la nuova casa aveva un odore strano. Ricordo di aver fatto la domanda su Babbo Natale, di aver avuto nostalgia dell’oceano, e di aver sentito Lita dirmi quant’ero fortunata.
Ho infilzato le carote una dopo l’altra con la forchetta e le ho messe da parte su un tovagliolo accanto al piatto. L’olio del condimento ha impregnato la carta ed è colato sul tavolo, perché mia madre compra i tovaglioli meno costosi. Compra sempre il meno costoso di tutto.
Ha dato un’occhiata al tovagliolo. «Credevo che le carote fossero il tuo cibo preferito.» Ha puntato il cucchiaio verso di me. «Le carote fanno bene agli occhi, lo sai.»
Facciamo lo stesso discorso sulle carote da cinque anni, ma mia madre e io siamo come su una giostra, quanto a discorsi. Non abbiamo più niente di nuovo da dirci, quindi parliamo sempre delle stesse cose, come per esempio del nostro primo giorno in America e del fatto che prima le carote erano il mio cibo preferito.
Quando ancora credevo nelle carote, Lita mi aveva raccontato di aver letto in una rivista la storia di una modella a cui era diventata la faccia arancione perché mangiava carote tutto il giorno. Allora mia madre mi aveva detto di stare attenta e di non mangiarne troppe.
«Prima mangiavi un sacco di carote» ha detto. «Pensavo che saresti diventata arancione.»
Ecco un segreto, però: le carote non sono mai state il mio cibo preferito. Odiavo sentirle crocchiare sotto i denti, e quel gusto non-proprio-dolce e non-proprio-amaro, ma ne mangiavo finché ero sazia perché quando avevo sette anni mia madre mi aveva detto che “facevano bene agli occhi”. Le mangiavo dal sacchetto, pensando che gli occhi mi sarebbero diventati azzurri, ma sono rimasti a mandorla e scuri, con le ciglia corte e spesse.
Ho guardato l’alone bagnato delle carote che si espandeva sul tovagliolo e ho sentito mia madre canticchiare canzoni d’amore filippine. È strano sentirla canticchiare perché non è affatto un tipo musicale. Non credo che se ne renda conto, altrimenti smetterebbe.
«Quando eravamo al centro commerciale ieri ho visto una chitarra che costava solo venti dollari» ho detto.
Ha smesso di canticchiare, la bocca… una riga dritta e tesa.
Ho infilzato un pezzo di cipolla e l’ho lasciato dondolare, poi cadere. «Hai detto che se ne trovavo una che costava poco potevo prenderla.»
Mia madre ha sospirato. «È appena cominciata la scuola. Devi concentrarti sullo studio.»
«Sono sempre una delle migliori.»
«Sei troppo grande per i giocattoli.»
«Come posso diventare la prossima George Harrison o John Lennon, se non ho una chitarra?»
«Basta così, anak.»
«Hai detto che potevo comprarla. L’hai detto all’inizio dell’estate. È quasi ottobre ormai.» Sentivo il petto caldo.
Ha spento la fiamma e ha dato un’ultima rimestata. «È pronto.»
«Non ho voglia di mangiare.»
«Ay, Apple» ha detto, scuotendo la testa. «Devi pranzare.»
Eccoci pronte per un nuovo giro di giostra. Ora mi avrebbe detto che avevo bisogno di mangiare perché lei era uno stuzzicadenti da bambina, e tutti i ragazzi l’avevano presa in giro finché non aveva messo su un po’ di peso. Poi avrebbe aggiunto che anche se non bisogna essere troppo magri, non si deve neppure essere troppo grassi. Occorre stare nel mezzo, come lei.
«Mi hai detto che potevo comprare una chitarra» ho borbottato in fretta.
Ha contratto la mascella come fa quando è irritata, ma non m’importava.
«Non voglio tornare sull’argomento, Apple. Abbiamo fatto questo discorso tante volte. Ne riparleremo più avanti.»
Lo diceva sempre, ma quel più avanti non arrivava mai. Lo faceva solo perché credeva che me ne dimenticassi, ma io non me ne sarei dimenticata. Una cantautrice famosa ha bisogno di una chitarra. È una necessità. George Harrison ne aveva una. Paul Simon, Norah Jones… tutti avevano una chitarra.
«Lo dici sempre» ho obiettato.
«Ay, sus» ha detto lei. «Attenta a come parli. Stai diventando troppo americana.»
Ho spinto indietro la sedia.
«Non ho fame» ho detto. «Vado a fare un giro in bici.»
«Con gli amici o da sola?»
Ho fatto finta di non sentire e sono andata dritta verso la porta sul retro, dove ho agguantato lo zaino del weekend che era in un angolo. Il mio zaino del weekend assomiglia a quello di scuola, ma anziché libri noiosi dentro ci sono un cambio di vestiti, il mio quaderno rosso e una bottiglia d’acqua. Prima ci mettevo anche Abbey Road, ma una volta per poco non mi sono dimenticata lo zaino sull’autobus, e se c’è un posto in cui non bisogna lasciare un bene prezioso è quello.
«È un peccato che non sei riuscita a farti nuove amicizie» ha gridato mia madre dalla cucina. «Non fa bene ai bambini andarsene sempre in giro da soli. Nelle Filippine nessun bambino giocava da solo.»
«Qui non siamo nelle Filippine» ho detto mentre uscivo.
Ho inforcato la bici con il sellino sbiadito e sono partita. La mia bicicletta fa abbastanza schifo e ogni tanto cade la catena. Quando succede, devo alzare la ruota dietro e rimetterla. È una rottura, ma ho un attrezzo apposta nello zaino. Non è d’aiuto che Oak Park sia pieno di marciapiedi dissestati. A volte canto tra me e schivo le crepe a ritmo di musica, perché così diventa più divertente.
Ben presto il sudore mi è colato sulla fronte e tra le scapole. Ci sono un mucchio di alberi lungo i cinque isolati che separano la mia via e quella di Alyssa Tate, perciò il sole non era così tremendo, ma quando ho svoltato a destra nella sua strada non ce n’erano più. Senza alberi è difficile nascondere la bici e cambiarsi la maglietta, ma in estate uso un gruppo di cespugli che si trovano a quattro case di distanza da quella dei Tate, perciò ho accostato lì, ho sistemato la bicicletta e mi sono accovacciata per togliermi la T-shirt sudata e metterne una pulita, che mi porto sempre dietro. Ho bevuto un sorso d’acqua, poi sono uscita dai cespugli lasciando la bicic...