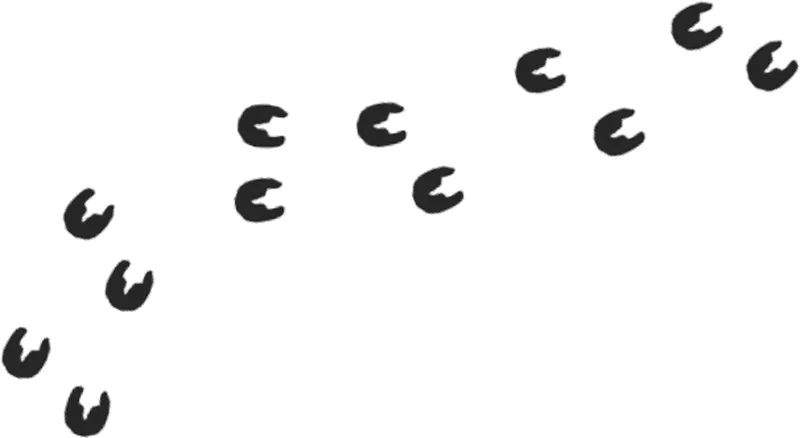È UNA DOMANDA CHE MI HANNO POSTO SPESSO quand’ero ragazzino.
Allora non avevo ancora pensato al fatto che da grande avrei dovuto fare necessariamente qualcosa. C’era qualcuno che da grande non faceva niente? Probabilmente c’era.
«Cosa vuoi fare da grande?»
«Niente.»
«Come niente?»
«Niente.» Sai che pacchia?
Comunque, visto che me lo domandavano così spesso, cominciai a immaginarmi mentre facevo qualcosa.
Mi piaceva lo spazio, mi affascinavano le stelle e i pianeti, e la possibilità che esistessero forme di vita extraterrestre. Così dissi che avrei voluto fare l’astronauta.
Poi, però, considerai che sarebbe stato più facile aspettare sulla Terra che un extraterrestre si facesse vivo, anziché volare sopra un razzo, dentro una navicella grande poco più di una vasca da bagno, rischiando pure la vita. Quindi cambiai idea.
Ero abbastanza bravo a disegnare (venivo sempre scelto dalla maestra per fare i cartelloni a scuola), così pensai di diventare un fumettista. Mi piaceva inventare storie e renderle vive attraverso le immagini. Perciò ideai alcuni personaggi (un investigatore privato di nome Dean Olaf e i suoi allegri compagni) e ne feci i protagonisti di un fumetto che realizzavo ogni due mesi. Riuscii a venderne diverse copie e a guadagnare abbastanza da comprare altri fumetti (quelli delle edicole, fatti bene, mica come i miei!).
“Potrei davvero farne la mia professione” mi dissi un giorno, proprio come Jacovitti e Roberto Raviola in arte Magnus, i miei miti. Lo comunicai ai miei genitori, ma la notizia fu presa piuttosto freddamente: per loro quello non era un “vero lavoro”, nel senso che non era sicuro, che non dava garanzie di guadagnare sempre, che potevi fare un fumetto per qualche anno e poi magari non lo comprava più nessuno e così ti ritrovavi senza soldi e senza lavoro. Mi chiesero gentilmente di pensare a qualcos’altro.
Un numero speciale di Dean Olaf, il mio fumetto bimestrale.
Quando avevo dodici o tredici anni, in tivù davano spesso partite di football americano. Gli atleti, con i caschi, le divise e tutte quelle imbottiture, sembravano dei supereroi. E poi avevano il nome scritto bello in grande sulle spalle (oggi è normale vederlo anche nel calcio e nel basket, ma allora ce l’avevano solo loro). Dissi ai miei che volevo diventare un giocatore di football americano. Ma mica in Italia, no, in America.
«Allora andrai a vivere in America?» mi chiese mia madre.
«No» risposi. «Vivrò in Italia, ma andrò in America la domenica, per le partite.»
Evidentemente, per me, gli allenamenti rivestivano un ruolo marginale.
A un certo punto mi venne in mente di fare l’architetto. Non sapevo esattamente cosa significasse, ma avevo visto lo studio di un architetto, una volta, un bello studio, e mi sembrava che diventare architetto fosse una cosa desiderabile. E poi gli architetti stanno sempre a disegnare e a me disegnare piaceva un botto.
«L’architetto è un lavoro vero, con tanto di laurea in Architettura» disse mio padre, «mica come fare il disegnatore di fumetti o il giocatore di rugby…»
«Football» lo corressi.
«Be’, quello che è.»
Pensai che avrei fatto l’architetto a lungo, finché un amico non mi invitò a iscrivermi a un corso di astronomia. Avevo sedici anni e fui totalmente rapito dalle stelle. La mia vecchia passione tornava a farsi sentire. Andavo ogni giovedì al planetario, dove, sul soffitto a cupola di una sala, ci mostravano una rappresentazione del cielo. Potei anche utilizzare un grande telescopio e vedere stelle e pianeti dal vivo, di notte. Ero entusiasta. Volevo essere un astronomo. Altro che football americano!
«Non mi sembra il massimo fare gli oroscopi tutto il giorno!»
«Quello è l’astrologo, nonna, non l’astronomo.»
Il corso di astronomia si trasformò in qualcosa di ancora più eccitante: archeoastronomia, che sarebbe lo studio di come le antiche popolazioni interpretavano i fenomeni celesti. Luoghi misteriosi come Stonehenge, le piramidi di Giza o gli antichi templi Maya mi convinsero che da grande avrei fatto proprio l’archeoastronomo.
Il percorso era semplicissimo: prima la laurea in Astronomia, poi la specializzazione in Archeoastronomia.
O meglio, sembrava semplicissimo. Diedi un’occhiata agli esami e capii che non ci sarei mai riuscito: matematica, matematica e ancora matematica. Sapete qual era la materia nella quale andavo peggio? Ecco.
Cosa volevo fare da grande? Non lo sapevo. Di sicuro non avevo mai pensato di fare il veterinario. Né lo scrittore.
Ero al punto di partenza.
Cosa volevo fare da grande? Non lo sapevo.
Di sicuro non avevo mai pensato di fare il veterinario.
Né lo scrittore.
CI SORPRENDE. PROPRIO COME IN UN ROMANZO, quando pensi che le cose andranno in un certo modo e invece vanno in un altro, del tutto inaspettato.
Dal momento che non avevo alcuna idea su cosa fare da grande, un giorno mio padre mi raccontò qual era stato il suo sogno da ragazzo. Lui aveva sempre lavorato in un ufficio, in mezzo alle carte e alle macchine da scrivere. Dirigeva una fabbrica di mobili. Sì, andava anche in mezzo ai mobili, di tanto in tanto, ma per lo più stava seduto a una scrivania, in mezzo alle carte e alle macchine da scrivere.
«Be’» mi disse quel giorno, «se avessi potuto studiare, mi sarebbe piaciuto fare il veterinario.»
«E come fai a sapere che ti sarebbe piaciuto» chiesi io, «visto che non l’hai mai fatto?»
Non mi rispose. In effetti non lo sapeva. Non puoi sapere se una cosa ti piace finché non hai provato a farla. Credo che a lui piacesse l’idea di fare il veterinario, come a me, in passato, era piaciuta l’idea di fare l’astronauta, il giocatore di football americano, l’architetto e l’archeoastronomo.
Da giovane mio padre aveva avuto dei cavalli e dei cani, e credo che alla base del suo desiderio ci fosse una reale passione per gli animali. Ma la passione per gli animali, come vedremo, non basta a fare di uno studente di Veterinaria un bravo veterinario.
Mio padre concluse quella conversazione chiedendomi se non mi andasse di fare il veterinario. Io dissi che ci avrei pensato. E così feci.
Era il 1982, l’anno in cui l’Italia vinceva i Mondiali di calcio, e io frequentavo la quarta al liceo scientifico Leonardo da Vinci, a Treviso. Dei miei diciassette anni di vita, gli ultimi dieci li avevo divisi con Veronica, un cocker femmina di colore fulvo. Sì, un cane.
Veronica era un po’ piccola rispetto allo standard dei cocker e così, anche quando il suo muso cominciava a imbiancarsi a causa dell’età, c’era sempre chi la scambiava per un cucciolo, cosa che mi divertiva molto.
La passione per gli animali non basta a fare di uno studente di Veterinaria un bravo veterinario.
Veronica quell’anno si ammalò ai reni. I reni sono importanti perché aiutano a depurare il sangue, agendo da filtri. Quando non funzionano bene, tutto l’organismo ne risente.
Il veterinario che la prese in cura era bravo, competente, ma non poteva fare molto. I reni non sono organi facili da curare, anche nell’uomo. Cominciai a pensare che io avrei potuto fare meglio. Magari avrei potuto trovare una cura miracolosa, qualcosa che ancora non esisteva, e che avrebbe salvato la vita della mia piccola amica. Credo che la scelta definitiva di iscrivermi alla facoltà di Medicina Veterinaria sia dipesa anche da questo. Volevo curare Veronica, volevo essere io ad aiutarla. Era il mio cane, la socia di mille avventure, la mia sorellina minore. Quante ne avevamo passate insieme!
Finito il liceo mi iscrissi all’università. Sapevo di avere davanti a me un mare di esami e difficoltà a non finire, ma ero anche consapevole di possedere qualcosa che forse gli altri non avevano: uno scopo preciso, salvare Veronica.
Ma la vita, come detto, ci sorprende. A volte anche in negativo.
Veronica morì quando io ero soltanto al secondo anno di università. Avevo studiato Fisica, Istologia, Anatomia, Botanica, Biomatematica, Chimica, Parassitologia, Idrobiologia e Pescicoltura. Ma nulla che servisse davvero per curare il mio cane. Era ancora troppo presto. Gli esami specifici, quelli che permettono di conoscere...