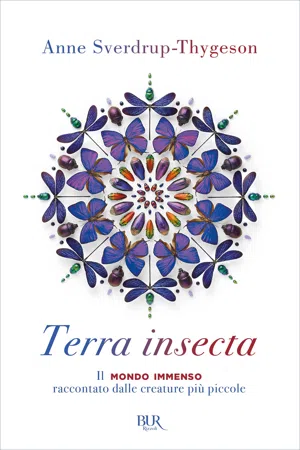Ma come sono fatte le creaturine con le quali dividiamo il pianeta? Qual è la loro struttura? Per cominciare vi propongo un rapido corso di base sull’ingegneria degli insetti. Tra le altre cose scopriremo che gli insetti, nonostante le loro dimensioni ridotte, sanno contare, insegnare e riconoscersi a vicenda (oltre a riconoscere noi).
Sei zampette, quattro ali, due antenne
Già, ma come distinguere gli insetti dagli altri invertebrati? Nel dubbio contate le zampe. La maggior parte degli insetti ne ha sei, tutte fissate alla parte centrale del corpo.
A questo punto verificate la presenza di ali. Anche quelle si innestano nella parte centrale del corpo. La maggior parte degli insetti ne ha quattro: un paio di ali anteriori e un paio posteriori.
Ci credereste? Senza neppure farci caso avete appena imparato anche una terza proprietà fondamentale degli insetti: hanno sempre un corpo diviso in tre parti. Come tutti gli esponenti del gruppo degli artropodi, gli insetti si compongono di più segmenti, detti anche metameri. Nel caso degli insetti quella struttura modulare si è articolata in sole tre parti ben separate e chiaramente distinguibili: il capo, il torace e l’addome.
I segmenti riassorbiti nel corso dell’evoluzione hanno lasciato delle vestigia simili a tacche o segni sul corpo di molte specie di insetti, un po’ come se qualcuno li avesse lavorati con una lama affilata. D’altra parte non è un caso che gli insetti si chiamino così. La parola deriva dal verbo latino insecare, che significa “incidere”, “praticare un taglio”.
Il primo dei tre segmenti, il capo, non è poi così diverso dalla nostra testa. Qui troviamo l’apparato boccale e i principali organi di senso, cioè gli occhi e le antenne. Negli insetti le antenne sono sempre due, non una di più, non una di meno, anche se le dimensioni e la forma risultano estremamente variabili. In compenso, diciamolo subito, gli occhi degli insetti non sono sempre localizzati sulla testa, o non solo. Esiste un macaone (un tipo di farfalla) che ha occhi perfino sul pene! Il maschio se ne serve per assumere la posizione corretta durante l’accoppiamento. La femmina, per parte sua, ha degli occhi sull’addome: li usa per verificare che le uova siano state deposte come si deve.
Se la testa degli insetti serve perlopiù da centralina sensoriale, il segmento intermedio, il torace, è la parte adibita al trasporto. È quasi interamente costituito da potenti muscoli che contribuiscono ad azionare le ali e le zampe. Va precisato fin da ora che le ali degli insetti – caso unico tra gli animali che sanno volare o planare, come gli uccelli, i pipistrelli, gli scoiattoli o i pesci volanti – non sono degli arti riadattati alle esigenze del volo: costituiscono un apparato motorio a parte che si affianca alle zampe.
L’addome, che non di rado è la regione morfologica più sviluppata, è il segmento adibito alla riproduzione, oltre a contenere la maggior parte del sistema digerente. Le deiezioni vengono espulse dalla parte posteriore dell’addome. Spesso, ma non sempre. Le minuscole vespe delle galle, che trascorrono la prima parte della loro vita all’interno delle tumescenze che la pianta fa crescere intorno a loro per isolarle, sono creature ammodo: defecare nel proprio nido non è buona creanza, ma come fare quando si è intrappolate in un monolocale senza bagno? Non resta loro che tenerla, tanto è vero che il tubo digerente e l’ano si collegano al resto dell’organismo solo al termine dello stadio larvale.
Piccoli smidollati
Gli insetti sono degli invertebrati, cioè animali del tutto privi di spina dorsale, scheletro e ossa. In compenso dispongono di un esoscheletro: un involucro duro ma leggerissimo che protegge le delicate strutture interne da collisioni e sollecitazioni ambientali. La parte esterna dell’esoscheletro è ricoperta da uno strato di cere che proteggono l’animale dalla minaccia numero uno, il grande terrore di tutti gli insetti: la disidratazione. Data la loro minuscola taglia, gli insetti presentano una superficie decisamente estesa in confronto al volume: in altri termini, rischiano che le preziose molecole d’acqua presenti nel loro organismo, evaporando, li lascino stecchiti come baccalà. Quello strato di cere è quindi indispensabile: serve a trattenere nell’organismo un certo numero di particelle di umidità.
Dello stesso materiale di cui è fatto l’esoscheletro sono composte anche le zampe e le ali. Le zampe degli insetti sono dei robusti tubicini cavi articolati in più segmenti che consentono loro di correre, saltare e compiere mille altre prodezze straordinarie.
Avere un esoscheletro, però, non è sempre un vantaggio. Come crescere e svilupparsi quando si è prigionieri di un involucro rigido? Immaginate della pasta per dolci all’interno dell’armatura di un cavaliere medievale: quella lievita, cresce e si dilata finché non trova più spazio. Eppure, anche in questo caso, gli insetti sanno come cavarsela: sotto la vecchia armatura ne cresce una seconda che in un primo tempo è morbida. La vecchia, non essendo deformabile, finisce per fessurarsi, e allora l’insetto se ne sbarazza come noi ci cambiamo una camicia macchiata. A quel punto l’essenziale è gonfiarsi, alla lettera, cioè dilatare il più possibile la nuova armatura ancora morbida prima che si irrigidisca a sua volta, facendosi impenetrabile. Quando il nuovo esoscheletro perde la sua iniziale plasticità il margine di crescita risulta irrimediabilmente compresso fino alla successiva muta.
Vi sembra troppo faticoso? Forse vi consolerà sapere che il ciclo delle mute (salvo rare eccezioni) riguarda solo le prime fasi della vita di un insetto.
La metamorfosi
Esistono due tipi di insetti: quelli che si trasformano per successivi gradi, di muta in muta, e quelli che cambiano in modo improvviso, nel passaggio dall’infanzia alla condizione adulta. Il nome tecnico di questa trasformazione è metamorfosi.
La prima categoria – rappresentata da libellule, cavallette, blatte e cimici – muta aspetto per successivi gradi, nel corso di un processo di crescita. Un po’ come facciamo noi, che pure non siamo costretti a spogliarci della vecchia pelle per indossare la nuova. Lo stadio giovanile di quegli insetti prende il nome di ninfa. La ninfa cresce, cambia più volte esoscheletro (il numero delle mute dipende dalla specie, ma perlopiù si parla di tre-otto cicli) e finisce per assomigliare sempre di più alla versione adulta. Fino all’ultima muta, quando la ninfa cambia pelle un’ultima volta ed esce da un involucro larvale ormai superfluo, finalmente dotata di ali e organi riproduttivi perfettamente funzionanti. Voilà! L’insetto è diventato grande.
Altre specie conoscono un’alterazione totale e pressoché magica del loro aspetto esteriore nel passaggio dallo stadio giovanile a quello adulto. Nel mondo degli esseri umani metamorfosi così radicali esistono solo nelle fiabe o nel mito: ranocchi che diventano principi, vecchie streghe capaci di trasformarsi in gatto ecc. Per quanto riguarda gli insetti, però, la metamorfosi non dipende da baci o formule magiche, ma è governata da processi ormonali, responsabili della ristrutturazione morfologica che segna il passaggio dallo stadio giovanile a quello adulto. Per prima cosa l’uovo si schiude, liberando una larva, che però non assomiglia in nulla alla forma definitiva dell’insetto. Il più delle volte una larva fa pensare a un sacchetto biancastro dotato di un organo boccale a una delle estremità e di un ano all’estremità opposta (anche se non mancano le eccezioni, come nel caso di molte larve di farfalla). Le larve attraversano più cicli di muta, crescendo via via, ma senza assomigliare ancora in nulla al prodotto finito.
La vera magia è quella della pupa, uno stadio di transizione nel quale l’insetto conosce una miracolosa trasformazione, passando da “animale-sacchetto” a individuo adulto: un essere sofisticatissimo dotato di una struttura dall’inconcepibile complessità. L’involucro protettivo della pupa nasconde una trasformazione integrale: è un po’ come se i mattoncini di una costruzione LEGO venissero smembrati e li si usasse per comporre una figura totalmente nuova. Finché la pupa non esce dal bozzolo trasformata in una “bellissima farfalla”, come racconta il Bruco Maisazio di Eric Carle, uno dei miei classici per l’infanzia preferiti.
La capacità di trasformarsi è utilissima, anzi, rappresenta la variante di gran lunga più efficace sul piano evolutivo. La maggior parte degli insetti del nostro pianeta, l’85 per cento circa, vive un processo di metamorfosi completa. Il fenomeno riguarda molte delle specie più diffuse, come i coleotteri, le vespe, le farfalle, le mosche e le zanzare.
Il colpo di genio sta nel fatto che la versione giovanile e quella adulta dello stesso insetto possono beneficiare di fonti alimentari e ambienti di vita totalmente diversi, traendo di volta in volta il massimo profitto da ciascuna fase. Quando la priorità è accumulare la maggiore quantità di energia possibile le larve, incapaci di volare, agiscono come delle autentiche macchine divoratrici. Nel successivo stadio, quello della pupa, le energie accumulate vengono riorganizzate e reinvestite nell’assemblaggio di un organismo totalmente nuovo: un essere capace di volare il cui unico obiettivo è la riproduzione.
L’esistenza di un nesso genetico tra le larve e l’insetto adulto non è sfuggita all’essere umano, che ha osservato il processo almeno fin dai tempi dell’antico Egitto. In un primo tempo, però, nessuno ha capito che cosa succedesse davvero. Alcuni sostennero che la larva fosse come una confusa esistenza fetale che aveva smarrito la strada, ma a lungo andare metteva un po’ di giudizio e tornava nell’uovo (cioè impupava) in attesa di nascere; altri vedevano due individui completamente diversi, dei quali uno rinasceva nell’altro.
Solo nel diciassettesimo secolo, grazie all’invenzione del microscopio, Jan Swammerdam è riuscito a dimostrare che le larve e gli insetti sono fin dall’inizio un solo e unico individuo. Grazie all’ingrandimento è apparso finalmente chiaro che sezionando con cautela una larva o una pupa si potevano osservare, nascosti sotto la superficie, elementi riconducibili all’anatomia dell’insetto adulto. Swammerdam non si faceva pregare per dare un saggio dei suoi talenti con il microscopio e il bisturi: davanti a un pubblico spellava un grosso baco da seta per mostrare i rudimenti delle ali della futura falena, già dotate delle caratteristiche venature.
Eppure dovette passare molto tempo perché quelle scoperte venissero accettate comunemente. Nei suoi diari Charles Darwin racconta la storia di un ricercatore tedesco accusato di stregoneria nel Cile del 1830 perché sapeva trasformare le larve in farfalle. Come si è affermato storicamente il processo della metamorfosi? Non lo sappiamo, gli studiosi non sono ancora giunti a una conclusione univoca. Il mondo è tuttora pieno di misteri.
Come lo chiameremo? Nomenclature e raggruppamenti
Per tentare di mettere un po’ d’ordine nel brulichio degli invertebrati gli esseri umani li hanno suddivisi in gruppi, secondo il loro grado di parentela. È un sistema ingegnoso che parte dai regni e procede per successive ramificazioni in phyla e classi, a loro volta organizzati in ordini, famiglie, generi e specie.
Prendiamo il caso della vespa comune. Appartiene al regno animale, al phylum degli artropodi, alla classe degli insetti, all’ordine degli imenotteri, alla famiglia delle vespe, al genere Vespula e alla specie “vespa comune”.
Tutte le specie hanno un nome latino composto da due termini che si scrivono in corsivo. Il primo indica il genere di appartenenza, il secondo precisa la specie. Questo tipo di nomenclatura, chiamata linneiana, è stato introdotto nel diciottesimo secolo dal naturalista svedese Carl von Linné e consente ai biologi di qualunque Paese di riferirsi alla stessa specie senza confusioni linguistiche di sorta. Il nome latino della vespa comune è Vespula vulgaris. In molti casi il senso del nome scientifico è intuitivo: l’aggettivo vulgaris, per esempio, significa “comune” (e non “volgare”).
A volte la nomenclatura latina contiene informazioni sull’aspetto di una creatura. Il coleottero Stenurella nigra, per esempio, è completamente nero. In altri casi il nome è desunto dalla mitologia. Pensiamo alla comune farfalla Aglais io, detta “occhio di pavone”: la sacerdotessa Io, che ha dato il nome anche a una delle lune di Giove, è stata una delle amanti di Zeus.
Con centinaia di migliaia di insetti da battezzare capita a volte che gli entomologi si lascino andare e assegnino alle specie il nome dei loro artisti preferiti (come per il tafano Scaptia beyonceae) oppure quello di certi personaggi di finzione ai quali sono affezionati (come è accaduto per le vespe Polemistus chewbacca, Polemistus vaderi e Polemistus yoda). In certi casi la nomenclatura nasconde addirittura un gioco di parole, del quale magari ci si accorge soltanto scandendo il nome ad alta voce. Provate a pronunciare all’inglese il nome dei tozzi coleotteri Gelae baen e Gelae fish (che suonano rispettivamente come “jelly bean”, un tipo di caramella, e “jellyfish”, medusa), oppure quello delle vespe parassite Heerz lukenatcha (“he’s lookin’ at ya!”, ce l’ha con te) o della specie Heerz tooya (“here’s to you”, alla salute)!
Nel mondo esistono circa trenta diversi ordini di insetti. I cinque principali sono i coleotteri, gli imenotteri, i lepidotteri (o farfalle), i ditteri e i rincoti. Tra gli altri si possono citare gli odonati (o libellule), i blattoidei, gli isotteri (o termiti), gli ortotteri (come cavallette e grilli), i tricotteri, i plecotteri, gli efemerotteri, i tisanotteri, gli anopluri (come il pidocchio) e i sifonatteri (come la pulce).
In assoluto l’ordine più numeroso è quello dei coleotteri, tallonato dagli imenotteri, dei quali si scoprono sempre nuove specie. I coleotteri si riconoscono dal fatto che le ali anteriori (le elitre) risultano sclerificate, a formare uno strato duro che protegge il dorso. A parte questo sono diversissimi tra loro per l’aspetto e lo stile di vita. Esistono coleotteri sia di terra sia d’acqua. Le specie note sono quattrocentomila, organizzate in oltre centosettanta famiglie. Le principali sono i curculionidi, gli scarabeidi, i crisomelidi, i carabidi, gli stafilinidi, i cerambici e i buprestidi.
L’ordine degli imenotteri annovera insetti comunissimi come la formica, l’ape, il bombo e la vespa. Molte di queste specie hanno disposizioni gregarie e vivono in colonie con migliaia di operaie di sesso femminile e una o più regine. Tra gli imenotteri meno conosciuti, però, si contano anche moltissime categorie di vespe fitofaghe (i due sottordini dei sinfiti) e una nutrita serie di vespe parassite. Le specie attualmente note sono centocinquantamila, ma se ne scoprono in continuazione di nuove, per cui si può anche ipotizzare che l’ordine più numeroso, tra gli insetti, siano in realtà proprio gli imenotteri.
I lepidotteri sono dotati di ali coperte di minuscole scaglie disposte come le tegole di un tetto. Nel mondo esistono più di centottantamila specie di farfalle. Molte, però, sono piccole e non si fanno notare. I lepidotteri più conosciuti sono i papilionoidea, una superfamiglia che annovera svariate centinaia di specie diurne di grandi dimensioni che spesso sfoggiano splendidi colori e disegni. Le farfalle notturne sono comunemente chiamate falene (o “tarme” nel caso di alcune specie più piccole).
I ditteri comprendono le specie note a tutti come mosche, tafani, zanzare, moscerini e “zanzare dei prati” (o tipulidi). Il nome deriva dal fatto che, contrariamente al resto degli insetti, hanno solo due ali funzionali e non quattro. Nei ditteri le ali posteriori si sono ridotte a due appendici, i bilancieri, che aiutano a mantenere l’equilibrio in volo. Le specie note sono almeno centomila.
I rincoti sono un ordine meno conosciuto, almeno dalla maggior parte di noi, anche se contano più di settantamila specie. Al loro interno si individuano tre gruppi principali: cimici, cicale e sternorrinchi. Il nome deriva dal greco rhynchos, “rostro”, e si riferisce alla morfologia dell’apparato boccale, dotato di una sorta di becco che l’insetto utilizza come una cannuccia per succhiare il cibo, perlopiù linfa vegetale (alcuni rincoti, però, sono carnivori e succhiano sangue). Esteriormente le cimici assomigliano ai coleotteri, ma si differenziano per il triangolo che portano sulla schiena. Vi sarà capitato di vedere i “pattinatori” che scorrazzano sul pelo degli stagni o forse, usciti a raccogliere frutti di bosco, avete sentito il cattivo odore che certe cimici arboricole chiamate anche pentatomidi sprigionano quando hanno paura (si parla non a caso di cimici “fetide”). Le cicale presentano un’anatomia che può ricordare vagamente quella delle rane. Tra gli sternorrinchi (detti “pidocchi delle piante”) ci sono specie ben note a molti giardinieri dilettanti, come gli afidi, e specie meno comuni come le cocciniglie, la cui femmina, priva di zampe e ali, passa la vita aggrappata a una pianta sotto una sorta di scudo protettivo.
Tanto per...