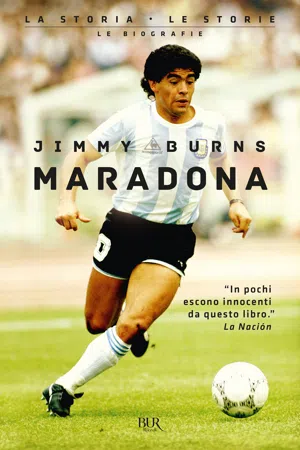Ottobre 1995. A Buenos Aires è primavera. Tra la dolce fragranza dei fiori di jacaranda, il ritmo incalzante dei tamburi e lo sventolio frenetico delle bandiere, migliaia di tifosi si dirigono verso La Bombonera, lo stadio del Boca Juniors. Bombonera in spagnolo significa scatola di cioccolatini, ma non c’è niente che contenga nulla di dolce, in quella scena. La fiumana di gente manda in frantumi la tranquilla domenica della capitale più sofisticata di tutta l’America Latina, come una tribù selvaggia a piede libero in una sala da tè. Gli uomini – perché l’atmosfera allo stadio è ancora abbastanza ostile e di donne e bambini se ne vedono pochi – sono a torso nudo e sventolano le magliette come catene. Avanzano implacabili, come se stessero andando in guerra. Il capotribù, Diego Maradona, li osserva dalla cima di un bus a due piani, lo sguardo scuro e risoluto, i capelli tagliati corti e tinti dei colori di guerra del Boca, un telefonino in mano. Il ritornello è scandito da un giornalista radiofonico dalla voce isterica: «Arriva il nostro idolo, arriva il nostro idolo» ripete, senza sosta. Oltre la terra incolta e le baracche mezze arrugginite lungo il Rio de la Plata, il frenetico corteo passa accanto a un battaglione di poliziotti in tenuta antisommossa, manganelli e lacrimogeni pronti all’uso, prima di rivendicare irrevocabilmente il territorio.
Una volta nello stadio, i tifosi riempiono le gradinate. Le recinzioni altissime e il fossato che circondano il terreno di gioco sembrano focalizzare e alimentare la loro passione. La Bombonera vibra del battito dei piedi e dell’esplosione dei petardi, una danza di guerra collettiva che cresce d’intensità col passare di ogni minuto.
In mezzo al campo c’è una scatola gigantesca, incartata, con un fiocco sopra, che ruota lentamente sul pianale di un furgone. Ma per un attimo tutti gli occhi sono fissi sul serpente di plastica da cui finalmente emerge Maradona, seguito dai compagni del Boca Juniors. Un enorme ruggito lo saluta mentre si fa il segno della croce e alza trionfalmente le braccia al cielo. «Maradooona… Maradooona…» urlano i tifosi. Poi scende in campo un gigantesco pallone gonfiabile, con le parole BENTORNATO DIEGO! Per i descamisados, gli scamiciati che non hanno mai perso la fede, è subito magia. Il loro idolo prende la palla, se la porta come se niente fosse da un piede all’altro, poi la stoppa col petto e la lascia scendere di nuovo. Poi, con la palla sempre vicino al piede, saltella fra le stelle filanti che adesso riempiono lo stadio là dove la scatola ha cominciato a dar segni di vita. Un’altra esplosione, la scatola si apre come un petardo e ne escono le due figlie di Maradona vestite coi colori del Boca, un regalo a sorpresa del maestro di cerimonie, il miglior amico di Maradona nonché procuratore e messaggero notturno, Guillermo Coppola. Sembra che l’intenzione sia di dare un tocco di rassicurante innocenza per scacciare gli incubi del passato.
Sono trascorsi quasi quindici mesi dal giorno in cui Maradona è stato estromesso, nel modo più disonorevole, dai Mondiali negli Stati Uniti dopo essere risultato positivo all’antidoping. Molti pensavano che quel momento avrebbe segnato una volta per tutte la fine di una carriera eternamente sospesa fra successi e scandali. Ma oggi alla Bombonera il dio è tornato, sprezzante, per dimostrare al mondo che Maradona non muore tanto facilmente. È palese che gli manchi l’accelerazione per saltare l’uomo e segnare, ma i suoi passaggi sono praticamente perfetti e la sua visione di gioco è incredibile. Nel giro di pochi minuti dà un qualche senso a una partita tutt’altro che memorabile, creando le poche opportunità che il Boca avrà di tirare in porta. Quando finalmente il gol arriva, all’ultimo minuto della partita, Maradona non è coinvolto in prima persona nell’azione. Eppure tale è stata la sua presenza nel corso dei novanta minuti che nessuno dei sessantamila tifosi stipati nello stadio ha nulla da obiettare quando Diego esulta come se avesse segnato lui. La palla entra in rete, e Maradona si volta e attraversa il campo, alzando le braccia in trionfo all’indirizzo della sua famiglia, di Coppola, delle telecamere. L’ultima volta che ha corso così verso una telecamera è stato quando ha segnato il terzo gol contro la Grecia, il suo primo gol di quel disgraziato Mondiale. Oggi, come allora, vuole dire alla gente che è ancora il migliore, che non è così facile sconfiggerlo. «Olé, olé, olé, olé, Diego, Diego!» canta in coro la folla. Sì, Dio è tornato.
Il fatto che questa resurrezione, dopo quella che sembrava la caduta definitiva, vada in scena qui alla Bombonera, ci ricorda che non si può davvero separare Maradona dal Paese in cui è nato e cresciuto. L’unica certezza, con Maradona, è che quando morirà, indipendentemente da come accadrà, il suo funerale a Buenos Aires sarà in pompa magna come quello di Evita, e persino allora la gente si rifiuterà di credere che sia morto. Se è vero che in Argentina sono pazzi di calcio, i sintomi più ovvi di questa passione sono i ferventi rituali dei tifosi del Boca, molti dei quali hanno le stesse origini di Maradona, una mescolanza fra immigrati poveri e stirpi indigene. Tanti di loro vivono e respirano calcio perché non resta più nient’altro in cui credere. L’Argentina ha una lunga tradizione di falsi profeti.
Ogni giocatore argentino degno di questo nome dice che la sua ambizione è di giocare nel Boca, un giorno. Maradona lo disse da giovanissimo, ma poi si spinse un passo oltre. Ammise di avere una seconda ambizione: quella di vincere un Mondiale. Ha condotto il Boca alla vittoria in campionato quando aveva appena ventun anni. È tornato alla Bombonera dopo aver guidato la nazionale alla conquista della Coppa del Mondo, con la fascia da capitano. Le sue prestazioni eccezionali ai Mondiali di Messico ’86 gli sono valse il titolo di miglior giocatore di tutti i tempi. Alto meno di un metro e sessantacinque, eppure con una forza di volontà e un equilibrio fisico capaci di fargli sopportare una straordinaria gamma di maltrattamenti, Maradona ha unito la tecnica e la visione di gioco di Pelé alla versatilità di Johan Cruijff. Ma in realtà Maradona è sempre sembrato al di là dei paragoni, sfuggendo alle categorizzazioni con la stessa facilità con cui ignorava le richieste dei presidenti e la disciplina degli allenatori. Ed è lì che sta il suo carisma.
I suoi connazionali si sono innamorati di lui perché proiettava a livello internazionale la narrazione di un successo argentino. Sembrava rimediare ai tanti fallimenti della loro storia. Maradona ha offerto agli argentini non soltanto un’identità, ma una via di fuga. Vedevano la purezza del suo modo di giocare, e la chiamavano poesia.
La popolarità di Maradona nel resto del mondo, invece, ha attinto la sua forza dal modo in cui incarnava l’idea stessa del successo, e dall’ammirazione che si era conquistato grazie al suo talento naturale per il calcio. La sua storia è la leggendaria ascesa di un genio il cui destino manifesto è rappresentato alla perfezione dalle prime immagini di Diego, nel filmato del servizio in cui un Maradona poco più che bambino dà una dimostrazione del suo eccezionale controllo di palla su uno dei campetti polverosi della baraccopoli. Una storia che poi si è evoluta fino a diventare il mito del talento naturale che, per quanto determinato a vincere, riusciva ancora a dimostrare, certe volte, di essere follemente innamorato del calcio. Nelle giornate giuste, Maradona si dimenticava chi fosse diventato, e semplicemente scendeva in campo e giocava a pallone.
Gli aneddoti che illustrano l’universalità di Maradona sono una moltitudine, e di solito dicono più sui singoli Paesi che non sull’uomo in sé. Ma ce ne sono due in particolare che vale la pena ricordare subito. Aiutano a capire fino a che punto Maradona sia riuscito ad attraversare i pregiudizi culturali e i confini nazionali. Il primo ha per protagonista un gruppo di turiste argentine in visita alle piramidi, dove alcuni egiziani avevano iniziato a infastidirle. Le donne erano sull’orlo della disperazione dopo che le loro richieste di essere lasciate in pace erano state ripetutamente ignorate. Poi una di loro all’improvviso si ricordò di una cosa che suo fratello, tifoso del Boca, le aveva detto prima di partire: Maradona una volta aveva giocato un’amichevole da qualche parte in Medio Oriente, per inaugurare una scuola calcio per bambini. Così la donna si ritrasse per l’ennesima volta e gridò: «Maradona!». Nel sentire quel nome, gli egiziani si diedero una regolata, e nel giro di un attimo smisero di pensare al sesso e cominciarono a parlare di calcio, consentendo alle turiste di battere in ritirata pochi minuti dopo senza venir più molestate.
La seconda storia vede Maradona nella metropolitana di Londra, in incognito, con un cappello e un cappotto lungo, il bavero alzato a coprirgli quasi del tutto il volto. In occasione di uno dei suoi rari viaggi in Inghilterra – ha appena tenuto una lezione all’Oxford Union – è in ritardo, come spesso gli accade, e ha un aereo da prendere. Il giovane studente argentino che lo ha invitato lo convince che la metropolitana per Heathrow è più veloce del taxi. Lui acconsente a prenderla a condizione di potersi camuffare. Teme che qualora lo riconoscano possano fargli perdere tempo, o persino aggredirlo. Tutto sembra andare secondo i piani finché, a quattro fermate dal capolinea, un passeggero lo riconosce e ne annuncia la presenza ad alta voce. Tutti interrompono all’istante le loro conversazioni, e si voltano a guardarlo. Nel giro di pochi secondi l’intera carrozza si è radunata intorno a lui per chiedergli un autografo. Sono quasi tutti inglesi. Uno gli dice che non si è certo dimenticato della Mano di Dio, ma che si ricorda anche l’altro gol che Maradona segnò contro l’Inghilterra, una delle reti più celebri nella storia del calcio.
Ma il talento è solo una parte della vicenda di Maradona. Il mito di Maradona come Dio è stato alimentato e sfruttato da interessi economici e da idiosincrasie nazionali e regionali. Sin dagli albori della sua carriera, Maradona è stato sia commercializzato che politicizzato. La sua immagine polverizzò qualsiasi record di trasferimenti e incoraggiò la diffusione delle sponsorizzazioni e dei diritti televisivi come elementi cruciali del legame sempre più stretto fra il calcio internazionale e il libero mercato. C’era un aspetto ciclico nel ritorno di Maradona al Boca, in più di un senso. L’accordo sui diritti televisivi da dieci milioni di dollari che stava dietro al suo ritorno era stato reso possibile dallo stesso uomo d’affari che aveva firmato uno dei primissimi accordi di sponsorizzazione per il giocatore sul finire degli anni Settanta.
Maradona scelse di giocare in Paesi nei quali il calcio si mescola inesorabilmente alla politica, in maniera davvero passionale, e dove la pressione mediatica sui campioni è immensa, senza però rendersi conto fino in fondo che così facendo avrebbe dovuto interpretare un ruolo che andava al di là di requisiti puramente sportivi. Alcuni degli aspetti meno edificanti delle pressioni esterne subite da Maradona sono riconducibili a individui che sostengono di rappresentare la professione medica, ma che hanno cinicamente anteposto gli interessi a breve termine di Maradona come macchina da soldi alle considerazioni circa la sua sopravvivenza a lungo termine come essere umano.
Sia gli aspetti tragici della vita di Maradona sia la sua capacità di essere fonte d’ispirazione affondano le radici nella povertà della sua infanzia. Essere il primogenito maschio di una famiglia povera significò che già in tenera età gli toccò accollarsi il fardello di dover sfamare la sua famiglia quasi da solo tramite il calcio, senza avere il tempo o l’istruzione per poter prendere in considerazione o esplorare eventuali alternative. Mi ricordo che una volta ero seduto accanto ai genitori di Maradona, Chitoro e Tota, durante la sua stagione con la maglia del Boca, e di aver visto in prima persona la maniera ossessiva con cui soprattutto la madre seguiva la prestazione di suo figlio in campo.
Allo stesso tempo è difficile immaginare Maradona con una storia diversa. La baraccopoli gli ha dato la fame di successo e un sistema di valori alquanto tormentato basato sulla superstizione e su un sistema di espedienti, per tirare a campare. È meno chiaro invece fino a che punto la vita di Maradona avrebbe potuto essere diversa se si fosse scelto altri amici, altri procuratori, o se avesse giocato in altri Paesi. Sia la sua tribù sia alcuni dei suoi consulenti sono responsabili quanto i medici per le crisi personali e professionali che ha patito nel corso della sua carriera. Troppi dei personaggi che hanno fatto parte della vita di Maradona sembrano fare confusione tra subordinazione e lealtà, e hanno finito con l’assecondare le sue stramberie quando invece le critiche avrebbero potuto fargli meglio. In un contesto più ampio, le ripetute accuse di ipocrisia mosse da Maradona a certe istituzioni calcistiche sono tutt’altro che prive di giustificazioni. Ben più di una volta dirigenti e funzionari hanno chiuso un occhio davanti ai difetti di Maradona quando era nel loro interesse, per poi stangarlo una volta deciso che avesse oltrepassato la data di scadenza. In questo senso i dirigenti di tutti i club in cui Maradona abbia mai giocato, gli allenatori della nazionale, la federcalcio argentina e dulcis in fundo la FIFA, l’organo supremo del calcio mondiale, dovrebbero assumersi altrettante responsabilità. Il loro evidente desiderio di sfruttare Maradona innanzitutto a livello commerciale non sempre ha fatto l’interesse del calcio.
Ma sarebbe davvero troppo semplicistico dipingere Maradona come una vittima di circostanze fuori dal suo controllo. In verità si è sempre portato dietro, dentro di sé, il suo peggior nemico e il suo migliore amico. La debolezza insita nel suo carattere ha fatto sì che non fosse in grado di gestire le pressioni del successo e della fama. Non sopporta di venir toccato in mezzo alla folla, eppure cade in una profonda depressione se pensa che la folla lo stia ignorando o gli si sia rivoltata contro. Ho visto il meglio di Maradona quando, da solo insieme a un paio di amici, fa qualcosa di semplice, come bersi una birra o mangiare una pizza. Ha l’aria rilassata, a proprio agio con se stesso e con il mondo che lo circonda, è generoso e divertente. E ho visto il peggio di Maradona quando, ancora segnato dalla nottata precedente, o rosso di rabbia e frustrato dopo una sconfitta, irascibile e sentenzioso, gioca a fare il re di fronte a qualche suddito adorante o in conferenza stampa. Possiamo solo immaginare quanto sarebbero state diverse le cose se fosse andato a giocare in Inghilterra anziché in Spagna, come gli aveva consigliato di fare Osvaldo Ardiles. Magari avrebbe sentito meno il bisogno di parlare di questioni che esulavano dal calcio. Magari avrebbe potuto anche condurre una vita più tranquilla, meno complicata. Per quanto, dalla tossicodipendenza di Paul Merson al calcio volante a un tifoso di Eric Cantona, il calcio inglese sia tutt’altro che avaro di sorprese e di polemiche.
Maradona resta comunque figlio del suo Paese. Le sue opinioni politiche sono un guazzabuglio di idee raffazzonate che non sono mai state messe alla prova in una vera discussione. Un documentario televisivo realizzato in Inghilterra nel 1995 tentò di dipingerlo come un rivoluzionario radicale, ma quando Maradona tesse le lodi di Castro lo fa perché secondo lui è l’ultimo «vero patriarca con le palle». Le opinioni politiche di Maradona sono poco più che un rozzo ma fervente nazionalismo, che lo rende vulnerabile alle manipolazioni del governo argentino di turno, quale che sia il suo livello etico.
In Argentina il concetto inglese di fair play è senz’altro meno riconosciuto e assai meno popolare del concetto di viveza. La parola letteralmente significa vivacità, ma è usata per indicare l’arte di arrangiarsi, o di fregare gli altri, pur non essendo mai utilizzata in senso negativo. L’eroe nazionale argentino è un gaucho chiamato Martín Fierro, che passa il tempo a barare e a farla franca. Maradona stesso ammise in un’intervista del 1994 di portarsi appresso più la viveza delle baraccopoli di Buenos Aires che non la schiettezza dell’Argentina di provincia.
Un altro aspetto chiave nella vita del villero, ovvero di chi abita nelle baraccopoli, è la lealtà a una cerchia molto unita di parenti e amici, e un certo sprezzo delle istituzioni esterne. Di conseguenza, pur essendo un personaggio pubblico, Maradona resta straordinariamente inaccessibile. Le sue conferenze stampa sono sempre eventi manipolati con grande attenzione, durante i quali offre solo mezze risposte o solo le risposte che gli va di dare. Anche nei faccia a faccia è molto selettivo nella scelta dei giornalisti con cui aprire parte di se stesso, e comunque lo fa solo per brevi momenti.
Tutto questo spiega almeno in parte come mai la sua tossicodipendenza sia durata più a lungo di quanto si pensava all’inizio. Ha ammesso solo molto tardi che aveva fatto uso di droga per coprire e per nascondere fino a che punto la sua vita stesse andando in malora. Dopo essersi costantemente rifiutato di confessare alcunché, all’inizio del 1996 concesse al settimanale argentino di costume «Gente» un’intervista preparata con attenzione, nella quale fornì alcuni dettagli circa il suo abuso di stupefacenti e auspicò un miglioramento delle politiche di prevenzione rivolte ai giovani.
Per più di quattordici anni Maradona aveva giustificato il suo rifiuto di discutere della questione con la scusa che al pubblico doveva importare solo del suo talento calcistico. Usava argomentazioni simili quando si rifiutava di confermare certi altri aspetti della sua vita fuori dal campo, come il figlio che ha avuto in Italia o i suoi contatti con la camorra. La sua posizione sarebbe stata difendibile se Maradona non fosse stato Maradona. In altre parole, se non avesse sconfinato di sua spontanea volontà oltre i limiti della sua carriera di calciatore professionista per abitare un mondo che gli richiedeva un livello di responsabilità sociale che lui non era in grado di assumersi, anche qualora ne avesse avuto intenzione.
È qui che i difetti di Maradona come essere umano emergono con più forza. Chi lo elogia senza riserve dà grande importanza ai suoi attacchi espliciti contro determinati simboli del potere, come la dirigenza della FIFA, e la sua difesa dei poveri. La realtà è che Diego Maradona ha passato molto più tempo a far parte dell’ingranaggio universale della FIFA per lo sfruttamento del calcio che non nei quartieri piagati dalla povertà dove erano cresciuti i suoi genitori a Esquina e Villa Fiorito, molto più tempo a difendere il suo diritto a fare i propri comodi che non a dare l’esempio per le prossime generazioni di calciatori che, seguendo il suo esempio, potrebbero lasciarsi tentare dalla droga, o abbandonare i figli che avevano promesso di crescere, o bere un bicchiere di champagne in compagnia di un camorrista.
Ci aspettiamo troppo da quello che è il più commercializzato tra gli sport, il calcio, e i calciatori si aspettano troppo da loro stessi: forse questi sono sintomi della commercializzazione stessa dello sport. Questo libro di certo non sarebbe mai stato scritto se così non fosse. Magari anni fa Maradona sarebbe passato alla storia come l’ennesimo calciatore ossessionato da se stesso e non particolarmente intelligente ma che nonostante tutto era il miglior giocatore nella storia del calcio. Ma è diventato un mito nella propria epoca, trascinando con sé milioni di persone, e deve farsi carico di questa responsabilità.
Su una parte di Maradona non si può discutere: i momenti di magia che ha regalato al calcio e il modo in cui, in certi momenti della sua carriera, siano stati soffocati da arbitri mediocri, dalla mancanza di professionalità dei suoi avversari e dalla pessima gestione di funzionari che avrebbero dovuto essere più giudiziosi. Eppure il difetto più tragico di Maradona sta in quanto lui stesso abbia perpetuato, con le sue dichiarazioni e la sua condotta, il mito della propria condizione quasi divina, senza però assumersi pienamente la responsabilità delle sue mancanze. Troppo spesso Maradona ha sperperato il proprio talento, negando non solo ai tifosi ma a se stesso l’opportunità di godersi il suo calcio, puro e semplice, con Dio davvero dalla sua parte.