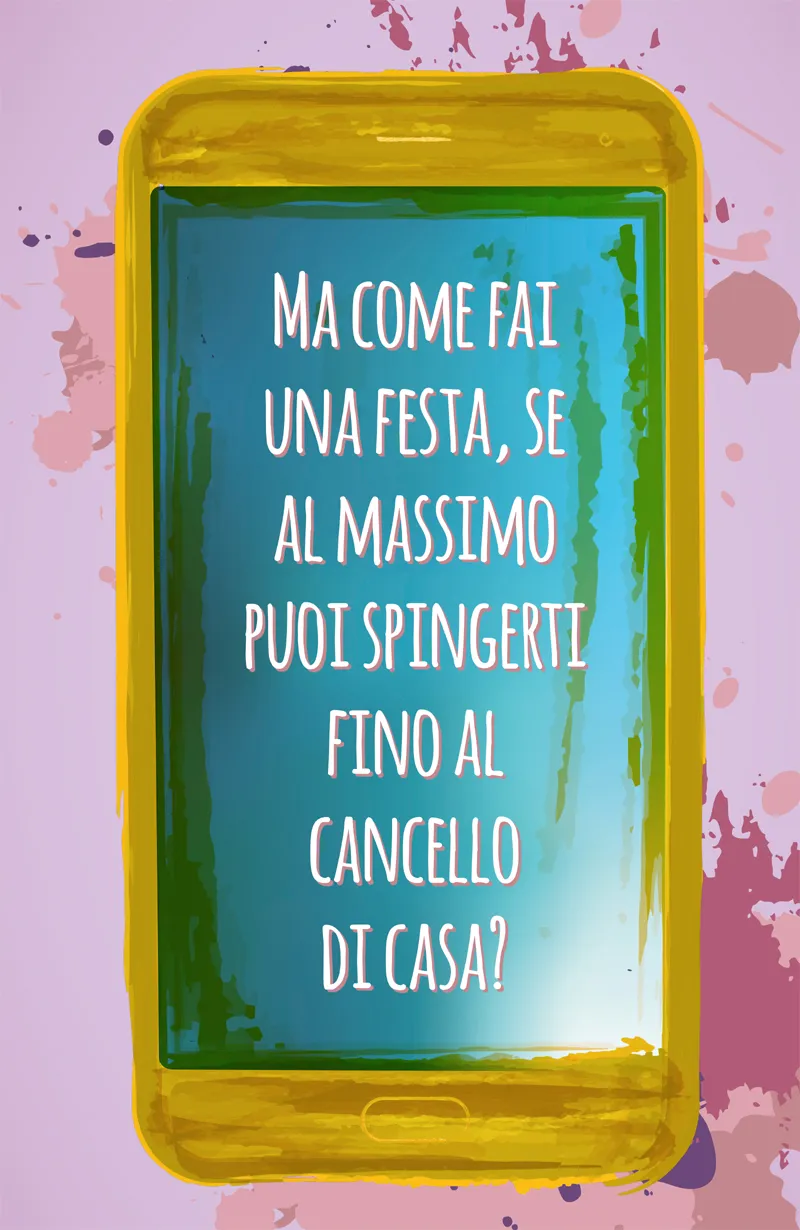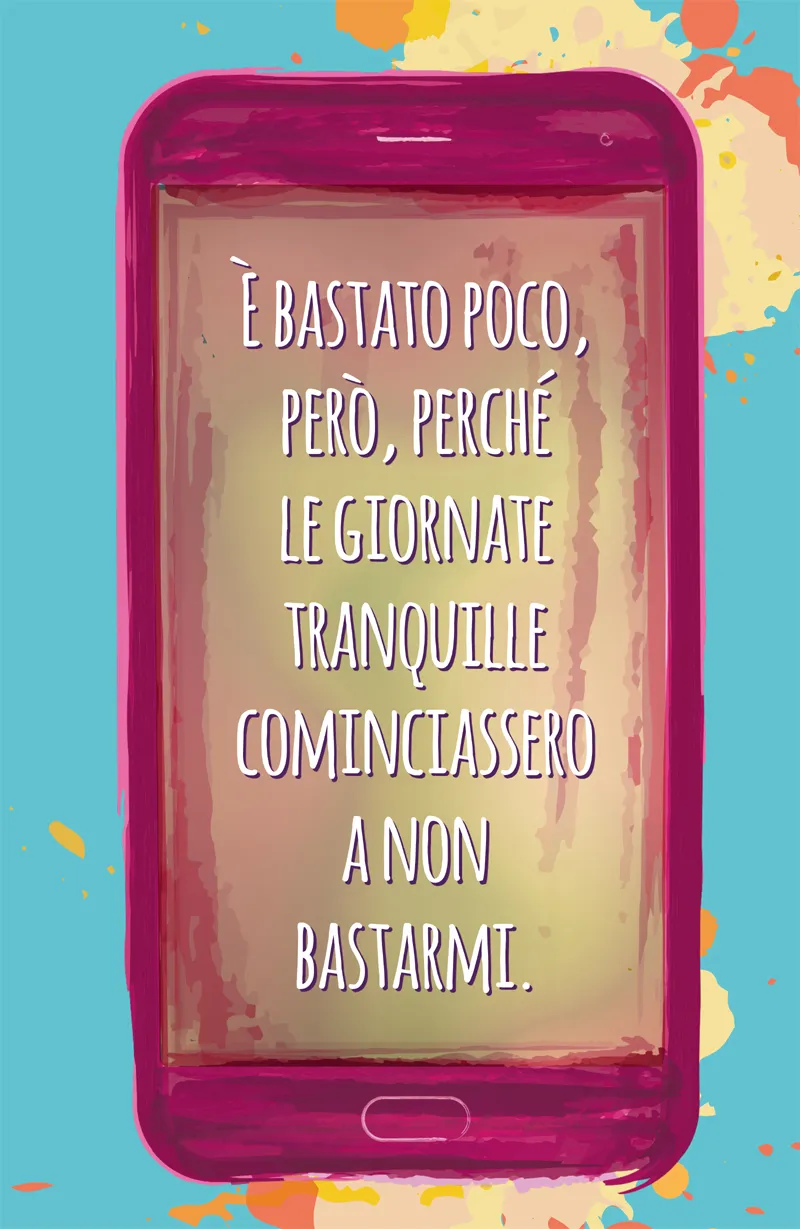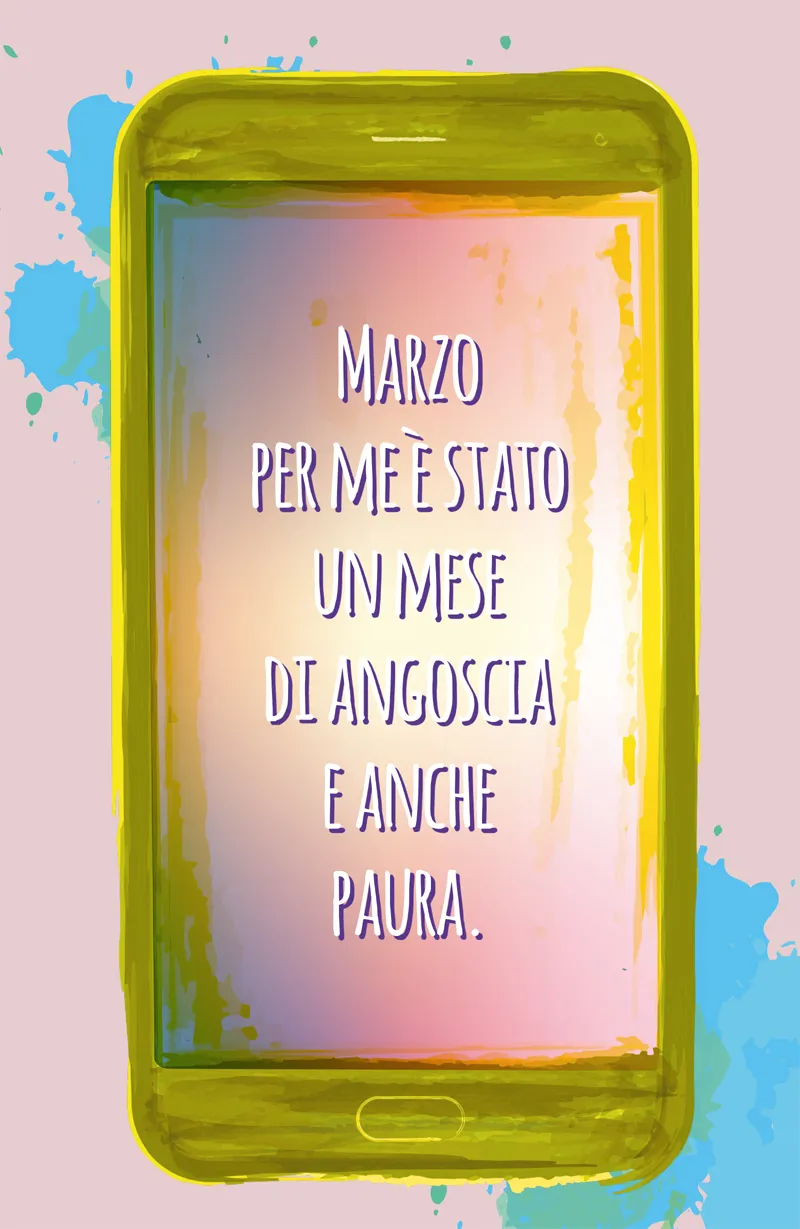Immaginate di avere vissuto la vostra prima esperienza da attore, quella che vi porta nella direzione lavorativa in cui credete davvero – tipo che se vi chiedono: «Cosa vuoi fare da grande?», rispondete subito: «Il cinema» – e che siete stati sul set da giugno a settembre, apprezzando ogni istante di quei tre mesi.
Immaginate di avere contato i giorni in attesa della grande uscita, per poter finalmente vedere come è stata montata ogni scena, perché mentre giri sei completamente concentrato sulla tua parte ed è difficile immaginare il risultato finale.
Immaginate di avere organizzato una serata insieme a un po’ di gente del cast, amici e attori, per festeggiare.
E poi immaginate che capiti un evento totalmente assurdo che manda a monte ogni piano: la pandemia globale, che solo a dirlo suona una cosa che, appunto, dovrebbe accadere soltanto in un film. Di fantascienza.
A me è successo proprio questo. Il 29 aprile ero pronto all’uscita di Summertime su Netflix. Ero proprio prontissimo, e invece mi sono ritrovato chiuso in casa, e come me praticamente il mondo intero. Niente proiezione in un cinema, niente eventi.
Ma come fai una festa, se al massimo puoi spingerti fino al cancello di casa?
Con chi esulti? Chi può essere al tuo fianco a emozionarsi con te?
Come lanci l’uscita di un grande progetto in otto puntate, se tutti sono costretti a restare seduti sul divano?
Con la quarantena tutto è diverso. Tutto, tranne le emozioni che provi all’idea che esca la tua prima serie TV. Quelle sono intense e pazzesche, forse addirittura amplificate, perché non puoi lasciarle esplodere con gli amici in tutte quelle situazioni create apposta per celebrare un grande momento della tua vita.
Nei giorni precedenti il fatidico 29 aprile, non avevo idea di che cosa sarebbe successo, per me era una prima volta totale. E lo ammetto, un po’ di ansia mi è venuta. Mi frullavano parecchie domande in testa: “Andrà bene? Male? Piacerò? Il pubblico apprezzerà la serie?”. Il problema è sempre quello: normalmente sarei stato preso da un sacco di impegni, progetti; sarei stato in giro per l’Italia e avrei avuto meno tempo per farmi mille paranoie… e invece così, confinato tra le mura di casa per via del COVID avevo persino troppe occasioni per tormentarmi di dubbi. Un’esperienza potenzialmente stupenda si stava trasformando in una paranoia unica.
E non era solo il lancio di Summertime il problema. Tutto il primo mese in casa è stato duro, in marzo ho vissuto una lotta tra me e la mia testa.
E pensare che io alla pandemia globale ci sono arrivato abbastanza preparato. Cioè, non è stata una sorpresa. Mia madre ha alcuni amici che vivono proprio a Wuhan, dove tutto è iniziato, e quando in Italia si parlava ancora del COVID come di una malattia lontana, come di qualcosa che non ci riguardava davvero, io sentivo le sue telefonate con persone che stavano già sperimentando quell’assurda situazione. Ci arrivavano notizie sulle difficoltà di fare la spesa, su tutte le strane nuove abitudini da imparare per evitare il contagio. A casa ne discutevamo, quindi noi eravamo bene informati.
Razionalmente sapevo tutto ed ero consapevole del fatto che il virus avrebbe potuto diffondersi anche nel nostro Paese, prima o poi. Ma davanti a un evento così enorme, sapere non basta. Non so come spiegarlo: la fantasia non arriva a immaginare che la tua vita sarà completamente sconvolta. Come fai a pensare che accadrà proprio a te?
Dico la verità: l’avevo sottovalutato. Era una minaccia lontana, prima solo cinese, poi circoscritta alla Lombardia. E ho cominciato a prendere la faccenda sul serio solo un pomeriggio di fine febbraio, quando ho capito che mi stava succedendo qualcosa. Avevo freddo, mi sentivo stanco. Quella sera ho provato la febbre: avevo 39 °C e non stavo così a pezzi da tempo. Non riuscivo ad alzarmi dal letto, non riuscivo a mangiare nulla, dormivo e basta. Quel che è peggio, gli antibiotici sembravano non fare effetto. La situazione è perfino peggiorata: ho cominciato a tossire, una tosse sgradevole e profonda. Per dieci giorni sono stato così, e persino mia madre, che è una tipa che tende a essere positiva anche nelle difficoltà, ha cominciato a preoccuparsi. Poi, lentamente, quella strana influenza è passata. La febbre è scesa, ho ripreso a respirare.
Da quel momento, ho cominciato a prendere più seriamente il COVID. Quando al telegiornale ne parlavano, ascoltavo con attenzione; ho cercato di tenermi informato, ogni mattina leggevo le notizie. Volevo sapere che cosa stava accadendo.
A marzo l’ansia è cresciuta: i numeri facevano paura, impossibile ignorarli. Ogni giorno si scoprivano nuovi ammalati. Ero preoccupato, ma ancora sembrava una minaccia che riguardava prevalentemente Codogno e Lombardia; l’esercito, la zona rossa… il COVID era lì, non dove abito io. Infatti, ai primi di marzo ho deciso di partire comunque per quella settimana di vacanza in Trentino prenotata da tempo.
A ripensarci adesso, mi pare assurdo che appena il giorno prima che la quarantena iniziasse io ero sulle piste da sci, e mi sembrava la cosa più normale del mondo. Ho trascorso giornate pazzesche all’aria aperta, senza immaginare che per un po’ non ne avrei più avuto l’occasione. Non avevo il minimo sentore della notizia storica che stava per essere comunicata. Sono tornato a casa giusto in tempo per seguire l’incredibile annuncio: iniziava la quarantena, in tutto il Paese. E improvvisamente il COVID diventava un problema anche mio. Se lo dico adesso quasi mi viene da ridere, ma io all’inizio non l’ho presa male: ho pensato che un periodo tranquillo, a casa, ci potesse stare. In fondo, ero appena stato in montagna.
È bastato poco, però, perché le giornate tranquille cominciassero a non bastarmi. È tornata la voglia di fare, di uscire, di vedere persone, di passare del tempo con gli amici. Casa mia mi è andata presto stretta. Ero abituato a viaggiare, infatti negli ultimi anni trascorrevo pochissimo tempo a casa: cinque giorni su sette ero in giro, sicuro. Raggiungevo gli amici a Milano, stavo a Roma per il cinema, avevo foto da scattare, casting per la moda, a Bologna preparavo provini insieme ai miei due amici gemelli.
Quando improvvisamente mi sono ritrovato confinato tra le mie quattro mura, ho iniziato a starci male. I giorni passavano e io mi sentivo sempre più a pezzi. Ero stanco senza avere fatto nulla, annoiato. Mi sembrava di non avere più una direzione, un obiettivo.
Marzo per me è stato un mese di angoscia e anche paura.
Lo so benissimo che la quarantena è stata dura per tutti, che in fondo si è trattato solo di restare in casa, un sacrificio limitato. Avevamo film da vedere, libri da leggere, telefonate con gli amici, chat, i social. Personalmente nella vita ho anche affrontato situazioni molto, molto più dure. Il problema è che la quarantena a me ricordava proprio il mio passato, mi risvegliava i ricordi di quando per due lunghissimi anni sono stato più in ospedale che a casa, con un batterio potenzialmente letale nello stomaco, confinato in un letto con l’ago della flebo fissa sul polso.
Erano quei ricordi a distruggermi.
Era cominciato tutto con un dolore alla milza che mi aveva preso un pomeriggio di febbraio durante gli allenamenti in campo, alla Imonese. Sentivo male, ma non ci avevo fatto troppo caso. Dopo qualche settimana, però, il dolore era diventato sempre più forte e insistente. Mi ero detto: “D’accordo, adesso devo fare qualcosa”. Continuare a ignorarlo era impossibile. Mi hanno portato in ospedale, dove un’infermiera mi ha fatto sdraiare su una barella. Poi sono arrivati i medici, mi hanno sottoposto a ogni tipo di esame possibile, fino a scoprire la verità: la mia milza era ingrossata in maniera gravissima. Altri due millimetri e sarebbe esplosa. Esatto: la mia milza ha rischiato di esplodere; un’eventualità tragica che avrebbe potuto uccidermi. Poi ho scoperto che la causa di tutto era la mononucleosi, una malattia infettiva. Risolto quel problema, però, continuavo a stare male.
I dottori non riuscivano a curarmi né a capire che cosa avessi. Non c’era una diagnosi. Sono stato un caso di studio a Napoli. Per lunghissimi mesi sono stato prevalentemente solo nel mio letto, incontravo unicamente i medici la mattina, e me lo ricordo ancora quel dolore, che mi teneva sveglio. Quando mi spostavano in isolamento non potevo vedere mia madre anche per settimane intere. Mi mancavano da morire le abitudini più semplici, quelle che finisci per dare per scontate, tipo risvegliarmi tra le mie coperte, a casa mia.
Per due anni quella è stata la mia vita: immobile in una stanza d’ospedale, che è uno dei posti più deprimenti che ci siano al mondo. L’unica evasione che potevo permettermi erano i film. Li guardavo sul mio cellulare, e li guardavo tutti: dalle avventure storiche agli horror. Quando lo schermo si spegneva dopo i titoli di coda, non mi restava che pensare. Pensavo, perché avevo troppo tempo. Riflettevo e ...