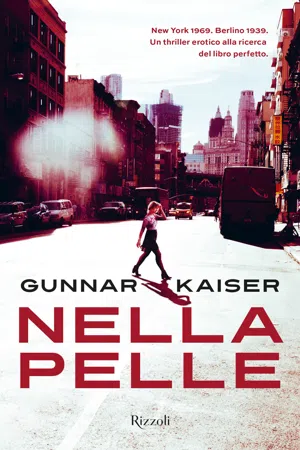Il XX secolo, lo possiamo dire anche se mancano ancora un paio di anni insignificanti alla fine, è stato il secolo degli estremi. Chi non è stato estremo in questo secolo, o era un uomo del passato, o già apparteneva a un futuro non troppo lontano, quello di una generazione tiepida e mediocre che lavora in giacca e cravatta, piena di comodità e di comprensione, i cui esponenti, fatti tutti con lo stesso stampino, guardano chi vive in modo estremo dall’alto in basso, gli occhi socchiusi tra il divertito e lo sprezzante. Questi soggetti, invece, privi di misura e di modelli e di esempi, si sono potuti assicurare un posto nella memoria collettiva del mondo che sarebbe venuto grazie a una inclinazione spirituale dell’uomo per gli eccessi degli eccentrici, degli estremi e degli stravaganti. I nomi di un Mao o di un Hitler, di uno Stalin, un Idi Amin Dada o un Pinochet; di un Pol Pot o di un Suharto, di un Mengele o di un Göth, ma anche di un Čikatilo o di un Fritz Haarmann, sono marchiati per sempre sulla pelle del secolo trascorso, segno perenne della sua scelleratezza.
Nella lista dei cattivi, tuttavia, non si trova il nome dell’uomo di cui vogliamo qui raccontare la storia. Josef Eisenstein infatti fu uno dei mostri più geniali e al tempo stesso meno conosciuti. Tanti suoi contemporanei, se non tutti, lo definirebbero una bestia, un demonio e una creatura infernale; solo in pochi avrebbero forse riconosciuto in lui il genio, che con le sue opere è sopravvissuto, se non al tempo, di certo all’invecchiamento. Se tuttavia nessuno pronuncia il suo nome senza un brivido o un moto di meraviglia – o entrambi – si deve esclusivamente al fatto che le opere e le azioni di quest’uomo furono al contempo tanto orribili quanto geniali: la loro genialità risiede nel loro essere orribili e viceversa, al punto che fu necessario tenerle nascoste al mondo intero – e forse sarebbero rimaste tali per sempre se non tentassimo qui con impertinenza di descrivere una volta per tutte l’inaudito, e di strapparlo all’oblio. Questo destino, quello di non vedere mai le proprie azioni associate al proprio nome, Eisenstein lo condivide con molti, moltissimi mostri – non solo di questo secolo giunto al termine, ma dell’intera storia dell’umanità. Ci sono stati numerosi responsabili di genocidi, crimini di guerra, terrorismo, e ancora carnefici e serial killer e altri mostri, i cui nomi ci sono sconosciuti, anche se sulla loro coscienza gravano la sofferenza e la vita spezzata di innumerevoli vittime – o forse no, non gravano affatto.
Tuttavia… se volessimo esporre qui la storia della sua vita, il lettore non potrebbe fare a meno, già alle prime parole d’introduzione, di segnalare i primi dubbi rispetto alla veridicità del racconto. Anche nel corso della vicenda, possiamo assicurarlo, certi dubbi potrebbero non essere dissipati né placati – un orrore talmente colossale che occorre raccontarlo nei suoi dettagli in nome dello spirito della storia. Qui però assicuriamo, e non per l’ultima volta, che gli elementi della vicenda che si dipanerà davanti agli occhi del lettore nelle pagine a seguire non solo sono riportati con occhio e mano fedele, ma rispondono a una altrettanto alta verità, dato che i dettagli sono sottoposti al vaglio della credibilità che l’essere umano mette in campo di fronte alle più alte opere di ingegno.
La nascita, dunque. O forse no, cominciamo ancora prima. Josef Eisenstein fu infatti concepito nel pieno dei disordini del diciottesimo anno del nostro secolo, tutt’altro che privo di disordini, esattamente la sera dello stesso giorno che vide il Barone Rosso cadere sulla Somme. Quella mattina, più o meno diecimila chilometri a ovest, un giovane si svegliò all’ombra di un albero di susine, sotto il quale la sera prima si era addormentato, stanco del lavoro nei campi. All’alba la rugiada cominciò a formarsi sui fili d’erba e sulle foglie, e poi a gocciolare dai rami del susino. Una di queste gocce era precedentemente venuta in contatto con gli escrementi di una fregata, e portava alcune tracce delle feci dell’uccello nonché gli agenti patogeni dell’influenza. Proprio quella caduta al centro della gola del ragazzo che dormiva con la bocca spalancata. Lui si svegliò all’improvviso, si scosse la terra e la polvere del giorno prima dai calzoni e si avviò verso la casa dei genitori, dove sua madre lo accolse con un meritato carico di legnate.
Il giorno successivo il giovane aveva la febbre alta. Rimase a letto per due settimane e infine l’influenza se lo portò via, non prima però che avesse la possibilità di trasmettere l’agente patogeno alla madre, al padre e al fratello maggiore. Mentre i genitori vegliavano sulla tomba del figlio tre giorni dopo la morte, il fratello maggiore, chiamiamolo Jim, era già partito per un lungo viaggio, dal quale non sarebbe più tornato. La guerra chiamava, e lui aveva risposto. Giunse in Europa dove passò il virus alla maggior parte dei suoi commilitoni e a una prostituta di Amsterdam. Da qui l’influenza, che in seguito fu chiamata «spagnola», perché i primi annunci dell’epidemia furono diffusi dalla stampa spagnola, meno limitata dalla censura. Si supponeva per questo che il focolare della malattia si trovasse nella penisola iberica e che da qui si fosse diffusa nell’Europa occidentale, in Italia, Svezia e poi fino all’Himalaya. Nell’anno 1920, quando l’epidemia sembrava finalmente essersi placata, oltre a Jim, a suo fratello minore e alla prostituta olandese, avevano trovato la morte venti milioni di persone, tre volte più di quelle che perirono nella Prima guerra mondiale.
Più o meno nove mesi dopo quella mattina d’aprile, Josef Eisenstein venne alla luce con un parto breve e indolore, quando l’agente della cosiddetta ondata autunnale era ormai giunto a Weimar attaccando soprattutto i molto giovani e i molto vecchi, i poveri e gli affamati. Giravano voci e superstizioni su come si fosse diffusa l’epidemia, congetture sul pesce avvelenato dai francesi, sulla polvere, sui pigiama leggeri, sulle finestre chiuse o aperte e addirittura sui contatti non protetti con vecchi libri. L’amministrazione cittadina reagì velocemente e ordinò ai suoi collaboratori severe misure igieniche. Il tram rifiutava il viaggio alle persone che non avessero una protezione per la bocca, le scuole furono chiuse, negli ospedali regnava un regime di quarantena. Ponderando la pericolosità della situazione, i futuri genitori di Josef decisero di far nascere il bambino senza assistenza medica nella casa di Parkstraße, alla presenza soltanto della fedele e anziana nutrice Maria, che da parte sua aveva aiutato a venire al mondo già il padrone di casa, futuro padre, così come suo fratello maggiore.
La nascita di Eisenstein ebbe luogo un gelido giorno di febbraio. Per intere settimane aveva fatto così freddo che la fontana di Nettuno sulla piazza del mercato si era gelata, ora però le temperature erano calate al punto che, nel parco, il ghiaccio sull’Ilm era spesso un dito. L’ultimo inverno della guerra aveva preteso le sue vittime, il carbone era finito già da tempo e c’era così poca legna da bruciare che si iniziavano ad abbattere gli alberi nella foresta di Webicht a Tiefurf. Anche nella casa di Parkstraße, dove gli Eisenstein abitavano dal 1912, il combustibile era terminato e si gelava. Faceva così freddo che Maria, la nutrice, aveva messo da parte cinque coperte di lana, due per il bambino e tre per la madre.
Fanny, la madre di Josef, nata Mendel, era tanto felice della nascita del suo virgulto quanto del fatto che, finalmente, le sue sofferenze erano giunte al termine: l’epoca della prigionia babilonese, così descriveva, scherzando ma non del tutto, la sua gravidanza. Si sentiva, infatti, prigioniera fin dal giorno in cui l’avevano informata delle sue condizioni – prigioniera di un figlio non ancora nato, che aveva cominciato la propria vita mettendo fine alla sua. Una vita a stento cominciata, del resto: Fanny Mendel, infatti, era molto giovane. Già prima della guerra, a sedici anni, aveva raggiunto considerevoli successi sul palcoscenico, e ora sperava, anzi si aspettava, che con la fine della guerra la sua carriera sarebbe proseguita senza intoppi, o che addirittura si sarebbe impennata verso sfere ancora più elevate. Ora, nel pieno dell’estate, quando anche i nazionalisti più ostinati intuivano la sconfitta del Reich, ora che la pace era vicina, che la normalità sarebbe stata ripristinata e tutti avrebbero ripreso a sciamare nei teatri, affamati dopo anni di privazione di divertimenti e di varietà, ora Fanny avrebbe potuto realizzare il suo sogno di ragazza ed emergere come una nuova stella del firmamento.
Quanto doveva essere delusa, nonostante la gioia di divenire madre, quando le fu comunicata la lieta notizia. C’era questa circostanza disturbante, questo essere che annunciava il proprio diritto all’esistenza nel momento meno opportuno, un essere umano che minacciava di annichilire i suoi sogni. Una volta madre, intuiva, non solo sarebbe stata meno flessibile per quanto riguarda le offerte provenienti dai grandi teatri, ma anche la sua desiderabilità sarebbe diminuita non appena il pubblico l’avesse percepita come la matrona che era e non più come l’amazzone giovane e vergine. Per non parlare degli inconvenienti che la gravidanza infliggeva al suo corpo. Sarebbe stata costretta a continuare a portare il corsetto, a dimenticare la sua agilità adolescenziale, a sostenere il seno svuotato e a nascondere il suo décolleté grinzoso.
Ben lontana dal pensiero di porre fine prematuramente alla gravidanza, si tastava qua e là nel silente desiderio che il bambino fosse disabile o gravemente malato, così che tale necessità sarebbe apparsa naturale. «L’uomo» era solita citare Humboldt, «deve aspirare al Bene e alle cose grandi! Il resto dipende dal destino.»
Tuttavia, in quei momenti che trascorreva nella sala di lettura senza far nulla, incapace di qualunque occupazione sensata, si ricordava che il matrimonio con il professor Samuel Josef Cahn Eisenstein, fin dal primo giorno, un’afosa giornata di luglio del 1914, comportava che presto avrebbe dato alla luce dei bambini. E se fosse stato soltanto uno, allora il fato poteva essere considerato piuttosto benevolo. Doveva dunque fare in modo che suo marito non avesse occasione di darle un altro bambino in un momento inopportuno. Forse così le sarebbe stato concesso, nonostante la maternità e il corpo sfigurato, di continuare la sua carriera.
Non che non amasse il marito, ma lo amava per via del suo denaro. Tuttavia dal giorno della notizia, Fanny vide rapidamente svanire tutte le possibilità che il matrimonio con il famoso e agiato professore le promettevano. Comunque: infine, la mattina del sei febbraio, Fanny Eisenstein, nata Mendel, fu felice di vedere il suo primo e – come si scoprirà in futuro – ultimo figlio. Vederlo, si fa per dire, perché quando tastò quel corpicino e si rese conto che era freddo come quello di un bimbo nato morto, e che non si riscaldava a contatto con il suo, la ragazza spossata dalla fatica del parto e dal freddo tagliente della casa riuscì a dedicare al proprio piccolo solo una rapida occhiata. Era felice, dunque, e passò il fagotto urlante alla nutrice, che lo lavò, asciugò, avvolse nelle coperte di lana e lo portò nella stanza accanto. Qui, in questo spazio fin troppo grande, dalle dimensioni di un salone, quasi, Maria depose il poppante nella sua culletta, dove finalmente si calmò.
Fanny, che non percepiva le urla del figlio dietro la doppia porta chiusa, non vedeva l’ora di mostrare al marito, non appena fosse rientrato in città, il piccolo Josef. Fino ad allora aveva considerato suo preciso obbligo curare la propria bellezza e salute, così si avvolse nelle tre coperte e si addormentò.
Il padre di Josef Eisenstein in quel momento stava tracciando un ampio arco intorno alla città, contando le bucce di patate nelle tasche del cappotto. Era di ritorno da Jena, dove aveva appena annunciato le sue lezioni per il semestre estivo. Era arrivato con il treno di mezzogiorno alla stazione e stava scegliendo un tragitto per raggiungere il centro, invece di andare dritto per la Carl-August-Allee, come era solito fare, e prendere poi la Wieland e la Schillerstraße e di lì la proprietà dove la sua famiglia viveva da generazioni. Samuel Josef Cahn Eisenstein, infatti, professore di linguistica all’Alma Mater di Jena, apparteneva a una famiglia le cui radici weimariane risalivano al 1770, al giorno in cui Anna Amalia nominò ebreo di corte del principato un commerciante di Schwanfeld. Era un discendente di una cugina del commissario e banchiere granducale che aveva rifornito d’argento la corte. Suo bisnonno, si diceva, aveva aiutato il vecchio Goethe nella sua ultima camminata sul Kickelhahn, e suo padre, nell’Anno Domini 1774, aveva collaborato alla ricostruzione della casetta di Goethe, distrutta un paio di anni prima da un incendio. Samuel non aveva dato alcun contributo alle attività bancarie della sua famiglia. Al momento della nascita del figlio era un uomo di scienza conosciuto nella cerchia degli addetti e assai stimato anche all’estero, un trentanovenne professore di linguistica generale e comparata, coautore del Dizionario etimologico indoariano, opera fondamentale nel ramo ancora giovane della linguistica storica. La sua fama, tuttavia, echeggiava oltre le porte della città natale non soltanto per l’attività scientifica: i servigi resi da ufficiale gli erano valsi nel 1916, tra altre onorificenze, anche la croce di guerra di Guglielmo Ernesto; la sua attività politica di consigliere comunale di Weimar gli aveva assicurato un posto nel Consiglio regionale, e non solo. A partire dal novembre precedente si era impegnato con successo, attraverso missive inviate a Berlino e incontri di persona, per candidarsi alle elezioni dell’assemblea nazionale, e non aveva le peggiori chance. Quando nel gennaio la scelta della località del congresso ricadde proprio sulla sua città natale, era fuori di sé dalla gioia – cinque giorni dopo, tuttavia, durante la distribuzione dei seggi, i voti per il suo partito non erano bastati per un pelo per farlo entrare nella lista.
Per due intere settimane il professor Eisenstein lottò con se stesso e con il mondo, tirando in ballo complotti e intrighi. La mattina di cui qui si parla, tuttavia, decise di non dare all’intera faccenda più peso di quanto non meritasse. Se la repubblica pensava di poter rinunciare a uomini come lui, allora, stando alle previsioni, non avrebbe avuto lunga vita. Egli, invece, si sarebbe nuovamente dedicato allo studio e alla cura della sua vita sociale. Già a marzo poté ancora una volta ricacciare fuori i suoi vecchi scritti, perché era tornato troppo tardi dalla Francia per poter preparare una lezione completamente nuova. Allora avrebbe finalmente rimesso mano al suo progetto, da tempo in lavorazione, di una nuova, fondamentale Storia della lingua tedesca.
Lo irritava anche la confusione che stavano facendo a Weimar e che quel giorno lo costrinse ad allungare il tragitto verso casa. Polizia a ogni angolo, gli inviati dei quotidiani della capitale, e poi l’esercito grigio dei deputati. Camminava scuotendo il capo, superando i capannelli degli onorevoli cittadini in colletto inamidato e di qualche imbecille dell’accademia, per arrivare alla piazza del teatro nazionale, dove dodici brigadieri in elmetto presidiavano la scalinata. Infine entrò allo Schützen, un locale che da quando si aveva memoria spillava birra per i cocchieri della piazza del teatro. Qui ordinò una tazza di tè e incaricò un ragazzo di portargli la legna che da giorni aveva richiesto in Parkstraße. Il garzone, tuttavia, un birbante di nemmeno dodici anni, non era, come il professor Eisenstein ebbe modo di constatare presto, in salute. Tossiva e respirava affannosamente, a tal punto che il professore fu quasi tentato di togliergli l’incarico, di schiacciargli in mano le bucce di patate pattuite e di trasportare da solo a casa il fascio di legna. Ormai non riusciva più a resistere a questo moto della coscienza, ma erano già quasi arrivati all’angolo della Frauenthor e vedevano la facciata ricoperta di fregi della residenza degli Eisenstein. Il professore fece deporre al poveretto il carico davanti al portone, l’avrebbe portato in casa lui stesso.
Arrivato nelle stanze del primo piano, Eisenstein sudava per lo sforzo, al quale il suo esile corpo di uomo di cultura non era abituato. Sudava così tanto che, contro ogni ragionevolezza, pensò per un attimo che il ragazzo potesse averlo contagiato e che la malattia fosse già scoppiata – un tempo d’incubazione di cinque minuti, scherzava tra sé e sé, attenzione! Ciononostante, che la sua stanchezza fosse un sintomo normale o meno, restava il rischio che quel ragazzo avrebbe potuto contagiarlo con tubercolosi, peste pneumonica o la stessa influenza di cui soffriva da sette giorni mezza Weimar. Decise quindi di salutare la moglie solo da lontano. Quando l’intravide che dormiva nel suo letto, si ricordò delle sue condizioni ma in quel momento Maria, che gli aveva tolto la legna dalle mani, gli comunicò la lieta notizia. E così fece visita al suo figlio neonato, meticolosamente attento a non entrare in contatto né con la nutrice né con il piccolo, che gli apparve, in quell’angolo in fondo al salone, come una larva che si è trasformata in crisalide. Non si avvicinò oltre i dieci passi. Il bambino si trasformerà presto in una farfalla, si disse. Poi si diresse con una faccia soddisfatta verso il suo studio e si mise al lavoro.
Quel giorno, dunque, Maria fu l’unica a toccare il corpo bisognoso di cure di Josef, dopo che questi aveva lasciato il ventre della madre. E fino a quando l’influenza infuriò nel Paese, le cose restarono così.