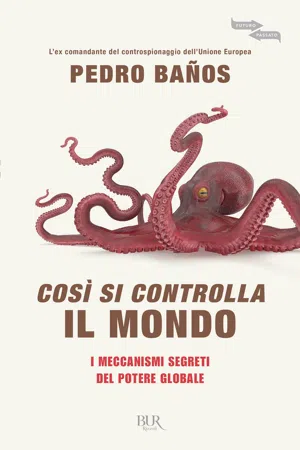Per capire il significato attuale del termine «geopolitica» non è sufficiente andare a cercare tra le sue tradizionali accezioni. Pur senza ignorarle, è necessario fare un passo avanti e inserirle in modo corretto nell’ambito del vigente contesto mondiale.
Secondo la visione classica, gli avvenimenti politici si potevano capire, interpretare e persino giustificare in base al loro legame con le posizioni geografiche e gli antecedenti storici. Questo punto di vista accetta l’esistenza di una serie di costanti geopolitiche che fanno da cornice, in maniera immutabile e imperitura, al manifestarsi di eventi che si ripetono dai tempi passati al presente.
Senza disdegnare una simile approssimazione, la geopolitica odierna esige una prospettiva più ampia e profonda. L’innegabile fenomeno di globalizzazione e la crescente interdipendenza tra le nazioni hanno fatto sì che la geopolitica sia passata dall’essere unicamente limitata alla terra – il prefisso «geo» la collega a un determinato territorio, a uno spazio fisico concreto – a riferirsi alla Terra, intesa come l’intero globo terracqueo. Di conseguenza, persino le nazioni più piccole sono costrette a stabilire la propria strategia geopolitica, perché quasi tutto ciò che accade nel resto del mondo può in qualche modo avere delle ripercussioni anche su di loro. Anzi, ormai ne ha addirittura sullo spazio esterno al pianeta: il bisogno di cercare nuove risorse ed energie, o banalmente luoghi in cui sistemare una popolazione in crescita in una superficie terrestre sempre più depauperata, fa sì che la moderna geopolitica si interessi anche alle dimensioni extraterrestri.
D’altro canto, l’espressione «geopolitica» ha assunto un’accezione più dinamica, essendo diventato imprescindibile approfondire non solo lo studio del passato e del presente, ma anche cercare di «prevedere» il futuro. Capendo come si dipaneranno gli eventi nei prossimi anni, saremo in grado di pianificare azioni vantaggiose per i nostri interessi, che devono essere quelli dell’intera umanità.
Nel dizionario della Real Academia Española, le prime due accezioni della parola «politica» offrono spunti piuttosto interessanti. La prima la definisce come «arte, dottrina o opinione riferita al governo degli Stati», la seconda come «attività di quanti gestiscono, o aspirano a gestire, la cosa pubblica», il che si potrebbe tradurre come l’aspirazione a reggere i destini dei propri simili.
Quindi, si potrebbe definire la geopolitica attuale come l’attività svolta allo scopo di influenzare le vicende della scena internazionale, intesa come l’aspirazione a esercitare la propria influenza su scala globale, evitando, al tempo stesso, di lasciarsi condizionare. Si potrebbe persino definire come l’attività svolta da quanti si prefiggono di reggere i destini del mondo (o almeno di una vasta parte di esso), cercando di impedire che altri attori internazionali governino il proprio, in modo che nessuno possa intromettersi nelle decisioni dei primi.
Nonostante questa novità a livello terminologico, la geopolitica resta strettamente legata agli aspetti geografici (quelli meno soggetti a cambiamenti), siano essi elementi concreti, come catene montuose o corsi d’acqua, o relativi alla popolazione che vive in un determinato luogo, passando per le diverse risorse naturali (energetiche, minerarie, idriche, agricole, ittiche e così via). Non bisogna però dimenticare che la geopolitica agisce anche su fattori meno tangibili, ma non per questo meno importanti, quali sono l’economia e le finanze.
E proprio per abbracciare uno spettro così ampio, la neonata geografia politica è allo stesso tempo generatrice delle altre politiche nazionali, che racchiude in sé. Poco, o meglio quasi nulla, di ciò che accade in un Paese è completamente svincolato dalla situazione internazionale, dalle tendenze mondiali dominanti e dai rischi comuni. In un simile panorama su scala planetaria, dove la complessità e la confusione non fanno che aumentare, per chi prende decisioni a carattere geopolitico diventa sempre più imprescindibile avere a disposizione informazioni precise in modo da comprendere il più possibile le prospettive future.
All’interno del processo di determinazione delle direttrici geopolitiche (il «cosa»), si devono in primo luogo definire i bisogni e gli interessi dello Stato (i «perché»). Saranno poi elaborate le strategie pertinenti, trasformate in geostrategie, ovvero i procedimenti, le azioni e i mezzi che servono per soddisfare i fini geopolitici (il «come» e il «con cosa»). In altre parole, la geostrategia è l’elaborazione e la messa in atto delle linee d’azione per raggiungere gli obiettivi indicati dalla geopolitica.
Il mondo è come il cortile di una scuola
In tutte le scuole del mondo ci sono bambini e bambine che gestiscono la propria piccola cerchia di compagni. Sono i dominatori di una classe o di un’intera scolaresca, noti, rispettati e temuti da tutto l’istituto. Questo ordine di potere scolastico si percepisce soprattutto nei cortili durante la ricreazione, quando gli alunni si mostrano così come sono, liberi dalla tensione delle lezioni. Lì si distingue chiaramente chi ha la capacità di influire sugli altri, prerogativa che può derivare da una o più circostanze: forza fisica, innata capacità di leadership, abilità sportive, appartenenza a una famiglia importante, lingua lunga e biforcuta, abilità nell’accattivarsi gli insegnanti… o pura malvagità unita all’astuzia.
I bambini capaci di esercitare un particolare ascendente sugli altri possono influenzare il gruppo in positivo, esortandolo a comportamenti corretti e gesti nobili. Spesso, invece, si dedicano alle imprese più dissennate, sono i promotori di attività di cui i professori non sono al corrente e che violano le regole della scuola, o, peggio, i bulli che aggrediscono psicologicamente e fisicamente i compagni più vulnerabili, perché meno dotati o di aspetto meno gradevole.
Chi si comporta così di solito tende a circondarsi di altri bambini che cercano protezione e apprezzamento oppure la forza che a loro manca del tutto (o ritengono essere inferiore a quella dei leader ai quali si sottomettono). Sono quelli che sghignazzano delle «imprese» dei più forti, che li sostengono quando compiono perfidi soprusi a danno dei più deboli e applaudono alle loro dimostrazioni di potenza e abilità fisica. In sintesi, preferiscono sacrificare una parte della propria personalità pur di entrare nella corte di adulatori, cosa che assicura un certo status e considerazione.
Ovviamente, per giustificare il loro comportamento, il leader e il suo seguito devono avere intorno altri alunni che considerano inferiori. Alcuni vengono semplicemente ignorati perché non fanno parte dell’élite o perché non eccellono negli sport più popolari della scuola. Altri, purtroppo, diventano il bersaglio dei dardi crudeli lanciati da chi si sente superiore. Se poi i malcapitati sono anche bravi studenti, l’ira del gruppo si abbatterà su di loro per evitare che possano distinguersi e mettere in discussione la presunta superiorità dei più forti. Alcune di queste vittime, quelle più fragili a livello mentale o che non hanno un adeguato appoggio familiare, possono subire danni irreparabili da queste angherie. È possibile anche che tra loro ci siano elementi che aspirano a far parte del gruppo dei bulli, in modo da non essere più presi di mira. Sfortunatamente, quando ciò avviene, questi possono trasformarsi nei componenti più crudeli del gruppo verso chi non ne fa parte.
Ma c’è anche chi oppone resistenza, con risultati più o meno efficaci, a lasciarsi influenzare dal leader o dalla pressione di tutto il gruppo. O chi, a sua volta dotato di un certo potere, non desidera far parte della cricca né esercitare la benché minima influenza, e si accontenta di vivere la propria vita, essere rispettato e mantenere le distanze dai comportamenti impropri dei compagni. Talvolta potrebbe anche essere interessato a un’alleanza momentanea con il potente di turno, ma in genere si gode la sua indipendenza. Infine, ci sono quelli che non desiderano altro che isolarsi, senza prendere parte ad alcuna attività, positiva o negativa. Questi di solito hanno un atteggiamento forte e reagiscono con decisione se qualcuno prova a insultarli.
Il discorso vale per qualsiasi collettività i cui membri trascorrono tante ore insieme, come una caserma, una prigione o un luogo di lavoro. E qualcosa di simile avviene anche in campo internazionale, dove ci sono potenze con diversi gradi di capacità di influenzare le decisioni mondiali.
L’ipocrisia: il principio che regge la geopolitica
Non c’è nulla di più ipocrita e crudele della politica internazionale, perché tutto ciò che decide e realizza si basa esclusivamente sugli interessi di ciascun Paese, sempre effimeri e mutevoli e che hanno ben poco, o quasi niente, a che fare con gli altri Stati. Anche la politica nazionale è spietata e fratricida, priva di attenzione verso l’avversario politico: qualsiasi misura venga adottata contro di lui è considerata legittima a patto che serva a indebolirlo e a estrometterlo dal potere, all’unico scopo di prenderne il posto. Tuttavia, si suppone che tutti i gruppi politici – anche i più dissimili – perseguano lo stesso fine e interesse, ovvero il bene dei propri cittadini e della propria nazione, benché ognuno lo interpreti con un approccio diverso a seconda dell’ideologia a cui si ispira.
Ma nell’ambito internazionale, in cui si muove la geopolitica, non vi è alcun fine comune, almeno non permanente, che possa bloccare gli istinti più bassi, nessuna brace sempre viva che faccia da fattore di coesione. Gli interessi comuni sono talmente «deperibili» che si alterano in fretta e vengono sostituiti da altri, per cui alleanze, amicizie e inimicizie fluiscono a una velocità paradossale e sorprendente. Si vive in un perenne stato di rivalità in cui tutte le parti sgomitano per farsi spazio e far prevalere i propri interessi.
Nemmeno i pericoli o le minacce che si potrebbero considerare condivisi – come quelli derivanti dal cambiamento climatico – esercitano una reale influenza, perché in questo particolare ambito ogni Paese guarda unicamente al proprio interesse. Non solo: più un Paese è potente, meno si preoccupa dei bisogni delle altre nazioni. Per quanto possa sembrare banale, per far sì che tutti gli Stati adottino decisioni comuni di cui potrebbe beneficiare l’intera umanità, dovrebbe esserci una minaccia extraterrestre, come un’invasione o qualcosa del genere. Intanto, come è accaduto in passato, e come continuerà ad accadere, ogni Paese guarderà a se stesso e agirà per il proprio bene, anche quando è pienamente consapevole dei danni, diretti o indiretti, che può causare agli altri.
Così lo storico militare Michael Howard riassume l’altissimo livello di ipocrisia su cui si basano le relazioni internazionali, sempre rette, orientate e regolamentate dai potenti: «Spesso gli Stati che mostrano maggiore interesse per il mantenimento della pace sono quelli che possiedono più armi».
Il gioco delle influenze
In campo internazionale coesistono potenze con diversi gradi di influenza nelle decisioni mondiali. Di base, si può affermare che esistono due tipologie di Paesi: dominatori e dominati. I primi esercitano il proprio controllo a livello locale o globale. Quelli che sono sottomessi possono esserlo in maniera più o meno diretta e in diversi ambiti (militare, economico, culturale, tecnologico eccetera) e accettare più o meno bene la propria condizione, a volte persino con rassegnata passività. Se è necessario, possono farsi soggiogare dai più potenti per essere rispettati e persino temuti.
I Paesi che, per un qualsiasi motivo, non si sentono potenti – un punto cruciale potrebbe essere disporre o meno della bomba atomica – cercano di proteggersi rifugiandosi sotto l’ala di una potenza superiore che, almeno in teoria, possa garantire loro sicurezza e immunità. È quello che offrono le potenze nucleari, in termini di mezzi puramente strategici, così come fanno i membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dinanzi a ipotetiche sanzioni internazionali. È così che ha agito la Cina con il Sudan e il suo presidente Omar al-Bashir, rimasto al suo posto fino al golpe militare dell’aprile 2019 che lo ha destituito, nonostante la Corte penale internazionale abbia emesso, nel marzo del 2009, un ordine di arresto per crimini contro l’umanità e crimini di guerra in conseguenza della violenza scatenata nel Darfur. Il presidente al-Bashir era certo di essere intoccabile finché fosse rimasto sotto l’egida della Cina. Pechino offre questo «servizio» anche ad altri Paesi durante i processi negoziali, attuando la strategia win-win, un sistema negoziazione apparentemente trasparente in cui vincono entrambe le parti. Per esempio, nei suoi rapporti con il Sudan, Pechino ha ottenuto accesso al greggio e ai terreni coltivabili del Paese. Avendo il vantaggio di non essere stata una potenza coloniale, la Cina non incute, soprattutto in molti Stati africani, la stessa diffidenza di altre potenze rivali.
La Siria è un esempio di come uno Stato debole attaccato da uno più belligerante si veda costretto ad appoggiarsi a un terzo, il forzuto di turno. Il presidente Bashar al-Assad ha dovuto accettare l’aiuto della Russia – che ovviamente perseguiva i propri interessi – per evitare di perdere il potere quando le sue forze vacillavano sotto la pressione dei ribelli appoggiati dagli USA e da altri Paesi mediorientali e occidentali.
D’altro canto, un Paese che ritiene di non avere abbastanza peso o ascendente, a livello locale o mondiale, si allea con altri per avere una maggiore...