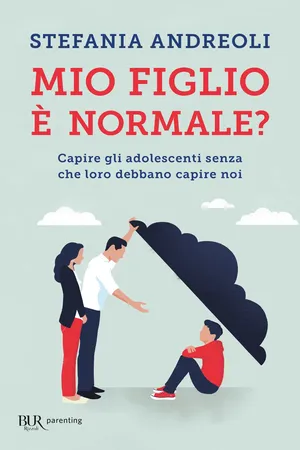
eBook - ePub
Mio figlio è normale?
Capire gli adolescenti senza che loro debbano capire noi
- 352 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Genitori che fanno fatica, allergici a ogni forma di ribellione filiale, preparatissimi eppure inspiegabilmente inesperti circa la normalità di come sia fatto un essere umano lungo la linea evolutiva: sono coloro che chiedono aiuto in seduta, ma anche sui social e in radio, a Stefania Andreoli, una delle più importanti terapeute dell'adolescenza, davanti alle trasformazioni dei figli, che incutono la paura di aver sbagliato tutto. E ancor più in questa epoca, quella in cui gli "adolescenti" sembrano essere scomparsi, non avendo spesso ricevuto regole da trasgredire da chi avrebbe dovuto dargliele, saltando così il tradizionale passaggio all'autonomia e alla responsabilità, ossia all'età adulta. In questo libro provocatorio e al tempo stesso tranquillizzante, l'autrice propone un'idea funzionale di adolescenza, analizzando i diversi ambiti in cui si manifesta (dalla scuola all'amore, al sesso, ai progetti per il futuro) e risponde alle domande che quotidianamente le vengono poste da padri e madri disorientati e confusi, che spesso faticano a distinguere un adolescente "fisiologico" da un figlio che invece ha bisogno di aiuto.
Uno strumento prezioso per accompagnare l'evoluzione dei figli senza perdere la testa e per intervenire solo quando ce n'è davvero bisogno.
Uno strumento prezioso per accompagnare l'evoluzione dei figli senza perdere la testa e per intervenire solo quando ce n'è davvero bisogno.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Mio figlio è normale? di Stefania Andreoli in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
eBook ISBN
9788831800501PARTE 1
ADOLESCENZE, ADOLESCENTI ED ETÀ ADULTA
1
Cosa va saputo dell’adolescenza
Ma ’sta adolescenza, dovevano inventarsela per forza?
MARTINA, 17 ANNI
Adolescenza e adolescenti: sono sempre esistiti?
Così come è stato anche per l’infanzia, gli studiosi si sono posti una domanda che ci interessa ancora oggi: l’adolescenza l’abbiamo scoperta, oppure è il frutto di un brevetto originale?
Come è andata? Seguendo la prima ipotesi, dovremmo supporre che a un certo punto ci siamo accorti che durante una determinata fase dello sviluppo, corrispondente a un riconoscibile segmento anagrafico, gli esseri umani apparivano diversi da come erano stati fino a quel momento da bambini e altrettanto differenti da come sarebbero stati dopo in quanto adulti. Ne abbiamo osservato da vicino le caratteristiche, le abbiamo estese alla popolazione generale, abbiamo assistito alla replicabilità del fenomeno e, una volta riconosciuto come tale, gli abbiamo dato un nome.
Nel caso della seconda ipotesi, al contrario, ci saremmo inventati l’adolescenza di sana pianta. Chi sarebbe stato? Quando? A quale scopo? Il mistero si infittisce.
Vediamo: nella più rosea delle interpretazioni, si sarebbe trattato di una trovata utile a spiegare (qualora sia stata una pensata degli adulti) la natura difficile del rapporto con i giovani e le giovani in un certo momento di passaggio della loro crescita, che rendeva spesso complesso avere a che fare con loro – giacché non essendo più bambini, non si lasciavano più assoggettare tanto facilmente – come a presupporre che, di fondo, il problema fosse proprio l’età. O, comunque, che il problema fossero loro.
A inventare l’adolescenza, tuttavia, potrebbero anche essere stati degli adulti non così generici: gente senza scrupoli che voleva lucrarci, costruendoci sopra un business… Gli psicologi! Gli educatori!
Terza ipotesi teorica: e se l’adolescenza l’avessero inventata i bambini, per gioco? Come ultima burla prima di fare sul serio.
Da ultimo: l’adolescenza l’hanno forse inventata gli adolescenti? Ragioniamo: avrebbero un movente, ovvero la giustificazione ideale per una serie di comportamenti istintuali, dissennati, irresponsabili, immaturi e – una volta su due – goderecci. Chiamare in causa uno specifico periodo della vita che attraversano tutti, e che dunque è universale, sarebbe diventato un alibi eccellente con cui fronteggiare la deplorazione sociale.
Venite con me: per trovare le risposte alle domande importanti dobbiamo tenere presente la storia dell’evoluzione e del funzionamento di tutti gli esseri umani, per non perdere le proporzioni dell’individuo.
Nutrirsi al banchetto della vita
I giovani sono inclini al desiderio e portati a fare ciò che vogliono. Tra i desideri del corpo sono inclini soprattutto a quelli erotici e sono incontinenti al riguardo. Sono ambiziosi e vivono la maggior parte del tempo nella speranza; infatti, la speranza è relativa all’avvenire e per i giovani l’avvenire è lungo mentre il passato è breve… Non sono di cattivo carattere, ma di buon carattere, perché non hanno ancora visto molte malvagità, e sono facili a convincersi perché non sono ancora stati ripetutamente ingannati. E sono portati a sperare anche per il fatto che non hanno ancora subito molti insuccessi. Inoltre sono magnanimi, perché non sono stati ancora umiliati dalla vita. Preferiscono compiere belle azioni piuttosto che azioni utili, poiché essi vivono più secondo il loro carattere che non secondo il calcolo; sono amanti della vita sociale e peccano sempre per eccesso e per esagerazione; essi infatti fanno tutto con eccesso: amano all’eccesso, odiano all’eccesso.1
Era il IV secolo a.C., quando Aristotele scriveva queste parole nella sua Retorica. Il testo originale in greco antico non parla di «adolescenti», ma la questione è squisitamente etimologica: la parola non era ancora stata inventata.
Di fatto però Aristotele, tra le tante cose su cui aveva visto lungo, descrive i ragazzi con contezza, usando definizioni che potrebbero essere state scelte l’altro ieri: soggetti antropologici che rispondono edonisticamente più al guizzo del momento che non in considerazione delle conseguenze dei loro gesti. Governati dalla lingua del corpo, che reagisce senza riuscire a fare resistenza ai canti di sirena del sesso. Smaliziati, bendisposti, in certa misura ingenui. Programmati per vivere naturalmente la dimensione della comunità insieme ai loro simili e, nel bene e nel male, esagerati.
Ma c’è un messaggio in filigrana tra le parole del grande filosofo che mi interessa particolarmente: egli racconta i giovani come innocenti, non colpevoli. Non hanno ancora visto molte malvagità: ovvero, non hanno ancora assistito allo spettacolo del male che, se non loro, e certamente non i bambini, chi vedrà mai protagonisti sulla scena?
Non sono nemmeno ancora stati ripetutamente ingannati, né umiliati dalla vita e infine non sono opportunisti: non vivono in base ai principi di utilità e calcolo. Come invece fa… chi?
Sembra proprio che, per esclusione, rimangano gli adulti.
Emerge dal testo di Aristotele un’idea dei giovani nobilmente generosa, tale per cui le caratteristiche positive che li rendono riconoscibili le possiedono perché non sono ancora stati contaminati da quelle negative dell’adultità, oppure perché la vita non gli si è ancora parata di fronte con tutto il suo potenziale di cinismo, crudeltà, ingiustizia.
Per converso, le peculiarità che potrebbero far risuonare un’eco negativa non riescono a far loro cattiva pubblicità, perché Aristotele le dà come strutturali, elementi di stretta qualità descrittiva: cosa vuole farci, signora mia, sono fatti così. So’ ragazzi.
Dicevamo che il termine «adolescenza» ha origini più tarde dal latino: forse non tutti sanno che adolescens è il participio presente di adolescere, un verbo costituito da alere (nutrire), rafforzato da ad. La traduzione letterale descrive dunque l’adolescente come «colui che si sta ancora nutrendo», mentre l’adulto (participio passato del medesimo verbo) è «colui che si è già nutrito».
Personalmente trovo questo breve cenno etimologico una vera e propria gemma: che delizia il riferimento al banchetto della vita e dell’esperienza, cui i ragazzi devono ancora attingere e legittimamente si servono! Che bella questa immagine riferita alla tavola imbandita per tutti coloro che ancora debbono riempirsi la pancia, assaggiare di tutto un po’, scegliere, magari abbuffarsi o, all’esatto contrario, rinunciare restando un po’ indietro. Quanto trovo precisa l’idea intrinseca che debbano avere la precedenza, poiché quel che c’è è lì per loro: ne facciano ciò che credono.
Per converso, resta inteso che gli adulti non rimangono certo a morire di fame: loro sono sazi, hanno già mangiato. Diventano piuttosto essi stessi frutti maturi da cogliere e di cui nutrirsi, ancora più appetitosi quando si fanno da parte senza imporsi, lasciando che tra tutto ciò che c’è a disposizione essi siano solo alcune delle opzioni possibili, non l’unica, non necessariamente quella da prediligere.
Quel che è certo è che per i latini gli adolescenti erano coloro i quali stavano ancora diventando grandi (compiendo la loro formazione in senso lato nel riempirsi sia di abilità e conoscenze sia di energie per diventare grandi nel corpo e nello spirito), mentre gli adulti erano coloro i quali erano ormai cresciuti.
È ancora oggi così?
Per una visione univoca dell’adolescenza
Se fu soltanto verso la fine dell’Ottocento che cominciò ad affermarsi robustamente l’idea che l’adolescenza fosse una fase della vita che poneva problemi di natura psicologica, il vero «padre dell’adolescenza» può di fatto a buon diritto essere considerato lo psicologo e pedagogista statunitense Stanley Hall.
Hall teorizzò per primo in via definitiva che l’adolescenza esistesse da ben prima del suo Adolescence: its psychology and the relation to physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion and education del 1904, al netto della scarsa considerazione che poteva avere avuto in certe epoche o presso determinate culture.
Lo studioso ebbe il merito di attribuire all’adolescenza (il cui connotato biologico anticipato dall’età puberale non poteva da sempre considerarsi altro che un fatto) una squisita qualità psicologica, ovvero una componente che indissolubilmente lega il periodo anagrafico di riferimento alla concezione che l’individuo costruisce di sé al crocevia tra le sue azioni e il suo mondo interiore, e l’idea che di essa conseguentemente se ne fanno la società e la subcultura di appartenenza.
Il fatto che prima di questo momento gli adulti non pensassero alla questione nei termini di una fase evolutiva delicata della vita, di un’età di trasgressione dell’ordine costituito, insomma, non è sufficiente per dire che non lo fosse.
A mio modo di vedere la faccenda sta precisamente in questo passaggio.
Diversi storiografi e storici sociali hanno ritenuto che ciò che di epoca in epoca ha subito un mutamento in relazione al concetto di adolescenza siano stati, in sintesi, i modi di diventare adulti e gli scopi formativi da porsi al termine di questa fase.
Personalmente, non sono d’accordo: alla fine dell’adolescenza, altro non c’è che l’età adulta, qualsiasi cosa si intenda di epoca in epoca e di cultura in cultura con questo.
Sono più dell’idea che ciò che ha segnato il passo nella storia dell’uomo e nella concezione delle teorie evolutive e degli stadi di sviluppo sia stata la sensibilità e la capacità degli adulti di comprendere e di conseguenza creare un racconto su come fossero, siano stati e siano gli adolescenti: come funzionino, che peculiarità abbiano, a quali compiti di sviluppo siano chiamati e con quali mezzi sappiano, possano, debbano o cerchino di portarli a termine.
Nel nostro momento presente, per esempio, abbiamo scarsissima contezza di come siano fatti tanto i piccoli quanto i giovani della nostra specie.
Vogliamo infatti spingere all’autonomia e alla precoce socializzazione bambini piccolissimi che sono e fanno i bambini, chiediamo loro di bruciare le tappe di sviluppo: prova ne è il fatto che io riceva continuamente quesiti dubbiosi riguardo il mantenere o meno il pannolino a due anni, oppure richieste accorate (per non dire angosciate) su come togliere il ciuccio (che peraltro abbiamo inizialmente proposto proprio noi genitori) a un bambino che va ancora all’asilo nido («Ha preso il vizio, dottoressa!»).
È come se dai nostri piccoli ci aspettassimo che non abbiano troppo bisogno di noi, che si rendano autonomi, che vadano anzitempo fuori dalla famiglia per «svegliarsi» e «imparare in fretta».
Salvo poi riprenderceli, una dozzina di anni dopo, legandoli a doppio filo alle gambe del tavolo per farli stare lì con noi, non farli andare incontro ai pericoli, poterli controllare, sentendo di svolgere in questo modo il nostro dovere di supervisori.
Ed ecco che mi sembra (per quanto resti incondivisibile) almeno spiegato perché, a settembre del 2019, decine e decine di giovani del biennio delle superiori (tra i quattordici e i sedici anni, per agevolare i calcoli: un’età in cui anche per la legge i ragazzi possono essere lasciati soli) mi hanno detto di non avere avuto il permesso dai genitori di prendere in pieno giorno i mezzi e raggiungere il centro di Milano, per partecipare alla manifestazione pacifica indetta per sensibilizzare l’opinione pubblica contro il cambiamento climatico.
Per ritornare dunque al quesito iniziale sulle origini dell’adolescenza, io sono certa dell’idea che da che mondo è mondo i bambini prima e gli adolescenti poi siano un prodotto di ciò che gli adulti (i loro oggetti d’amore primari) – ma non solo, la società tutta – pensano a proposito di loro.
Ecco perché i piccoli altro non diventano che l’incarnazione delle parole (d’amore, ma non sempre e non solo) che i loro «grandi» di riferimento usano per appellarli; ecco perché dicevo che gli adolescenti, loro malgrado, non inventano niente.
Niente.
A cosa serve l’adolescenza?
Il funzionamento degli esseri umani sa essere tanto elementare quanto complesso.
Per certi versi siamo poco più che creature unicellulari, semplici e lineari. Per altri, siamo e facciamo cose che si può al massimo pensare di intuire, prendendone atto.
Di sicuro c’è, tuttavia, che ogni nostra azione, prima ancora di essere colta nelle sue pieghe profonde, risponde a un criterio incontrovertibile: nell’esperienza non trova mai spazio nulla che non ci serva a qualcosa.
Il punto infatti non sta – sarebbe molto più semplice! – nel fare la cosa giusta o sbagliata (discrimine che cominciamo ad avere chiaro sin da bambini), ma nel fare ed essere cose di cui abbiamo bisogno. Sbagliatissime a volte, pericolose altre, folli altre ancora, eppure necessarie.
Questo concetto trova comodamente posto dentro al percorso di crescita degli esseri viventi, e gli umani non solo non fanno eccezione ma l’hanno perfezionato, arrivando a farne una forma d’arte.
Dopo un secondo dalla nascita, un neonato è già perfettamente programmato per vivere ed espertissimo, senza che evidentemente nessuno glielo abbia insegnato, a farlo cercando l’assolvimento dei suoi bisogni primari.
Diventando grandi (badate bene: ci mettiamo parecchio a farlo, decenni!), i bisogni si affinano, a quelli primari se ne accostano altri più sofi...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Mio figlio è normale?
- Il senso di questo libro
- PARTE 1. ADOLESCENZE, ADOLESCENTI ED ETÀ ADULTA
- PARTE 2. MIO FIGLIO È NORMALE?
- PARTE 3. COSA SERVE AGLI ADOLESCENTI
- Postfazione
- Ringraziamenti
- Bibliografia
- Copyright