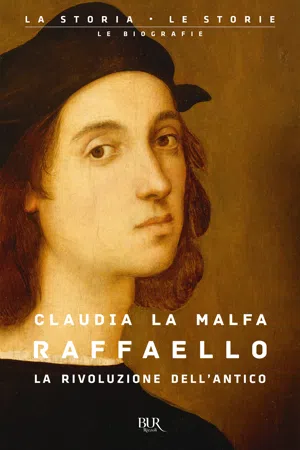Studiando la maniera di Pietro
Al tempo di Raffaello, Urbino doveva essere un luogo idilliaco, a stare alla descrizione che, con accenti poetici, ne fa nel Cortegiano Baldassarre Castiglione all’inizio del Cinquecento:
Alle pendici dell’Appennino, quasi al mezzo della Italia verso il mare Adriatico, è posta, come ognun sa, la piccola città d’Urbino; la quale, benché tra monti sia, e non così ameni come forse alcun’altri che veggiamo in molti lochi, pur di tanto avuto ha il cielo favorevole, che intorno il paese è fertilissimo e pieno di frutti; di modo che, oltre alla salubrità dell’aere, si trova abundantissima d’ogni cosa che fa mestieri per lo vivere umano.1
La città era divenuta un ducato per decisione di papa Eugenio IV nel 1443 e dal 1444 era stata guidata da Federico da Montefeltro (1422-1482), la cui signoria diede a Urbino sicurezza e splendore. Intrepido condottiero e abile uomo politico, Federico si dimostra capace di collocare il ducato, anche con la violenza, nel novero delle potenti signorie che governano l’Italia, di svolgere un ruolo chiave in alcune delle più importanti vicende del papato e di scegliere di volta in volta una saggia posizione strategica rispetto alle pressioni provenienti dagli stati stranieri.
Federico da Montefeltro, memore della formazione ricevuta da Vittorino da Feltre «MATEMATICO E PADRE DI TUTTI GLI [STUDI] UMANISTICI» (secondo una fortunata iscrizione sulla medaglia che Pisanello realizza per Vittorino nel 1447), si dedica anche all’accrescimento delle lettere e delle arti nel suo palazzo e nella città. Dopo avere acquistato alcune proprietà adiacenti al modesto palazzetto di famiglia di fronte al duomo, Federico da Montefeltro edifica un palazzo che rappresenta la sintesi perfetta tra il fortilizio e l’edificio di corte. Imponente e magnifico nelle sue forme classiche, degno di un condottiero militare ma anche di un signore di città educato negli studia humanitatis, il palazzo viene giudicato «non aedifitio humano anzi divino».2 Nel palazzo, Federico istituisce, sotto la guida del libraio fiorentino Vespasiano da Bisticci, una biblioteca ricca e colta con preziosi manoscritti illustrati su carta e su pergamena realizzati dai più noti amanuensi e miniatori dell’epoca. Federico chiama alla sua corte Luca Pacioli, matematico e teorico della prospettiva, Paolo Uccello, Piero della Francesca e molti altri pittori, scultori e architetti che concorrono con le maestranze locali a realizzare opere per il suo palazzo e a decorare gli altri edifici pubblici ed ecclesiastici da lui promossi in città.
L’ambiente umanistico, il mecenatismo e le gesta eroiche del condottiero sono narrate in un poema, la Cronica rimata, scritto negli anni successivi alla morte di Federico, tra il 1482 e il 1487, e dedicato a suo figlio Guidobaldo da Montefeltro. L’autore della Cronica è il cortigiano e pittore Giovanni Santi, padre di Raffaello. Il Santi (ante 1439-1494) vive a Urbino dove ha bottega in via di San Francesco, nei pressi della chiesa omonima. Tra i suoi assistenti vi sono Evangelista da Pian di Meleto (c. 1458-1549),3 Timoteo Viti (1469-1523) e, più tardi, Girolamo Genga (c. 1476-1551), tutti pittori di qualche anno più anziani di Raffaello che in diverse fasi della sua vita collaboreranno con lui. Giudicato da Vasari come un pittore di qualità modesta, Giovanni Santi per un certo periodo fu protagonista della produzione pittorica dell’età di Federico da Montefeltro a Urbino e nelle città vicine. Per Federico, Santi realizza le dieci tavole raffiguranti le Muse e Apollo che decoravano le pareti della preziosissima saletta, luogo di raccoglimento spirituale del duca, adiacente allo studiolo e aperta verso la Loggia dei Torricini. Vicino a Urbino, nella città di Fano, Giovanni Santi realizza tra il 1488 e il 1489 una Visitazione, pala d’altare della chiesa di San Salvatore (oggi Santa Maria Nuova), mentre a Cagli, probabilmente agli inizi degli anni Novanta, affresca la Cappella Tiranni nella chiesa di San Domenico.
Federico da Montefeltro muore il 10 settembre 1482. Il ducato di Urbino passa nelle mani del figlio di Federico, Guidobaldo (1472-1508), il quale, avendo poco più di dieci anni, è posto sotto la tutela dello zio, Ottaviano Ubaldini. Raffaello nasce nel 1483, pochi mesi dopo la scomparsa di Federico da Montefeltro, dal matrimonio di Giovanni Santi con Maria di Battista Ciarla. Generalmente si ritiene che la sua data di nascita sia il 6 aprile (che coinciderebbe con il mese e il giorno della morte). Ha un’infanzia costellata di lutti: a due anni perde il fratello e a otto anni muoiono la sorella e la madre. Nel 1494, Giovanni Santi si sposa una seconda volta con Bernardina di Pietro di Parte figlia di un orafo di Urbino. Quello stesso anno la giovane donna rimane incinta di una figlia, Elisabetta, che morirà anch’essa bambina. Nell’agosto del 1494, a soli undici anni, dopo aver perso madre e fratelli, Raffaello rimane orfano anche del padre. Nel testamento redatto prima di morire, Giovanni Santi affida Raffaello a suo fratello Bartolomeo Santi che con il bambino è eletto beneficiario universale di tutti i suoi beni mobili e immobili. Giovanni corrisponde alla seconda moglie la piccola dote che ella stessa aveva portato pochi anni prima quando si era sposata, alcuni panni e masserizie, ma le assegna anche l’usufrutto della casa, dove avrebbe potuto vivere con il nascituro, qualora avesse condotto una vita casta e onesta. Nel testamento, Giovanni promette alla moglie che, se fosse nato un figlio maschio, a questi sarebbe stata assegnata in eredità una parte dei beni mobili e immobili da dividere con Raffaello e con lo zio Bartolomeo, mentre se fosse nata una figlia femmina, avrebbero provveduto a darle una dote di centocinquanta ducati d’oro. Le altre carte sparse rinvenute negli archivi di Urbino, che documentano questioni testamentarie sollevate dalla seconda moglie del Santi e da suo padre, hanno permesso di trarre conclusioni sulla saltuaria presenza di Raffaello a Urbino in occasione di firme di documenti concernenti l’eredità e la gestione dei beni di famiglia.
Quanto alla formazione artistica di Raffaello non sono emersi fino a ora documenti d’archivio che facciano luce sul periodo giovanile, sia precedenti alla morte di Giovanni Santi sia successivi. La prima documentazione a noi pervenuta lo attesta tra il 1500 e il 1501 a Città di Castello vicino Perugia. Secondo Vasari, Santi affida, ancora prima della morte della madre, il piccolo Raffaello al pittore umbro Pietro Vannucci, noto come il Perugino (c. 1450-1523).4 Il padre di Raffaello ricorda il nome di Perugino già nella Cronica rimata, come quel «Pier dalla Pieve, ch’è un divin pictore» che con Leonardo da Vinci è «giovin par d’etate e par d’amori».5 Le imprese pittoriche realizzate a Roma nei primi anni Ottanta del Quattrocento durante il pontificato di Sisto IV a San Pietro e nella Cappella Sistina in Vaticano avevano infatti dato grande fama al Perugino, che, a partire da questi lavori, è, per alcune persone influenti del tempo come il banchiere senese Agostino Chigi, il «primo pittore» dell’Italia centrale.6 Nei tardi anni Ottanta, Giovanni Santi può avere avuto una conoscenza diretta dell’opera di Perugino, in quanto questi nel 1488, nello stesso periodo in cui anche il Santi lavora alla Visitazione, consegna, per un altare della chiesa di Santa Maria Nuova di Fano, un’Annunciazione. Successivamente, negli anni Novanta, a Perugino viene commissionata una seconda pala d’altare consegnata nel 1497, la Pala di Fano, un polittico di grandi dimensioni con al centro una Sacra conversazione e nella predella Storie della vita di Maria. A questa data il Santi era già morto, ma Raffaello potrebbe aver collaborato con il maestro umbro nell’esecuzione della predella, di cui vi è un’eco nella predella dell’Incoronazione della Vergine (Pala Oddi) dipinta da Raffaello all’inizio del Cinquecento per la cappella di san Giuseppe in San Francesco al Prato a Perugia.
Se Vasari può avere anticipato di troppi anni il periodo in cui Santi affida il figlio al Perugino, è verosimile che Raffaello possa aver ricevuto la sua formazione a contatto con Perugino quando negli anni Novanta questi è nel pieno della sua produzione con opere commissionate a Fano, a Firenze – il Compianto sul corpo di Cristo per il convento di Santa Chiara (1495) – e a Perugia. Dal 1495 infatti Perugino è il dominus della pittura nella città umbra dove riceve le commissioni per la Pala dei Decemviri nella cappella del Palazzo dei Priori (1495-1496), per il Polittico di san Pietro nell’Abbazia di San Pietro (c. 1496-1499), per la Resurrezione di Cristo in San Francesco al Prato (1499) e per lo Sposalizio della Vergine nel duomo di San Lorenzo a Perugia (1499-1504). Nel 1496 Perugino riceve anche l’incarico per la decorazione del Collegio del Cambio terminata nel 1500, dove dipinge una serie di uomini illustri, allegorie della virtù e un soffitto con grottesche e immagini degli dei pagani e delle divinità astrologiche.
Vasari, a commento degli anni che Raffaello avrebbe speso nella bottega di Perugino, scrive:
[…] notabilissimo fu che in pochi mesi, studiando Rafaello la maniera di Pietro, et Pietro mostrandoli con desiderio che egli imparassi, lo imitava tanto a punto et in tutte le cose che i suoi ritratti non si conoscevano da gli originali del maestro, e fra le cose sue e di Pietro non si sapeva certo discernere […].7
Indubbiamente la produzione giovanile di Raffaello mostra molte somiglianze con lo stile e le invenzioni di Perugino. Ciò in pratica sostanzia l’ipotesi di Vasari di una sua formazione nella bottega del maestro umbro.
E tuttavia è manifesta, già in questa produzione giovanile, una nota che sarà tipica di tutta l’attività dell’artista negli anni di maturità: fin dalla giovinezza Raffaello di volta in volta attinge dalle opere dei maestri a cui guarda o che conosce in prima persona, ma reagisce in modo complesso ai diversi stimoli che riceve, generando quella difficoltà di risalire alle diverse componenti della sua formazione che ha caratterizzato la critica d’arte. Nelle opere eseguite all’inizio del nuovo secolo, nelle sue piccole tavole devozionali come nelle grandi pale d’altare, si trovano infatti numerosi elementi desunti dalle invenzioni del padre e degli altri artisti attivi a Urbino, da Piero della Francesca al toscano Luca Signorelli, e dagli affreschi e dalle opere su tavola dell’altro grande maestro dell’Italia centrale, ritenuto all’epoca secondo solo a Perugino, l’umbro Bernardino Pintoricchio. Nei lavori giovanili di Raffaello vi è anche l’eco di famose opere classiche di Roma: si tratta tuttavia di opere ben note agli artisti di cui si è detto e il cui repertorio figurativo viene diffuso nelle loro botteghe attraverso le copie dei disegni prodotti a Roma da quelli di loro che nella città erano stati o avevano avuto accesso ai disegni dall’antico.
Pur traendo ispirazione dalle eleganti ma affettate figure di Perugino, dallo stile calligrafico di Signorelli, dalla densa narrazione di Pintoricchio, dalle statue e rilievi antichi e pur assorbendo le regole della matematica e della geometria da Piero della Francesca, Raffaello riesce a esprimersi con un linguaggio originale, distaccandosi dai suoi maestri e modelli e creando un nuovo stile individuale. Questa sua qualità è già evidente nel 1500-1501 allorché gli viene commissionata la prima opera di grandi dimensioni da esporre in un luogo pubblico, la Pala Baronci di Città di Castello.
La Pala Baronci
Il 10 dicembre 1500 Raffaello è documentato a Città di Castello, una piccola città dell’Umbria, vicino Perugia, affacciata sulle rive del fiume Tevere non lontana dalla Via Flaminia, l’antica strada che porta a Roma. In questa città, Raffaello firma quello che a oggi risulta come il suo primo contratto di incarico per l’esecuzione di una pala d’altare. Sebbene alla data della firma il pittore abbia solo diciassette anni, è indicato con il termine latino magister per «maestro», che nei documenti dell’epoca è usato per gli artisti che hanno piena autonomia di lavoro. Il contratto documenta un incarico importante: il mercante della lana Andrea Baronci di Città di Castello commissiona al pittore una pala per il proprio altare nella chiesa di Sant’Agostino. Nell’impresa Raffaello è coadiuvato dal pittore più anziano Evangelista da Pian di Meleto, già collaboratore del padre a Urbino. Secondo gli accordi, come si legge nel documento, «i pittori, cioè il maestro Raffaello di Giovanni Santi di Urbino e Evange...