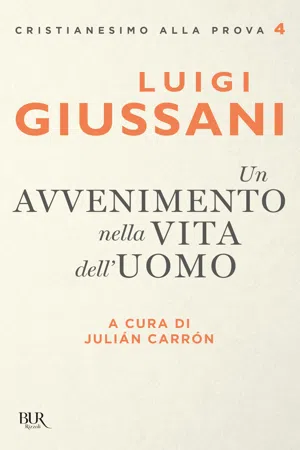Il 1991 si era chiuso con il dissolvimento dello Stato sovietico, dopo che le repubbliche che lo formavano, dall’Estonia all’Armenia, avevano dichiarato la loro indipendenza e avversione al comunismo. A nulla era valso il golpe d’agosto per tentare di tenere insieme un impero destinato a sgretolarsi con una rapidità che pochi avrebbero immaginato solo qualche anno prima. Con il crollo dell’URSS finiva uno dei maggiori regimi totalitari del Novecento e, con esso, terminava la realizzazione storica, in forma di Stato, del comunismo in Occidente. Nessuno era più disposto a credere alla sua promessa di giustizia, di uguaglianza e di libertà, che aveva condizionato le vicende storiche del secolo XX. Finiva anche l’epoca dei “blocchi”, delle “cortine di ferro”, dei “muri”, dei “patti militari” e tutto ciò avrebbe in poco tempo mutato i contorni del mondo occidentale, nelle sue componenti politiche, economiche e sociali.
A Milano iniziava, quasi in sordina, l’inchiesta su Tangentopoli, che in pochi mesi avrebbe coinvolto tutto il mondo politico e imprenditoriale italiano. Nuove formazioni politiche erano salite alla ribalta, mentre quelle tradizionali dimezzavano i loro consensi, in un clima generale di protesta contro la corruzione e di sfiducia nelle istituzioni. In un’intervista don Giussani definì quanto stava succedendo un «sommovimento terrestre, un terremoto» e manifestò «il timore […] che si scatenino conflitti senza fine», a causa della fragilità di «una situazione civile dove non c’è un ideale adeguato, dove non c’è nulla che ecceda l’aspetto utilitaristico».1
In tale contesto, la preoccupazione fondamentale di Comunione e Liberazione fu l’unità. «Non esiste ragione più forte dell’unità», sostenne don Giussani in una Diaconia della Fraternità, spiegando che «non esiste nessun sacrificio più grande di quello di dare le proprie energie, il proprio tempo e la propria vita per l’opera di un altro». Posta all’origine di ogni gesto e azione, «la nostra unità – e quindi la nostra Fraternità – nasce da un argomento e poggia su una ragione che viene prima di qualsiasi analisi possiamo fare o di qualsiasi reazione» possiamo avere. Se «per sua natura l’esperienza del movimento è liberazione», occorre immedesimarsi in essa ed esserne responsabili. «Ma non c’è responsabilità» – continuò in quella “sintesi”, che divenne proposta di un cammino –, «non avviene questo “render propria l’esperienza del movimento” se non c’è corresponsabilità, perché l’esperienza del movimento è per sua natura comunionale.»2
L’insorgere dei sintomi della malattia, che lo avrebbe accompagnato negli ultimi anni, non scoraggiò don Giussani, anzi lo rese più accanito nello spingere a fondo la riflessione sull’autocoscienza del carisma del movimento.
Al Consiglio nazionale dei responsabili di CL del 15 febbraio 1992 affrontò il tema che darà il titolo agli Esercizi: «“Il sacrificio più grande è dare la vita per l’opera di un Altro”. Questa frase è analogica con quella che ha detto Cristo: “Nessuno ama tanto i propri amici come chi dà la vita per i propri amici” (cfr. Gv 15,13). Ma più profondamente ancora – come tutto il Vangelo di san Giovanni afferma – questa frase ricorda l’esperienza stessa di Cristo che dà la vita per l’opera del Padre».3
Nella ricorrenza dei dieci anni dal riconoscimento pontificio, si tenne, il 17 ottobre, il pellegrinaggio a Lourdes di tutta la Fraternità, per tenere vivo il senso dell’esistenza come «pellegrinaggio del cuore dell’uomo verso il cuore del mistero dell’Essere».4
Veniamo da lontano, non tanto dalle nostre case, ma da lontano nel tempo: siamo parte di un avvenimento reale, così come è reale il convogliarci in unità di questa sera, un avvenimento che è iniziato nel nascondimento, nel segreto del seno di una giovane donna, in cui Dio si è reso carne. Noi portiamo nel nostro cuore, nella nostra intelligenza e nel nostro affetto, in qualsiasi proporzione o modalità, questa eredità per il mondo intero, per la storia intera. In questo istante della storia, questa eredità coincide con la nostra mente, col nostro cuore, con la nostra carne, con la nostra compagnia, con la nostra amicizia. Iniziamo ricordando quell’inizio. Niente lo può rendere più chiaro che recitare l’Angelus. Ma pesiamo le parole a cui il cuore nostro si deve legare.
Angelus
Per che cosa ci siamo ritrovati o per che cosa siamo venuti e siamo presenti come una cosa sola? Perché di questa compagnia presente ciò che veramente importa è qualcosa che ci è inesorabilmente comune. Ognuno di noi ha una sua personalità, una sua faccia, un suo cuore, un suo temperamento, un suo carattere, e relativamente in pochi ci si conosce in questi dettagli; ma anche le persone che non ho mai viste, che si perdono nell’oscurità, aumentata da queste luci poderose che mi bruciano gli occhi, anche coloro che non ho mai visti hanno in comune con me la vita come un compito da realizzare, da svolgere; un compito non indiziato o voluto da me o da loro, un compito comune, identico, per me e per l’ultimo, il più lontano geograficamente, tra voi: un compito assegnato. Quello che c’è di comune è che di questo compito vogliamo sapere, desideriamo sapere, esigiamo con tutto il cuore di sapere il «perché»; e vogliamo anche sapere dove tutta la nostra vitalità, tutta la nostra espressività, tutta la nostra dedizione, tutto il nostro vivere vada a finire, quale sia lo scopo del vivere, con la fatica da portare, le contraddizioni da subire, la vergogna di sé da sopportare («Prega per noi peccatori»).1
Queste cose sono comuni a tutti, sono le cose più importanti per ognuno di noi. Noi ci ritroviamo soltanto per riesaminare queste parole, che, essendo quelle essenziali della vita di ognuno, sono sempre le stesse e mai uguali, quando ce le ripetiamo. E questo è proprio il miracolo e il mistero di una vita che è vita, che si esprime a livello di queste parole drammaticamente decisive per un viso che duri sempre, che è destinato a durare sempre: il volto eterno del nostro io, senza del quale il nostro io sarebbe la figura di uno schiavo del potere o dei potenti, o della violenza o della sbadataggine di chi lo circonda.
Siamo venuti per riandare alle cose che sempre ci diciamo. Ci sono alcune di queste cose che sempre, tutte le volte che ci ritroviamo, ci diciamo, e sono quelle che diventano sempre più vive: ciò che conta, infatti, non è la diversità del discorrere, del discorso, delle parole che ci diciamo, ma proprio quello che c’è di più fermo, ripetuto, stabile, quello che abbiamo sempre detto.
E ci siamo ritrovati tutti insieme perché non c’è niente più di questo, normalmente, che possa aiutare le emozioni del cuore o la vivezza della percezione della nostra mente, che possa influire come un urto tenero e materno, o fraterno, o amicale, sulla nostra volontà, che altrimenti si impigrirebbe troppo. Niente più del nostro radunarci può servire a illuminare quello che altrimenti resterebbe sempre troppo oscuro. Comunque, al fine di destare un’esperienza nella quale i valori per cui ci muoviamo, a cui siamo costretti dalla nostra stessa natura e dal destino nostro, acquistino una efficacia sulla nostra vita personale, non c’è – dico – niente di paragonabile a questo nostro radunarci: potremmo essere in trenta, in trecento, come le prime volte, o giungere a trentamila. Non conta il numero, ma conta, sì, il ritrovarsi insieme.
E ritrovandosi insieme, ognuno, personalmente, in che modo può contribuire a questa azione che tutti insieme compiamo su di lui? E in che modo lui può contribuire alla vita di ognuno di noi, a stimolare la vita mia, a farmi attraversare un po’ più velocemente la vergogna che ho nel dire e ridire queste cose da questa posizione, mentre vorrei essere l’ultimo là in fondo, a sentire con libertà immediatamente più grande? In che modo possiamo contribuire? Con una sola cosa: col silenzio. Che almeno per un giorno e mezzo durante tutto un anno noi – grandi, non bambini – sappiamo scoprire o lasciarci affondare dentro questa cosa che è il silenzio, dove pensiero e cuore, percezione di ciò che ci circonda e perciò abbraccio fraterno, amichevole, con le persone e con le cose, dove tutto ciò che si attua in questa compagnia si esalta. Il silenzio esalta tutto. Che un giorno e mezzo durante tutto un anno ci lasciamo andare allo sforzo, alla fatica di questo silenzio! Il silenzio non è il non parlare, il silenzio è essere riempiti nel cuore e nella mente dalle cose più importanti, quelle a cui normalmente non pensiamo mai, pur essendo esse il segreto motore per cui facciamo tutto. Niente, infatti, di quello che facciamo ci basta, è soddisfacente ragione per farlo, o meglio, è esauriente ragione per farlo.
Il silenzio, dunque, coincide con quello che noi chiamiamo «memoria» e può essere condotto nella riflessione che personalmente favoriamo, o nell’ascolto, o nel guardare gli altri che ci sono intorno, nel guardare questi amici o questi fratelli o questi uomini, che, in vario atteggiamento, sono qui, come noi, per qualcosa di ultimamente comune, portandosi dentro una diversa storia, che confluisce nello stesso punto.
Per questo insistiamo perché il silenzio sia rispettato nella sua natura, cui adesso ho accennato, ma anche nel contesto in cui siamo, salvando il contesto per cui questa memoria può essere utile, e perciò anche non parlando inutilmente. Raccomandiamo il silenzio innanzitutto nei movimenti che facciamo, nei tragitti in pullman: che siano fatti in assoluto silenzio; e l’assoluto silenzio sia conservato mentre si entra in salone: del resto, la memoria sarà favorita dalla musica che sentiremo o dai quadri che vedremo, come quelli bellissimi che abbiamo visto poc’anzi proiettati sullo schermo,2 che ci disporranno a guardare, ad ascoltare, a sentire con la mente e col cuore quello che in qualche modo Iddio ci proporrà – «Iddio» ci proporrà –. E raccomandiamo il silenzio anche al ritorno negli alberghi. Questo, naturalmente, non può essere segnalato con precisione; però, se il raccoglimento sarà mantenuto, magari espresso in un dialogo indagatore, chiarificatore, tra voi, tra marito e moglie o tra gli amici più affiatati, o con il sacerdote, se negli alberghi questo raccoglimento viene riecheggiato e mantenuto, tanto meglio: vi preparerete all’assemblea che farete nei vostri alberghi domani sera, in cui potrete sottolineare ciò che più vi ha colpito o destato interrogativo di quello che vi verrà proposto.
Abbiamo una grande compassione verso ciò che ci viene proposto e il modo con cui ci viene proposto, perché l’intento è buono, vuole il tuo bene, ti vuole bene. Quello che facciamo insieme in questo giorno e mezzo non è che un aspetto del grande gesto amoroso con cui il Signore, comunque tu te ne accorga, spinge la tua vita verso quel destino che è Lui.
Quello che ci diremo avrà come tema Dare la propria vita per l’opera di un Altro. Ma l’altro a cui dare la propria vita non può essere che Lui, il grande Mistero originale, l’enigmatico destino verso cui tutto di noi fluisce: Padre, generatore e giudice e oggetto dell’eterna felicità. L’altro non può essere che Lui: Iddio. Dare la propria vita per Dio. Ci richiama una frase di Gesù: «Nessuno ama tanto come chi dà la vita per i propri amici»,3 e indubbiamente dovresti essere Tu, o Signore, l’amico per eccellenza.
«Dare la vita» non necessariamente significa morire; la morte è un fatto e un momento, un’espressione della vita, è parte della vita, ma dare la vita non necessariamente coincide con quel momento. Anzi, se si è data la vita per Dio lungo il passare dei giorni, allora appare o può apparire più buono anche quel momento, può essere più facile comprenderne il significato positivo e “definitivo” del grande desid...