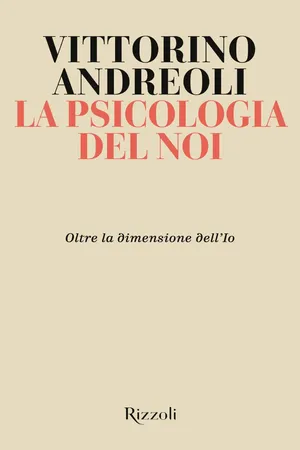Ci sono due strade che portano alla nascita di una teoria. Si può partire dall’argomento su cui è incentrato il proprio interesse e cercare fin dall’inizio di interpretarlo, seguendo la via del pensiero (che si può anche definire il primo laboratorio scientifico), e aggiungere poi, a sostegno di quanto elaborato fino a quel momento, una verifica sperimentale secondo i principi della metodologia scientifica.
Una teoria ha sempre alla base un grande tema, nel senso che riguarda determinati fenomeni: nel caso della teoria galileiana, bisognava spiegare il movimento del sistema solare; nel caso della teoria darwiniana, si voleva dare un ordine alle numerose specie animali distribuite sulla terra.
Il senso della ricerca è dunque chiaro fin dall’inizio: descrivere, interpretare, classificare e spiegare un sistema fisico su cui fino a quel momento si possedevano cognizioni insoddisfacenti. Il lavoro del teorico è tutto imperniato sul dare un ordine, una conformazione agli eventi, ed è questo il suo scopo, che persegue consapevolmente e con continuità.
Il secondo modo per elaborare una teoria parte invece da osservazioni o studi che riguardano aspetti particolari e limitati di un fenomeno – si potrebbe dire concreti – che, osservati in un determinato momento, suggeriscono una spiegazione generale. Potremmo semplificare dicendo che qui si va dal particolare al generale, diversamente dal primo caso, in cui si elabora una teoria generale e poi la si applica al particolare per stabilirne la capacità di offrire spiegazioni coerenti. Nel linguaggio scientifico si parla rispettivamente di «metodo deduttivo» e «metodo induttivo».
L’oggetto di una teoria può riguardare ambiti tra loro molto lontani.
Un campo in cui si esprimono oggi teorie di grande interesse è quello della fisica delle particelle e dell’astrofisica. La più nota, esemplare per le nostre considerazioni, è la teoria einsteiniana della relatività generale. Albert Einstein ha infatti fornito una interpretazione dell’universo che ha previsto le onde gravitazionali e i buchi neri, la cui esistenza è stata definitivamente dimostrata solo dopo molti anni dalla formulazione della teoria. Ha dunque seguito la prima strada, quella in cui la teoria precede la verifica del particolare, che si arriva a riconoscere anche molti decenni dopo.
Un altro settore di applicazione del primo metodo è dato dalla biologia intesa nel significato etimologico del termine, come «scienza della vita». In tal senso la teoria che riporta la vita al codice genetico è certamente la più significativa. La concezione del DNA, i geni che contengono le informazioni necessarie alla costituzione del corpo, che trova in James Watson e Francis Crick i suoi teorici, va in una direzione che continua a ricevere conferme.
Questo vale anche per la teoria freudiana, poiché formula gli elementi di una organizzazione psichica, ne esplicita la dinamica, che riporta nel campo della medicina, e dà prova di essere in grado non solo di spiegare la patologia ma anche di curarla. All’inizio riguardava soltanto l’isteria, ma poi è stata verificata in tutte le nevrosi e confermata.
Anche Freud dunque, come Einstein, elabora la sua teoria seguendo il metodo deduttivo, e la psicologia dell’Io ha trovato e continua a trovare conferma della propria validità nella pratica. Ne è esempio proprio il volume che Freud dedica ai casi clinici, diventati classici della psicoanalisi.
Per analogia merita di essere definita teoria anche una psicologia del Noi.
Anzitutto, questa definizione l’ho io stesso appresa dalle recensioni ad alcuni miei libri che non avevano uno scopo teorico, poiché la mia attenzione di clinico va sempre ai casi, tanto che sostengo che ognuno di essi è una realtà a sé stante.
Da clinico, mi sono occupato sempre di categorie, che significa cercare di raccogliere sotto un denominatore comune la varietà dei quadri psicopatologici. Solo recentemente ho preso atto di questa specificazione che mi è stata attribuita, e ciò mi ha permesso di rendermi conto che, combinando alcune mie conclusioni cliniche, giungevo a negare che un Io, ovvero un individuo, abbia una consistenza concreta. Finivo dunque per oppormi a una psicologia dell’Io, che mi appare una finzione poiché non solo non c’è mai un momento in cui si definisca un soggetto staccato da tutto il resto (gli altri Io e il mondo), ma anche perché non esiste espressione umana che non sia relazione con l’ambiente circostante.
Per quanto riguarda il mio specifico ambito di lavoro, ne deriva che non può esistere apparato psichico che funzioni indipendentemente; e che ogni psiche si esprime diversamente, in relazione all’altro da sé.
Un apparato psichico, dunque, esiste solo in quanto si relaziona con gli altri. La psiche di un individuo, pertanto, non è un’entità a sé stante ma una combinazione che nasce dal rapporto con gli altri: è cioè non un Io ma un Noi. Inoltre la plasticità di un apparato psichico dipende da come è la psiche dell’altro.
Io stesso sono rimasto meravigliato di aver espresso una concezione che si distingue da quella freudiana. Anche se non mi ha mai attratto diventare un seguace di Sigmund Freud e dedicarmi alla pratica psicoanalitica, ho sempre avuto una grande considerazione per la sua figura. Mi infastidisce quando si critica il suo pensiero, in nome di una scienza hard, fondata su rigide dimostrazioni. Ammiro la logica interna alla psicologia dell’Io e ritengo che l’opera freudiana sia un esempio di chiarezza clinica e di una grande capacità di scrittura.
Il mio tentativo di dare ai fenomeni psichici un ordine tale da comporre una teoria del Noi è pertanto lontano da ogni atteggiamento di critica malevola nei riguardi del lavoro freudiano. Mi pare però giunto il tempo di uscire dalle secche in cui si trovano gli studi sul comportamento umano e soprattutto gli interventi che si definiscono terapeutici.
È un passo assolutamente necessario: la psichiatria si trova in uno stato confusionale; la psicofarmacologia, su cui si fondava, negli ultimi quarant’anni non ha più dato un apporto significativo, e nemmeno utile. Le psicologie si sono disseminate in oltre duecento orientamenti; e nell’ultimo ventennio la psicoanalisi freudiana ha perduto il dominio di cui aveva a lungo goduto nella prassi terapeutica. Negli Stati Uniti si può parlare di vero e proprio crollo della sua applicazione.
In questo stato di immobilismo hanno fatto il loro ingresso dirompente le neuroscienze che si avvalgono di strumenti (macchine) di grande potenza. Gli studi neuroscientifici corrono però su sentieri che vanno in tutte le direzioni, senza intravedere traguardi che non siano quelli, ormai insostituibili, del riduzionismo biologico.
Forse è proprio questa visione che mi ha portato a prendere atto, nel momento in cui altri me lo indicavano, di aver generato una teoria. Mi piace pensare che possa servire a riunire gli orchestrali della psiche, che ormai, anche quando suonano bene uno strumento, non riescono a comporre una sinfonia utile agli ascoltatori. Che, nella metafora, sono i pazienti psichici.
La dimensione del Noi ha per me radici lontane. Colpito dalla sentenza di Socrate che si leggeva sul frontone del tempio di Apollo, a Delfi, conosci te stesso, tanti anni fa l’avevo completata in modo che recitasse: conosci te stesso per poterti meglio relazionare con l’altro. Pure all’Io penso di Kant mi è sempre venuto da aggiungere una specificazione, per farlo diventare: Io penso a un altro io. Questi, naturalmente, sono aneddoti che non hanno nessun significato all’interno di una teoria, ma desidero ricordarli mentre mi accingo a ricostruirla.
Anche la psicologia del Noi va raccontata per punti, per sottolineare quali elementi la giustifichino e al contempo la sostengano come teoria.
Prima di iniziare è necessaria una precisazione: la mia teoria non solo non costituisce la verità (che non appartiene alla scienza), ma rappresenta un sistema dinamico capace di comprendere in modo più coerente le manifestazioni dell’apparato psichico e tale da lasciare spazio a nuovi elementi che la possano rendere più consequenziale, ma anche a punti che trovino una diversa esplicazione. Se la verità dei filosofi e delle religioni è assoluta e immutabile, una teoria è invece aperta, mobile, in continua elaborazione; e si cala nel particulare (i casi clinici) accogliendo le osservazioni volte a migliorarla.
Il nucleo di questa teoria è, lo ripetiamo, il Noi, inteso come insieme che non è il risultato di un’azione, ma la condizione stessa di funzionamento dell’apparato psichico. Al suo interno sono indispensabili gli Io che, tuttavia, in ogni comportamento e in ogni funzione psichica si esprimono solo nel Noi.
Il cervello plastico
Il primo elemento si lega alle ricerche condotte sul cervello negli ultimi trent’anni (di cui ovviamente Sigmund Freud non poteva tener conto): la scoperta del cervello plastico.
Una porzione dell’organo cerebrale, i lobi frontali e la parte iniziale dei lobi parieto-temporali, ha mostrato infatti la capacità di strutturarsi e di modificare la propria funzione a seconda delle esperienze, differenziandosi dal cervello deterministico (determinato), che svolge invece funzioni rigidamente organizzate e si attiva nelle esperienze secondo una struttura innata, quindi non modificabile. L’apparato psichico deriva dal cervello plastico, ma ciò non impedisce che queste aree modificabili siano connesse con nuclei o zone del cervello determinato, a sostegno del principio che il cervello rappresenta un organo unitario. Cervello plastico e cervello determinato sono però nettamente distinti tra funzioni esattamente preordinate e funzioni invece aperte.
Ho sempre sostenuto che la plasticità non può essere ritenuta infinita, ma che si esprime entro certi livelli.
Se il cervello deterministico è rigidamente fissato nel codice genetico, quello plastico, che ho chiamato delle disposizioni-a, non sfugge a tale controllo. Del resto i comportamenti e le funzioni psichiche sono identificabili, definibili, e ciò sta a significare una certa costanza nella psiche umana. I già citati meccanismi di difesa del pensiero freudiano, per esempio, non potranno diventare illimitati poiché la stessa struttura del cervello dipende da un’organizzazione, la rete neuronale, che è fatta di cellule, di molecole. D’altra parte oggi si comincia a comprendere che anche la meccanica quantistica ha dei limiti e delle leggi.
Desidero ora soffermarmi sulla capacità del cervello plastico di strutturarsi sulla base delle esperienze.
Esperienza vuol dire incontro, rapporto, relazione con l’ambiente circostante, che è costituito dalla natura e dall’uomo, quello che viene chiamato «mondo». Senza esperienza, il cervello plastico non è in grado di esprimersi.
Non si tratta di un principio privo di dimostrazioni. Prendiamo un neonato: se si tiene al buio e senza stimoli sensoriali (sensory deprivation), il suo apparato psichico non si esprime. Ciò sta a significare che ha bisogno dell’altro, del mondo: un cervello per funzionare ha bisogno dell’altro, della presenza dell’altro. I termini incontro, rapporto, relazione servono a evidenziare le modalità attraverso cui il mondo attiva un cervello plastico, che altrimenti rimane inespresso.
Un’altra dimostrazione, storica e ante litteram, è quella del bambino dell’Aveyron, studiato anche da Philippe Pinel, il primo psichiatra della storia. Era un piccolo «selvaggio» che aveva vissuto nella foresta dell’Aveyron alla fine del XVIII secolo senza avere alcun contatto con i suoi simili, fino a quando era stato trovato presumibilmente tra i nove e i dodici anni di età. Camminava a quattro zampe, non parlava e la sua psiche richiamava quella di un animale, non certo di un essere umano.
Al di là di questi rarissimi casi, è invece frequente vedere come un bambino, fin dalla nascita, ha un tipo di relazione che non solo promuove l’attività dell’apparato psichico, ma presenta notevoli modificazioni a seconda dell’«altro» con cui vive. Basterebbe ricordare le osservazioni fatte dall’antropologo e psichiatra inglese Gregory Bateson sulla madre schizofrenogenica, ma anche quelle di Margaret Mead che, portando...