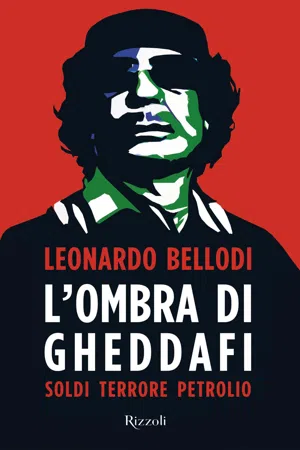1. L’invenzione della Libia
Il deserto della Sirtica dove nasce Muammar Gheddafi – in un luogo e in un giorno imprecisato della primavera del 1942 – è uno dei teatri cruciali della Seconda guerra mondiale. Nei pressi delle tende di pelli di capra che danno riparo alla qabila dei Gadadfa sfilano i cingolati protagonisti delle prime grandi battaglie della storia con mezzi corazzati. A quel tempo le cose sembrano ancora poter volgere al meglio per le forze dell’Asse. Dopo aver ricacciato i britannici dalla Cirenaica, la Panzer-Division dell’Afrika Korps guidata dal generale Erwin Rommel, inviato da Adolf Hitler a soccorrere gli alleati italiani in affanno, entra in profondità nell’Egitto britannico. L’avanzata della volpe del deserto si ferma però in estate a un centinaio di chilometri da Alessandria. In autunno, la sconfitta nella seconda battaglia di El Alamein contro l’Ottava armata britannica, comandata dal generale Bernard Law Montgomery, costringe le forze italo-tedesche a lasciare prima la Sirtica, poi tutta la Libia.
Il piccolo Muammar ha giusto il tempo di nascere cittadino italiano. Con la caduta di Tripoli, il 23 gennaio del 1943, si conclude anche quella sorta di Guerra dei trent’anni – spesso a bassa intensità e con una letale pacificazione prima della resa dei conti finale – iniziata nel 1911, quando l’esercito dell’Italia giolittiana sbarca sulle coste della Tripolitania per ritagliarsi l’agognato «posto al sole» nel corpaccione agonizzante dell’impero ottomano.
Quando Roma passa all’attacco, la Sublime Porta controlla quelle terre da circa trecento anni – Tripoli da metà del Cinquecento, Bengasi un secolo dopo – e le ha almeno formalmente accorpate, creando una prima, incerta e labile unità tra regioni che hanno poco o nulla in comune e una storia diversa alle spalle. Regioni che a lungo – prima che la modernità, in parte coincidente con la scoperta degli idrocarburi, ne alteri lievemente la fisionomia – si presentano più o meno così.
La Tripolitania è la più grande e popolata, il punto non solo di sbarco ma anche di stanziamento dei tanti aspiranti conquistatori, che si limitano poi a incursioni nell’interno. Poche oasi verdi interrompono la monotonia del deserto. A ovest di Tripoli, la pianura di Jafara permette quel minimo di pastorizia necessaria alla sopravvivenza, mentre la montagna occidentale Jabal al-Gharbi è pressoché l’unica zona dove è possibile coltivare olivi e cereali. La zona più fertile, quella del Sahil, a est di Tripoli, si spinge fino al Golfo della Sirte, che tradizionalmente divide la Tripolitania dalla Cirenaica.
La cosmopolita costiera che arriva fino in Tunisia è il primo lembo del Paese a essere toccato dalla modernizzazione, generando un ceto urbano mercantile interessato a quanto accade dall’altra parte del mare. Questa storica linea di faglia tra i cittadini sedentari e i nomadi del deserto, su cui si è poi innescata la resistenza dell’interno contro i colonizzatori – culla di un proto-nazionalismo sui generis – si sovrappone alle altre divisioni che frammentano la Libia di ieri e di oggi.
Se la Tripolitania o Tripolis, «terra delle tre città», era romana, com’è evidente ancora oggi dalle rovine di Leptis Magna, Oea e Sabrata, la Cirenaica è greca per origine, o comunque investita dall’influenza ellenica fin dal IV secolo a.C., secondo il padre della storia Erodoto, e fino ai giorni nostri o quasi, come testimonia la piccola comunità di pescatori greci che ancora in tempi recenti si trovava a Bengasi e dintorni.
Una divisione cruciale, quella tra Tripolitania e Cirenaica, che si approfondisce nel 395 d.C., quando dal deserto della Sirtica passa la linea di confine tra l’impero romano d’Occidente e quello d’Oriente. Qualcosa di più di un reperto storico: se i Tripolitani guardano al Maghreb, i Cirenaici orientali entrano presto nell’orbita del Mashreq, Egitto in testa. Più tardi Muammar Gheddafi per i suoi sogni unionisti si volgerà sia a est sia a ovest – oltre che a sud, negli anni della svolta panafricana – alternando i punti cardinali o combinandoli nel panarabismo.
Anche in Cirenaica, come in Tripolitania, la popolazione si concentra sulla costa, da Bengasi a Tobruk. Voltando le spalle al mare, chilometri e chilometri di deserto corrono verso il Sudan e lì nulla si può coltivare. Solo sul Jabal al-Akhdar (la Montagna Verde) piove abbastanza da permettere alcune coltivazioni. Altri sparuti cenni di vita si registrano nei villaggi che hanno trovato l’acqua, come le oasi di Kufra e Jaghbub.
Il Fezzan, infine, è l’area più isolata, separata dalla costa della Tripolitania da centinaia e centinaia di chilometri di sabbia e roccia. Sono terre di nomadi e di piste da percorrere con le carovane che portano le merci fino all’Africa subsahariana. Terre neglette fino all’avvento di Gheddafi, che nel capoluogo Sebha si forma politicamente e, una volta giunto al potere, proprio nella immensa distesa di sabbia che apre le porte del grande Sud vede una piattaforma strategica cruciale per coltivare le sue ambizioni continentali.
La popolazione della Libia che verrà è costituita a maggioranza da arabi e berberi, con minoranze di ebrei e stranieri, soprattutto nei centri urbani della costa.
La frattura tra regioni e le divisioni tra gruppi etnici si sovrappongono alla più profonda e persistente impronta del sistema tribale nella conformazione politico-sociale del Paese. L’appartenenza clanica rimane il principale fattore identitario. Sono i rapporti di forza e l’informale gioco delle alleanze tra le circa centoquaranta tribù – come quella dei Warfalla, che oggi conta un milione di persone, o gli Zintan, gli Zuwayya, i Tuareg o i Meqarha – a determinare ieri come oggi gli assetti del potere in Libia e il corso della sua storia. Una potente corrente sotterranea di cui in superficie non sempre si coglie la forza.
2. Breve storia della Libia
L’occupazione ottomana si concentra inizialmente nelle zone urbane della Tripolitania e della Cirenaica, poi progressivamente gli emissari del sultano s’inoltrano nell’entroterra per riscuotere tasse e formali atti di sottomissione. Il dominio di Costantinopoli, però, quando l’impero diventa una comunità multiculturale, lascia sopravvivere gli assetti sociali ed economici preesistenti. E in un mondo arabo in cui l’appartenenza tribale è il principale fattore d’identità, più che la fedeltà all’impero è quella al califfato, che ancora rappresenta l’unità della umma musulmana, a tenere insieme i sudditi nella casa comune.
Tramontata l’età dell’oro, l’egemonia di Costantinopoli si fa sempre più fragile, erosa dagli appetiti delle potenze europee e dalle rivolte locali. Gli stessi pascià, che sulla carta governano per conto del sultano, si ritagliano spazi sempre maggiori di autonomia, che a tratti sfociano in prove tecniche d’indipendenza. Tra i primi aspiranti raìs locali spiccano i Karamanli, ambiziosi khoulouglis (letteralmente «figli della serva», come erano chiamati i discendenti delle mésalliance tra ufficiali turchi e donne arabe) che a fasi alterne nel Settecento e Ottocento impongono una monarchia dinastica in ampie fette della Tripolitania e della Cirenaica. Merita una citazione particolare Yusuf Karamanli, alleato di Napoleone nella campagna di Egitto (1799) e primo leader libico ad andare allo scontro militare con gli Stati Uniti.
A quei tempi Washington versava nelle casse di Tripoli somme ingenti per garantirsi l’immunità dagli attacchi dei corsari della Barberia. Pagare per ottenere protezione dagli sponsor dei pirati era una consuetudine accettata da tutte le potenze occidentali, ma la decisione di Yusuf di alzare il prezzo del «pizzo» provoca la reazione della Casa Bianca, dove nel 1800 John Adams lascia il posto al meno accomodante Thomas Jefferson. Il presidente si rifiuta di negoziare con i terroristi del tempo o con lo «Stato canaglia» ante litteram che li sostiene. Quasi due secoli prima dell’operazione El Dorado Canyon firmata da Ronald Reagan (1986), nel 1804 Jefferson è il primo presidente degli Stati Uniti a muovere guerra a Tripoli, puntando a sostituire il tiranno con il più malleabile fratello Hassan. La prima operazione militare oltremare della storia statunitense riesce a metà: il pizzo viene solo ridotto e Yusuf rimane al potere. Ma dopo l’umiliante conquista della fregata Us Philadelphia da parte dei pirati – che prendono in ostaggio l’equipaggio – i Marines al debutto riescono a espugnare il porto di Derna, dove sventolerà per alcuni giorni la bandiera a stella e strisce. Testimonianza della prima sortita dell’impero che verrà voluta dal primo teorico dell’Empire of Liberty e della promozione della democrazia su scala globale che spetterebbe agli Usa. Dell’impresa rimarrà traccia anche nell’inno dei Marines, in cui «le spiagge di Tripoli» affiancano le «stanze di Montezuma», souvenir della guerra con il Messico del 1846-1848.
La forza dei Karamanli rimane però quella del mezzadro che strappa temporaneamente poteri al padrone negligente. Ad avere un significato e un impatto più profondo è piuttosto l’emergere di un’opposizione realmente autoctona al dominio straniero, che si manifesta in parallelo alla caduta dei pascià troppo indipendenti e, soprattutto, all’ingresso nel campo di gara delle potenze europee.
Nel 1835 gli ottomani depongono l’ultimo monarca e riprendono il controllo diretto della costa mediterranea. Minacciato su più fronti, l’impero prova a consolidare la sua presenza rafforzando l’apparato burocratico e militare anche all’interno, ma perde inesorabilmente terreno di fronte all’avanzata delle potenze europee in cerca di terre da colonizzare. Il primo ad affacciarsi in Africa è Napoleone, che, alla testa dell’Armata d’Oriente, nel 1798 piega i Mamelucchi e conquista per breve tempo l’Egitto. Sarà poi la Francia orleanista a fondare la prima vera colonia africana, in Algeria, nel 1830.
Stimolata dalla seconda Rivoluzione industriale e dal nuovo nazionalismo, la corsa verso sud delle potenze europee accelera il declino del vecchio impero. La competizione s’intensifica dopo l’apertura del Canale di Suez (1869), che restituisce centralità strategica al Mediterraneo. Londra si prende l’Egitto e il Sudan (1882), la Germania il Camerun e il Togo (1884). Il Belgio conquista il Congo, le cui enormi risorse vengono incamerate dal re Leopoldo come patrimonio personale dal 1885 al 1908. La Francia, dopo l’Algeria, allarga i suoi possedimenti nel Maghreb in Tunisia (1881), una conquista subita come uno schiaffo dall’Italia, che aveva avviato da tempo una colonizzazione dal basso. Qualche anno dopo, la disfatta di Adua (1896) congela anche le ambizioni di Roma nel Corno d’Africa. In cerca di «un posto al sole», gli italiani iniziano una lenta penetrazione della Tripolitania e della Cirenaica: entrano nei traffici commerciali, nell’industria leggera, nell’agricoltura e nel sistema creditizio, con l’apertura di filiali del Banco di Roma,1 motore dell’iniziativa libica. È una nuova colonizzazione dal basso, che prepara la strada all’intervento militare.
La disgregazione progressiva del tutore ottomano e la sua arrendevolezza di fronte agli invasori infedeli, che dispiegano tutta la forza di uno Stato moderno centralizzato, accendono i primi fuochi di rivolta nella popolazione araba. Accade anche all’interno della Libia, dove prendono le armi alcuni leader tribali, come Abdel Jalil Seif al-Nasr, che conquista il Fezzan e unisce le tribù della Tripolitania e quelle della Sirte (inclusa la qabila dei Gadadfa) nella lotta contro Costantinopoli. La resistenza all’invasore, però, va incontro alla dura repressione orchestrata dal generale Ahmet Pasha Izzet.
Avrà un’influenza molto più duratura sulla storia nazionale la nascita della confraternita della Senussia, espressione nella prima metà dell’Ottocento del risveglio religioso e politico delle genti della Cirenaica. Oltre un secolo dopo, i senussi daranno alla Libia indipendente il suo primo e unico re, ma il capostipite della famiglia, Muhammad ibn Ali al-Sanusi, era originario di un villaggio dell’Algeria. Il gran senusso, come viene presto ribattezzato per il suo baraka (carisma), allarga progressivamente la propria influenza prima alla Mecca – dove fonda il primo zawiya (monastero sufi) ma viene cacciato dai wahhabiti –, poi a Beida, in Cirenaica, dove si ferma e fonda lo Zawiya Bayda (Monastero Bianco).
A fare presa sui beduini della regione è la religiosità ascetica praticata dallo sceicco e dai suoi seguaci, disadorna come ai tempi del Profeta, che ispira anche un embrione di governo in un territorio de facto autonomo, attorno alla «capitale» Giarabub. La confraternita sostiene i suoi adepti attraverso un equo sistema di tassazione e crea così una nuova identità sociale che si sovrappone ai legami tribali. Dall’Algeria caduta in mano ai francesi, i senussi esporteranno idealmente in Cirenaica – e in misura molto più limitata in Tripolitania e Fezzan – anche lo spirito di resistenza nei confronti dell’invasore.
La diffusione della loro dottrina in un primo tempo è vista con favore dagli ottomani, convinti che possa arginare la crescente presenza francese. Pensiero condiviso dal governo italiano, che a metà dell’Ottocento fa arrivare alla confraternita un carico d’armi. La storia vuole che quelle armi verranno poi usate contro gli stessi italiani. La Senussia diventerà il fulcro della lotta contro il colonizzatore in Cirenaica.
Attorno al progetto coloniale nell’Italia giolittiana si forma un vasto consenso. L’operazione sembra avere una sua ratio strategica: Roma vuole contrastare l’espansione dei rivali europei che hanno occupato ormai quasi tutta l’Africa del Nord. Punta sulla «quarta sponda» per controllare le vie di comunicazione del Mediterraneo, a cui l’apertura di Suez ha ridato l’antica centralità, aprendo al contempo una porta verso le risorse africane. Più in generale, «l’impresa libica» può rialzare il profilo della politica estera italiana senza eccessivi rischi, o almeno di questo sono convinti i vertici militari, confidando nella debolezza dell’anacronistico esercito del sultano. Gli indigeni, immaginano a torto a Roma, non potranno che accogliere gli italiani come dei liberatori dal giogo ottomano.
La campagna di Libia viene promossa dagli ambienti nazionalisti, ma trova sostenitori persino a sinistra. Anche Giovanni Pascoli impartisce ex post la sua benedizione, integrando il suo socialismo umanitario con una robusta dose d’imperialismo proletario. I lavoratori – vaticina il poeta da Barga – troveranno sull’altra sponda del mare nostrum quegli spazi, quelle terre fertili e quelle opportunità, che nelle sovrappopolate campagne italiane e nei Paesi di migrazione europea sono loro negati.2 Così dopo un’accurata preparazione diplomatica, «la Grande Proletaria» guidata dal titubante presidente del Consiglio Giolitti si muove davvero.
3. L’avventura italiana in Libia
Il 29 settembre 1911 l’Italia dichiara guerra all’impero ottomano, l’11 ottobre prende Tripoli, il 20 Bengasi e il 5 novembre dichiara unilateralmente l’annessione di Tripolitania e Cirenaica, scatenando la rivolta degli arabi, più difficile da sconfiggere delle forze imperiali ottomane. Con Costantinopoli, Roma trova un accordo ambiguo un anno dopo, a Losanna, quando la rivolta della regione balcanica costringe i turchi a firmare la pace. L’Italia ottiene l’amministrazione civile e militare della Cirenaica e della Tripolitania, ma non la sovranità sui due vilayet (provincia ottomana) a cui i turchi rinunceranno formalmente solo nel 1923, quando l’impero non esiste più, sostituito dalla repubblica nazionalista e laica di Mustafa Kemal Atatürk, e l’Italia liberale ha lasciato il posto a quella fascista.
La guerriglia araba continua in tutti quegli anni anche se in modo disuguale, com’è disuguale la colonizzazione italiana nelle diverse entità che comporranno poi la Libia. Il Fezzan rimane a lungo più cosa francese che italiana, la conquista riguarda Tripolitania e Cirenaica. L’ingresso a Tripoli e dintorni non incontra grandi resistenze: la costa è abituata agli stranieri, pensa agli affari e il ceto mercantile – le potenti famiglie Muntasirs e Suwayhli in testa – non è ostile ai nuovi partner. In Tripolitania, anche negli anni successivi, i contrasti tra berberi e arabi e tra i diversi capi tribù agevolano il compito ai colonizzatori. In Cirenaica la penetrazione italiana è più complessa perché ostacolata dai senussi. Nella zona costiera tra Bengasi e Derna, gli adepti della confraternita sono costretti a capitolare, ma conservano il controllo dell’interno. Roma conquista l’agognata «quarta sponda», ma poco più. Le ribellioni non mancano.
Nel 1918, in Tripolitania, un pugno di uomini capitanati dall’egiziano Abd al-Rahman Hassan Azzam di concerto con Suleiman al-Baruni proclama l’effimera Repubblica di Tripolitania. È il primo esperimento repubblicano nell’intero mondo arabo, ma dura poco.3 La mancata coesione tra regioni e più ancora tra tribù azzoppa ogni tentativo unitario, tanto nell’età del dominio coloniale quanto, e forse più, in quella dell’incerta indipendenza dello Stato nazionale. La stessa insorgenza dei senussi rimane in buona parte un fattore regionale. I contrasti interni impediscono la formazione di un fronte comune contro l’invasore e favoriscono l’ingerenza degli attori stranieri.
Con lo scoppio della Prima guerra mondiale, la situazione si complica per gli italiani. Mancano ri...