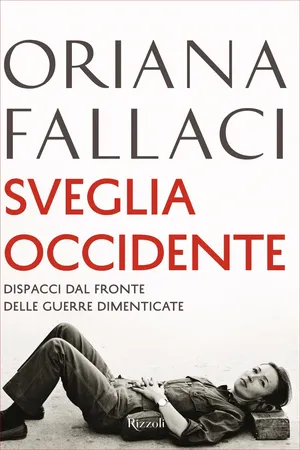Hanoi, marzo 1969
Anzitutto, l’angoscia. Essa ti prende non appena atterri sulla pista buia, è già sera, e due poliziotti salgono sull’aereo: a requisire il passaporto che ti verrà reso quando ripartirai. Sono i primi nordvietnamiti vivi che incontri, nel Vietnam del Sud li hai sempre visti morti: ricordi? Raggricciati dentro le trincee di Dak To, squarciati sotto le mura di Hué, decomposti al sole di Saigon. Guardavi quei cadaveri e ti sembrava che i nordvietnamiti non si potessero vedere che morti. Anche per questo li amavi, volevi venire qui a vederli vivi, ti chiedevi come fossero da vivi. Ecco, così. Attraverso il chiarore della lampada tascabile gli cerchi il volto, gli sorridi e gli dici buonasera. Ma nessuno dei due ti risponde, nessuno dei due ti restituisce il sorriso, e la loro espressione è di pietra, i loro occhi sono più freddi del freddo che entra dallo sportello quando, con un gesto brusco, ti permetton di scendere. Sei giunto ad Hanoi.
L’inverno è ghiaccio ad Hanoi, ma non è per l’inverno che rabbrividisci ora che ti senti scrutato da pupille dure e ostili, qualcuno ti porge un modulo dove elencherai qualsiasi cosa tu porti addosso o in valigia, compreso l’orologio da polso, la penna, gli anelli. E devi anche dire se insieme alle macchine fotografiche hai rotolini in bianco e nero o a colori: i primi saranno sviluppati e censurati dopo l’uso, i secondi sono proibiti. «Ne ho solo tre» menti rabbrividendo. E se si accorgon che menti? Sanno che non sei comunista: al primo errore potrebbero spedirti via con l’aereo da cui sei sceso. «Li consegni tutti e tre». Li consegni. Sali sull’automobile che ti conduce in città, attraversi il lungo ponte distrutto su cui si accaniron le bombe degli americani, ti inoltri per le strade deserte dove incroci soltanto qualche vecchio camion militare, arrivi all’albergo: e solo allora la tua angoscia si allenta. Ma rimane l’amarezza, il dispetto di accorgerti che è assai più facile amarli da lontano o dalla parte opposta della barricata. Forse li hai amati troppo, li hai pianti troppo, li hai idealizzati troppo. Visti da vicino, non potevano che ferirti.
Ciò che segue è il diario dei miei dodici giorni nel Vietnam del Nord. Attraverso la Cambogia vi entrai, nel mese di febbraio, con una delegazione di donne italiane: né fu facile. Nessun giornalista indipendente era mai partito dall’Italia per mettere piede ad Hanoi e i nordvietnamiti sapevano bene che ero stata tre volte a Saigon, che laggiù avevo seguito in combattimento gli americani, indossando un’uniforme americana, portandomi in tasca documenti americani. Forse sapevan perfino che un giorno, insieme a un pilota senza eccessive pietà, ero stata su un A-37 che aveva bombardato la zona del Delta, sganciando napalm. Non credevo che il visto venisse. Invece venne e quella sera, era un venerdì, sbarcai ad Hanoi. E da quella sera annotai su un quaderno tutto ciò che vedevo, udivo, sentivo. Doveva servirmi a ricavare una serie di articoli. Ma quando lo rilessi mi accorsi che era molto più onesto lasciare il racconto com’era, al massimo completandolo con ricordi e appunti sparsi. Eccolo dunque. Ve lo do ben sapendo che irriterà chi non deve irritare, compiacerà chi non deve compiacere. Ma tale è il destino di chi fa il giornalista obbedendo alla propria coscienza anziché agli interessi dei più. Cioè, un destino assai scomodo.
Dall’altra parte della trincea
Venerdì notte. Voglio inaugurare subito questo quaderno. Mi aiuterà a non dimenticar nulla e a superare l’avvilimento che è in me. Ho già capito infatti che qui non potrò lavorare come a Saigon, nella libertà di movimento che gli americani ti danno anche se parli male di loro. Qui sarò costretta a vedere solo ciò che mi faranno vedere, ascoltare solo ciò che mi faranno ascoltare, andare solo dove mi faranno andare. Non ho ancora avuto il permesso di dare uno sguardo ad Hanoi, sono affidata a due guardiane che non mi lasciano mai, mi sembra d’esser Pinocchio fra il Gatto e la Volpe. Il Gatto si chiama The ed è una matrona sulla cinquantina, con un gran viso piatto e un corpo pesante, due pupille che ti rincorrono fin dentro i pensieri. La Volpe si chiama Huan ed è uno gnomo di un metro e quarantacinque, trasparente, consunto. Di solido, in lei, non vi sono che i denti: enormi, piantati diagonalmente alle gengive, e così in fuori che non può chiuder la bocca. Sono perseguitata da quei denti come dalle sue manine che hanno la robustezza di artigli. Specialmente quando mi afferrano per impedire che mi allontani. Poco fa ero uscita sul marciapiede. Mi ha raggiunta e: «No! No! Dentro!». «Ma perché, Huan, suvvia, voglio fare un giretto.» «No! No! Domani!» «Ma perché domani e non ora, Huan, ti prego, sono appena le nove.» «Domani.» Mi ha piantato gli artigli nel braccio e mi ha riportata dentro il Metropole.
Ci hanno messe al Metropole. Dal 1954 si chiama Riunificazione ma gli stranieri continuano a dire Metropole. È l’albergo degli stranieri e il migliore della città: chissà gli altri. Da quando i francesi lo costruirono, i vietnamiti non si son curati neanche di darci un’imbiancatura: ancora un po’ e cadrà a pezzi. Le finestre non chiudono, le tubature non funzionano, l’acqua calda non scorre, la sporcizia vi regna sovrana e non puoi protestare. Oltre a sottolineare che questo è un Paese in guerra, ti ricorderebbero che vi sei ospite. Come sei in realtà. Nessuno entra nel Vietnam del Nord da visitatore o turista: si entra solo ospiti del governo che provvede al tuo alloggio, al tuo cibo, al tuo trasporto, e perfino alle tue spese minime. Appena giunta ho detto a The che volevo cambiare alcuni dollari in dong, la moneta di Hanoi. Ha risposto: «Perché?». «Be’, nel caso voglia comprare qualche cartolina.» «Le cartoline te le diamo noi.» «Be’, allora nel caso che voglia comprare alcuni francobolli.» «I francobolli ce li mettiamo noi.» «Be’, nel caso che voglia comprare un pacchetto di sigarette.» «Le sigarette sono in camera tua, con la frutta. Se non ti bastano, non hai che da chiederle.» Ho insistito scherzando che, da buona capitalista, non posso stare senza soldi in tasca, mi ammalo: ha preso venti dollari ma ha replicato che il cambio è chiuso fino a lunedì e che lunedì andremo in provincia dove non ci sarà bisogno di dong. Tra parentesi: non è straordinario che l’unica moneta di scambio sia il dollaro? Mi fa venire in mente quel marine di Saigon che in un certo negozio non riusciva a pagare in dollari e, disperato, gridava: «This is the damn best money in the world!». Questo è il dannato denaro migliore del mondo!
Il programma del nostro soggiorno è già stato stabilito: in ogni minimo particolare e senza consultarci. Sono riuscita solo ad aggiungere che vorrei incontrare il generale Giap e due piloti americani. Se almeno potessi prender contatto coi giornalisti stranieri: mi darebbero un consiglio. So che vi sono i russi della Tass, della Isvetzia, della Novosti, i francesi della France Presse e dell’Humanité, due cubani: però telefonargli è impossibile, recarsi ai loro uffici anche. In tutta Hanoi vi saranno sì e no trecento telefoni, al Metropole devi chiedere la cortesia a un portiere che non risponde o finge di non capire. I taxi non esistono: le auto che vedi appartengono allo Stato e non puoi usarle senza un permesso speciale. Anche se sfuggissi a Huan, non andrei lontano. E poi i rapporti fra gli stranieri non sono ben visti; quando ho detto a The che vorrei conoscere i colleghi russi o francesi s’è irrigidita e ha risposto che chiederà il permesso al ministero delle Informazioni. È allucinante. Quattro ore sono già bastate a trasferirmi in un racconto di Kafka, in un libro di Orwell. E se rovistando nella mia camera scoprissero che ho trattenuto per me alcuni rotolini a colori? Forse è meglio che li nasconda in un altro posto. O che li dia a Carmen, a Giulia, a Marisa: le tre donne della delegazione. Le prime due sono comuniste, la terza è socialista di unità proletaria: dovrebbero apparire meno sospette di me. Anche Carmen, Giulia e Marisa mi sembrano perplesse da questo primo incontro con Hanoi. Però Carmen ha detto una cosa: «Siamo capitate in un momento di quiete, cioè in un momento che non favorisce indulgenza». E mi pare giusta. Forse un anno fa quando Hanoi era sconvolta dagli allarmi aerei, dalle esplosioni, dalla tragedia, non me la sarei presa per certe piccole cose e il loro eroismo mi avrebbe sedotta. Scomparsi i bombardamenti, e con essi l’atmosfera di eroismo, i difetti balzano agli occhi con maggiore evidenza.
Aspettiamo comunque a giudicare, tentiamo piuttosto di dormire: domattina la sveglia è alle sei, il primo appuntamento alle sette. Sembra che qui si alzino all’alba, come nei conventi. Ma qualsiasi cosa abbia visto dacché sono sbarcata mi fa pensare a un convento. Voglio dire questo mortificarsi in una totale assenza di comodità, di allegria, di bellezza. La guerra non c’entra. Anche a Saigon c’è la guerra. Saigon, in fondo, è più tragica di Hanoi: bombardata dagli americani, dai vietcong, dai nordvietnamiti, dai sudvietnamiti, paralizzata dal coprifuoco, dai combattimenti per strada, dagli arresti, dalle esecuzioni. Eppure a Saigon la gente sa ridere, sa apprezzare il piacevole, e le donne sono le donne più graziose del mondo. Guarda queste, invece. Sciatte, spettinate, sempre brutte. Verrebbe voglia di urlare: datti un colpo di pettine, perbacco, datti un po’ di rossetto, non andrai mica all’inferno se lo fai! Forse è l’esempio di Ho Chi Minh che, chiuso in una specie di cella del palazzo presidenziale, un lettino una sedia un tavolo un armadio, vive da quattordici anni con tre vestiti lisi e tre paia di sandali. O forse è l’esempio di qualcun altro. Qui al Metropole vi sono cinquanta cinesi. Autorelegati nell’ala al di là del giardino, non si mostrano mai. Però cinque minuti fa, affacciandomi alle scale, li ho visti passare. Procedevano in fila indiana, senza un sorriso. Composti nella identica triste uniforme, senza una parola. Sembravano monaci che si avviano in chiesa per le preghiere della sera. Solo che invece del crocifisso portavan sul petto una grande medaglia di Mao.
Sabato mattina. Sono scappata! Ci sono riuscita! È successo dopo l’incontro mattutino con Nguyen Thi-tap, la presidente dell’Unione donne vietnamite. Bel personaggio, se avessi potuto intervistarla a quattr’occhi. Tutti i suoi figli li ha persi alla guerra, l’ultimo è morto quest’anno nel Sud, e lei sorride: serena. Mi sarebbe piaciuto chiederle: come fai a sorridere, Tap? Ma i quaranta minuti trascorsi nel suo salottino, sotto un ritratto di Ho Chi Minh, si sono risolti in un noiosissimo scambio di convenevoli, tazze di tè senza zucchero, e il mio bisogno di scappare s’è fatto spasmodico. Così, quando Huan e The ci hanno riportato in albergo, ho colto un loro attimo di distrazione e sono sgusciata via, verso il lago: per trovarmi subito chiusa da un codazzo di bambini che mi tastavano, mi agguantavano, mi tiravano, poi da una folla che mi serrava in un cerchio muto, sorpreso, e mi esaminava come noi esamineremmo una creatura scesa da Marte. Si sono fermati anche due miliziani e ciò m’ha innervosita perché avevo la macchina fotografica. Ma, dopo avermi guardato male sotto il berretto con la stella rossa, se ne sono andati. E a forza di spintoni, suppliche, ho potuto aprirmi un varco per continuar la mia strada.
Non ho visto distruzioni. Le zone colpite sono evidentemente nei quartieri periferici, lungo la ferrovia. Al centro non v’è neanche un edificio crollato, incrinato, e i rifugi hanno quasi un’aria superflua. Ve ne sono a centinaia, migliaia. Specie quelli rotondi, a fil di terra, per una persona sola. Sembrano bare cilindriche, con il coperchio a lato, e bucano i marciapiedi come piccoli crateri lunari. Bisogna fare attenzione a non caderci dentro e il trabocchetto ti attende ogni cinquanta centimetri. Mi son messa a fotografarli e una donna s’è offerta come comparsa, ci si è calata dentro. La folla, intorno, annuiva con severità. Quando la donna è risalita su, ho tentato di parlarci in francese ma non mi capiva ed è intervenuta una studentessa-operaia che sapeva un poco di inglese. «No bombing now! Finished!» ho detto. (Niente bombardamenti, ora, finito!). Ha risposto: «No believe. Americans always lies. We ready». (Non credere, americani sempre bugie. Noi pronti). Ho insistito: «No, no! Finished! Really finished!». (No, no, finiti, davvero finiti!). Ha torto la bocca: «May be, May be not, Gion Son still». (Forse sì, forse no, Gion Son ancora). Gion Son sta per Johnson che qui vuol dire bombe. Dio, cosa devon essere stati gli anni dei bombardamenti se ancora non credono che siano finiti. A ogni ora del giorno e della notte, settimana dopo settimana, mese dopo mese, in perpetuo. Ha davvero ragione Carmen: bisogna pensare a com’era fino al 31 marzo 1968. D’accordo, ci penso. Ma allora perché non riesco ugualmente a provare la commozione che suscitavano in me da lontano? Allora perché di questa città colgo solo la tristezza mortificante, la monotonia ossessionante?
Per cominciare, non vedi colori. Sono tutti vestiti uguali: uomini, donne, bambini. Di blu, come i cinesi. Quando non sono vestiti di blu sono vestiti in uniforme, cioè in grigioverde. Sicché l’unica macchia che interrompa quel mare di blu e grigioverde è il rosso delle bandiere rosse. Poi, non odi mai i rumori tipici e vivi di una città. A parte qualche camion militare, qualche antico tranvai da cui ciondolan grappoli umani, l’intero traffico si svolge su biciclette. Fiumi e fiumi di biciclette che passan frusciando e non scampanellano mai. Neanche i tranvai del resto scampanellano mai. Né i camion suonano il clacson. E il risultato è un silenzio disumano, impossibile, che d’un tratto si rompe in una voce immensa o in un’immensa canzone di guerra. Ti giri spaventato a guardare, a tentar di capire da dove essa giunga, e ti accorgi che giunge da ovunque: dai tetti, dagli alberi. Sono gli altoparlanti che prima annunciavano l’allarme aereo e ora invece trasmetton consigli, notizie, poesie di Ho Chi Minh, marce e cori arrabbiati. Infine, la miseria cupa. Tutte le case, gli edifici pubblici, risalgono al tempo dei francesi. Partiti loro, nessuno ha costruito più nulla. Peggio: nessuno ha fatto nulla per mantenere quel che esisteva. Così le palazzine che al tempo dei francesi dovevano esser graziose, pulite, ora sono sozze e nere e cadenti. E la gente ci vive ammassata fra i topi e il fetore. Guarda il teatro municipale: non era mica brutto. Oggi vi si disfanno perfin le persiane. Guarda quel cinematografo: non era mica peggiore dei nostri. Oggi è una bettola. Che sia perché gli uomini sono alla guerra? Ma no, e le donne li sostituiscono bene. Una ripulita potrebbero darla, una mano di calce, una martellata su un chiodo che casca.
Non esistono praticamente ristoranti, negozi. L’unico vero ristorante è quello (proibito ai vietnamiti) dove vanno gli stranieri: in massima parte laotiani e cubani. Assomiglia a una mensa popolare di terza categoria e ti toglie l’appetito a entrarci. Quanto ai negozi eccoli qua: una botteguccia con due pezze di stoffa e due manichini biondi (francesi) del 1930; una libreria dove trovi solo materiale di propaganda, agiografie di Ho Chi Minh; un posto dove vendono i francobolli per collezione, i dischi rivoluzionari, i ritratti di Marx. Gli acquisti veri e propri, carta di razionamento alla mano, si fanno nei Magazzini riuniti: una specie di grande emporio a tre piani. E poi, lungo il lago, c’è una gioielleria. Contiene un bel servizio d’argento che però non è in vendita, alcuni anellini e pettini fatti con l’acciaio degli aerei americani abbattuti, alcuni soprammobili di tartaruga, un piattino da caffè con sette pietruzze semipreziose, una collana. È una collana di perle false e cristalli, col fermaglio arrugginito. La regge una mano di gesso, europea. È chiusa dentro una bacheca di vetro. Costa sei dong, circa settecento lire.
Sono rimasta per strada quasi un’ora. Quando sono rientrata le mie guardiane erano in preda a una rabbia feroce. «Dove sei stata? Che hai fatto? Non si può. Non bisogna.» Huan mi ha afferrata con gli artigli e credevo che mi graffiasse. Ma perché questa gente non sa farsi gli amici, anzi conservarseli? Vieni qui pieno di rispetto, di pietà umana, e appena ti muovi ricevi uno sputo sul cuore.
Sabato pomeriggio. Dopo il rimprovero sono stata condotta alla sede del Fronte nazionale di liberazione. In automobile, sebbene si trovi a cento metri dal Metropole. Dice che a piedi non possiamo andarci perché «le biciclette sono pericolose». Ho chiesto: «Anche sui marciapiedi?». «Sì, anche sui marciapiedi.» Perbacco, con loro non ti sposti che dentro quel macinino. Il Fronte è una palazzina pulita e ha tutta l’aria di un’ambasciata. Con la sua sentinella, la sua bandiera. Mi ha ricevuto un tipo di mezza età, cordiale: Nguyen Phu-soai, di Saigon. Quando The gli ha spiegato che conosco bene Saigon, i suoi occhi si sono riempiti di lacrime. Mi racconti, diceva, è molto distrutta Saigon? La mia gente è molto infelice a Saigon? Non vedo Saigon da dodici anni. Ma le mie guardiane hanno tagliato corto, tal racconto non era in programma, in programma era l’intervista con due eroine vietcong: condotte lì apposta per me. Una bambina dagli occhi di cerbiatto, Ho Thi-thu, e una giovane donna cui mancava una gamba: Huynh Thi-kien. Catturata dagli americani, liberata dai guerriglieri. Hanno incominciato con lei. Huan, The e Nguyen Phusoai assistevano al dialogo e annotavano scrupolosamente tutto ciò che chiedevo o mi veniva risposto. Lo annotava anche un omino secco che d’ora innanzi mi seguirà ovunque come interprete: il camerata Ho. Così saranno in tre a sorvegliarmi.
Huynh Thi-kien, contadina di Quang Nam. Analfabeta, anni ventuno. Grassa, brutta, triste. Nella Resistenza dal 1958, come i suoi fratelli. Portaordini e poi combattente. «Raccontami la prima volta che ammazzasti un uomo, Kien.» «Non uno, tre.» «Racconta.» «Fu nel 1964. Su una collina vicino a Danang. Erano le nove di sera, pioveva. Con un’altra ragazza io facevo parte di un gruppo di trenta uomini. Ma io e lei avevamo quattro granate ciascuna e basta. Così abbiamo strisciato fino alla cima della collina e qui ho visto l’americano. Non avevo mai visto un americano e al solo pensare la parola americano mi si piegavan le gambe.» «Com’era questo americano, Kien?» «Era grande, molto grande, e peloso. Aveva tanto pelo sul viso e sui bracci. Ce l’aveva perfin sulle mani. Pelo rosso. Era orribile con quel pelo rosso e mi ha fatto tanta paura e gli ho tirato la granata, e l’ho preso. Allora s’è messo a gridare, piangeva e gridava, e sono arrivati altri due pelosi come lui. Per aiutarlo, credo. Così ho aspettato che fossero chini su lui e ho tirato la seconda granata e li ho ammazzati tutti e tre, sono andati a pezzi perché ero molto vicina.» «E cosa hai sentito, Kien, quando sono andati a pezzi?» «Mi son sentita felice. Come una gran voglia di ridere.» «E la gamba, quando l’hai persa, Kien?» «Tre anni dopo, presso Hoi An.» «Come l’hai persa, Kien?» «Me l’hanno tagliata gli americani. Sono una vittima delle atrocità americane.»
The ha annuito, soddisfatta. Huan ha annuito, soddisfatta. Soai ha annuito, soddisfatto. «Come te l’hanno tagliata, Kien?» «Mi torturavano, sono svenuta. Poi mi sono svegliata e la gamba non c’era più.» «Kien, una gamba non si taglia per tortura. Per tagliare una gamba e non morir dissanguati ci vuole un regolare intervento chirurgico. Dov’eri quando ti sei svegliata?» The ha alzato un sopracciglio, Huan mi ha fissato con antipatia, Soai ha stretto le labbra. «Ero in un letto.» «E la gamba era fasciata?» «Sì, era fasciata.» «Dimmi la verità, Kien: ti avevano catturata ferita alla gamba?» «Sì, c’era stato quel combattimento e io ero rimasta ferita alla gamba.» «E non può darsi che all’ospedale ti abbiano tagliata la gamba perché non c’era altro da fare?» «Loro mi torturavano. Mi hanno legato a quel tavolo, con le braccia sotto il tavolo, e mi tiravano pugnalate sulla gamba ferita.» «Loro chi? Gli americani?» «No, un soldato fantoccio, un sudvietnamita. Ma l’americano stava a guardare. Con quel frustino in mano diceva: “Sei una brava ragazza, parla”. E lasciava che l’altro mi pugnalasse. Che differenza fa?» «Non molta. Ma bisogna spiegarci bene, Kien.» A questo punto però Soai ha detto che Kien aveva molte cose da fare, The ha detto che Kien era assai stanca, e Kien s’è alzata, obbediente, e se n’è andata oscillando sulla sua povera gamba di legno, e non ho potuto sapere di più. Siamo passati alla bambina.
Ho Thi-thu che vuol dire Autunno. Figlia di contadini anche lei, analfabeta anche lei. Piccina, commovente, anni quindici. Ma ne dimostrava al massimo dodici ed era così assurdo vederla vestita da guerrigliera. Per presentarmela le avevano messo la giacca grigioverde, il cappelluccio vietcong, la sciarpa vietcong, e anche una delle sue molte decorazioni. «Qual era il tuo lavoro, Thu?» «Io, sai, seguivo il nemico per vedere dove andava, e contare le armi che aveva, e lo seguivo anche nel bosco dove i soldati dicevano: “Dove vai, bambina?”. E io rispondevo: “Vado dalla mia nonna”. E allora i soldati dicevano: “Sei una vietcong, bambina?”. E io rispondevo: “Khong, no!”. Dapprincipio, sai, avevo paura. Ma poi c’è stato quel congresso di guerriglieri, dentro la giungla, e loro mi hanno spiegato che non bisogna avere paura per vincere la guerra e liberare la patria.» «Thu, sapresti dirmi cos’è la guerra, Thu?» «Oh, la guerra sono gli americani che vengono qui per distruggerci e perché i genitori si separino dai loro bambini e le donne dai loro mariti.» «E la patria cos’è, Thu?» «Oh, questo non lo so, io fo le cose che gli zii e le zie mi dicono di fare, e non pongo domande, ma credo che la patria sia il villaggio dov’è la mia mamma, che mi manca tanto. Gli zii e le zie sono buoni con me, però io vorrei la mia mamma.»
Gli zii e le zie sono i membri del partito, presso cui vive dacché l’hanno portata ad Hanoi per farla diventare una vera guerrigliera e poi rinviarla al Sud. Ed era chiaro quanto gli zii e le zie non le bastassero: si stringeva a me con tenerezza, mi affondava gli occhi negli occhi, voleva seguirmi a ogni costo. «In Italia, Thu? Ma lo sai dov’è l’Italia?» «Oh, sì. Lontano, laggiù, in Europa. Vicino alla Francia.» «E la tua mamma sarebbe contenta se ti portassi in Italia?» «Oh, la mia mamma è se...