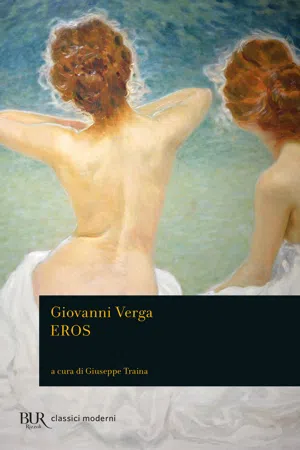Verso le quattro di una fra le ultime notti del carnevale, la marchesa Alberti, seduta dinanzi allo specchio, e alquanto pallida, stava guardandosi con occhi stanchi e distratti, mentre la cameriera le acconciava i capelli per la notte.
«Che rumore è cotesto?» domandò dopo un lungo silenzio.
«La carrozza del signor marchese.»
«Così presto!» mormorò ella soffocando uno sbadiglio.
La cameriera era per chiudere l’uscio del salottino che metteva nelle stanze del marchese, allorché entrò bruscamente un uomo in abito da maschera, col passo malfermo, e la fronte altera.
«Cecilia dorme?» domandò senza fermarsi.
«L’ho lasciata or ora, signor marchese» rispose la cameriera mal dissimulando la sorpresa.
«Domandatele se può accordarmi cinque minuti.»
Egli rimase immobile, col ciglio corrugato, e lo sguardo fiso dinanzi a sé. La cameriera ritornando sollevò la pesante portiera di velluto; il marchese fece alcuni passi verso l’uscio, volse gli occhi a caso su di un grande specchio che gli stava di faccia: sembrò esitare un istante, poscia fece un movimento di spalle, aggrottò il sopracciglio, ed entrò col sigaro in bocca.
La marchesa leggeva, voltata verso il muro: udendo il passo di lui chiuse il libro, e domandò senza muovere il capo:
«Siete voi?».
«Sì.»
Ella alzò gli occhi verso l’orologio appeso alla parete.
«Son le quattro e mezzo» rispose il marito a quella muta e significativa interrogazione, masticando il sigaro fra i denti.
Cecilia soffocò due o tre colpettini di tosse, e gli disse:
«Datemi quella boccettina che è lì sul tavolino, vi prego». Egli buttò il sigaro nel camino, e non si mosse.
Allora la marchesa si voltò verso di lui, con un brusco movimento che modellò le coperte sulla più elegante figura di donna; si passò una mano più bianca della batista che le cadeva lungo il braccio, sui folti capelli castagni, e fissò in volto al marito i suoi grand’occhi scuri bene aperti.
Egli era ritto, immobile, serio – troppo serio per gli abiti che indossava – e avea tuttora un leggiero strato di polvere sui capelli e sul viso; dovea essere giovane, invecchiato anzitempo, pallido, biondo, elegante, alquanto calvo.
«Dovete parlarmi?» domandò la marchesa dopo un breve silenzio.
«Sì.»
«Sedete adunque.»
Egli volse un’occhiata sulle seggiole ed il canapè,1 ingombri di vestiti e di arnesi muliebri, e rispose secco secco: «Grazie».
«Vi chiedo scusa per la mia cameriera» disse la moglie arrossendo impercettibilmente.
Alberti inchinò appena il capo.
«Scusatemi piuttosto la mia visita importuna. Mi premeva di parlarvi... stasera.»
Cecilia gli lanciò uno sguardo rapido e penetrante, e domandò:
«Avete perduto?».
«Non ho giocato.»
«Vi battete...?»
«Sì.» Ella impallidì.
«Tranquillizzatevi» soggiunse il marchese. «Non mi batto col conte Armandi.»
Ella si rizzò a sedere sul letto, rossa in viso, coi capelli sciolti, e il corsetto discinto: «Perché mi dite cotesto, signore?».
«Perché il mio amico Armandi è spadaccino famoso, e avreste potuto essere inquieta per me.»
La donna rimase a fissarlo con estrema fermezza.
«Perché vi battete?»
Il marito sorrise – sorriso grottesco su quel viso impassibile – e rispose tranquillamente:
«Per voi».
La marchesa si passò il fazzoletto sulle labbra.
«Galli aveva lo scilinguagnolo un po’ sciolto e pretendeva avervi vista alla Scala, in dominò,2 nel palco del mio amico Armandi.»
«Eravate a cena?»
«Sì.»
«Ah, vi battete per un cattivo scherzo da dessert!» diss’ella sorridendo amaramente.
Il marchese la guardò fiso. Poscia, coll’aria più indifferente del mondo, prese un dominò ch’era sulla seggiola più vicina, lo buttò sul canapè, e sedette di faccia a lei. «Perdonatemi» soggiunse; «non potevo lasciar calunniare mia moglie.»
Ella s’inchinò, troppo profondamente ed ironicamente forse, e perciò tutto il sangue le corse al viso:
«Tutti sanno che Galli è geloso di voi perché gli avete rubato l’Adalgisa!».
«Lo sapete anche voi?» rispose il marchese accavallando l’una gamba sull’altra.
«Scusatemi, debolezze di donne!» diss’ella un po’ pallida, e cercando di sorridere.
«E di uomini, se volete» aggiunse il marito con galanteria.
Ci fu un istante di silenzio: ella giocherellava collo sparato3 del suo corsetto; egli dondolava la gamba posta a cavalcioni: evitavano di guardarsi.
«Ora, siccome vi confesso che mi preme di non rimetterci la pelle, e farò il possibile per bucare quella del mio avversario, domani alle 12 avrò passato il confine.»
Ella rialzò gli occhi su di lui, e ascoltava in silenzio.
«Desidero risparmiarvi tutti i piccoli disturbi della mia lontananza, e vorrei perciò regolare di comune accordo l’amministrazione della vostra dote...»
Cecilia non rispose.
«Vi lascerò procura affinché possiate riscuotere da per voi quella somma che crederete...»
«Starete lontano molto tempo?» interruppe bruscamente la marchesa.
«Non lo so io stesso... e se volete suggerirmi la cifra...»
«Fate voi.»
«Ma io... francamente... dividerei in parti eguali, come fra buoni amici.»
Ella, più pallida del lenzuolo che la copriva, inchinò il capo.
Il marchese si alzò, accese un sigaro alla candela, e al momento di andarsene aggiunse, colla medesima aria di noncuranza:
«Rimarrebbe ad intenderci sull’educazione di Alberto, nel caso che la mia assenza si prolungasse indefinitamente; ma il meglio, parmi, si è di uniformarci alla prescrizione della legge. Voi vi occuperete di lui sino a’ sette anni; dopo me ne incaricherò io».
E volgeva diggià le spalle. «Come desiderate che sia educato vostro figlio sino ai sette anni?» domandò la marchesa con voce malferma.
Il marito si fermò su due piedi, e parve riflettere un istante. «Mah!... come vorrete...» aggiunse poscia. «Se vi dessi alcun suggerimento vi farei torto. Ed ora perdonatemi il disturbo, e buona notte.»
Cecilia rimase immobile, muta, pallida, cogli occhi fissi; ma nel momento in cui egli stava per passare l’uscio, esclamò, con accento improvviso e soffocato, come se tutto il sangue le fosse corso impetuosamente al cuore: «Signore!» ...Egli si voltò. «Signore!» ...e le mancavano le parole.
«Parlatemi francamente, in nome di Dio!...»
Egli vide le lagrime che luccicavano negli occhi della moglie, senza batter ciglio. Istintivamente ella si arretrò, spaventata dallo sguardo freddo ed incisivo di quell’uomo che sembrava ricercare le angoscie orribili di lei sin nelle pieghe più riposte del suo cuore, per contemplarle con quel viso pallido e glaciale.
«Sembrami d’avervi detto abbastanza. Mi batto con Galli perché ha insultato la marchesa Alberti, e Armandi sarà il mio secondo. Parto per l’estero, vi lascio la metà della vostra rendita, il mio nome, ed il nostro Alberto sino ai sette anni. Ma il mio sigaro vi appesta la camera. Buona notte.»
Egli non si volse, ed ella non disse motto.
Passando dall’anticamera udì scampanellare nelle stanze della marchesa.
Il marchesino Alberti fu educato lontano da’ suoi, alla spartana, nel collegio Cicognini.1 Il padre era morto fuori d’Italia, quasi senza averlo conosciuto. La marchesa, sempre giovane ed elegante, la più bella toscana che fosse in Milano, andava a fargli visita una volta all’anno, quando c’erano le corse a Firenze, l’abbracciava, l’accarezzava, gli recava dei confetti, e rimontava in carrozza sorridente. Ella era stata colta da una pleurite, all’uscire dalla Scala, ed era morta prima che i suoi amici avessero tempo di far venire il figliuolo da Prato. Il povero orfanello aveva allora dodici anni, e conservava religiosamente le poche lettere che il babbo gli aveva scritto, e le scatole dei confetti che la mamma gli aveva regalato. Una volta avea chinato il capo, tutto vergognoso, allorché il suo amico Gemmati gli avea detto: «O perché il tuo babbo non vien mai a vederti?». Un’altra volta avea arrossito perché certi forestieri che visitavano il collegio avevano mostrato di conoscerlo come il figliuolo della marchesa Alberti, e poi aveva arrossito di avere arrossito. Sua madre non gli parlava mai del babbo. Di tutte coteste cose si rammentò più tardi.
Le prime inquietudini del cuore gettarono nella sua mente il germe funesto dello esame.
A 16 anni Alberto era un giovinetto alto e delicato, coi capelli biondi, il profilo aristocratico, un po’ freddo e duro, e il pallore marmoreo del padre, e i grand’occhi azzurri, il sorriso affascinante e mobilissimo della madre – cuore aperto a due battenti, immaginazione vivace, affettuosa, ma inquieta, vagabonda, diremmo nervosa, ingegno più acuto che penetrante, analitico per inquietudine o per debolezza di carattere – un ingegno che vi sgusciava dalle mani ad ogni istante – diceva il suo professore di filosofia – atto a fargli cercare la decomposizione dell’unità, o a dargli i peggiori guai della vita quando il cuore si fosse mescolato della bisogna. Egli aveva preso di buon’ora l’abitudine di pensare, come tutti i solitarj. Più tardi ebbe un amico, Gemmati, pel quale ebbe tenerezze e gelosie d’amante, sino a tenergli il broncio quando seppe che sorrideva alla figliuola del barbiere che stava di faccia. Molto tempo dopo, e in circostanze assai diverse, mentre stava seduto accanto al fuoco, cogli occhi fissi sulla fiamma, e le labbra contratte sul sigaro spento, il ricordo di quella ridicola gelosia della sua infanzia gli balenò in mente colla strana bizzarria delle reminiscenze. Egli buttò il sigaro, e si alzò più pallido ed accigliato di prima.
Avea fatto tranquillamente i suoi studj in collegio sino a quell’età; era passato per le lingue, per i numeri, per l’analisi della parola e del pensiero; a sedici anni era diventato sognatore, fantastico, ipocondriaco, e sentì d’amare la prima volta perché tutti i poeti parlavano d’amore. Allora, trionfante di mistero, mostrò di nascosto all’amico Gemmati i primi fiori vizzi che la cuginetta gli avea dato, o che egli le avea rubati: «Ami l’Adele?» gli domandò Gemmati ch’era anch’esso un po’ parente della ragazza. «Sì!» rispose Alberto facendosi rosso. «O come? se non la vedi quasi mai?...