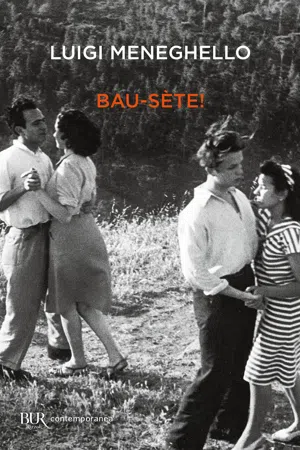Non vidi niente, mi ero scordato gli effetti della guerra, non c’erano i cartelli, Qui finisce la strada, Attenti all’Astico, Pendenza del 100%. Niente: un fascio luminoso mi sbatté in faccia da sotto in su, era il fanale, la DKW si era inalberata, e venne a darmi una specie di testonata che percepii in forma di luce, e mi addormentai nel più repentino dei modi.
Rinvenni con una chicchera in mano, in una cucina di contadini (era una casa isolata con annessa osteria, vicino al punto dove c’era, anzi mancava il ponte), in un cerchio di gente premurosa. Mi avevano dato una chicchera di grappa per farmi rinvenire. Il contadino combatteva i sintomi, spesso con vistosi risultati.
Tenevo banco, tutti ridevano. Non mi ricordavo più della moto, Lelio mi pareva naturale che fosse lì e avesse male a una gamba, c’era anche un dottore che diceva che bisognava portarmi all’ospedale, credeva in buona fede che avessi la commozione cerebrale della quale l’allegria smodata è tra i segnali più tipici; ma la mia era invece principalmente allegria da grappa, quella dei contadini e l’altra: avevo bevuto grappa tutto il giorno con Lelio, per non prendere freddo e combattere l’umido della pioggia continua. Ora ridevo e scherzavo, contentissimo di essere lì, tra queste simpatiche persone, salutavo allegramente i miei parenti al telefono (c’era il Posto Pubblico nell’osteria), i quali dopo un po’ c’erano anche loro, venuti prontamente con la Sette per partecipare alla festa, e dopo un altro po’ eravamo all’ospedale a Thiene, uno spasso, ne dicevo di cotte e di crude, avevo il muso un po’ raschiato ma stavo benissimo, mi avevano disteso su un lettino e a un certo punto mi alzai e mi avviai verso l’uscita per andare a casa con la Sette, gli altri mi seguivano in crocchio come un miracolato, però io cominciai a pendere e in modo dolce e improvviso cascai addosso a un’infermiera, e molte mani e braccia mi pigliarono a volo. Ma guarda che da ridere, sono cascato addosso a un’infermiera.
Avevamo girato tutto il giorno per l’Altipiano, io e Lelio con la DKW, sotto la pioggia. A notte fatta, scendendo per la Valsugana, la pioggia si era infittita: alla luce del nostro faro faceva come un bosco di sbarre d’oro animate, saettanti, fragili, contro le quali irrompeva l’arguto cappuccio nero del faro e la sagoma corta e netta del parafango. Era come un ballo, un volo, ma c’era anche un aspetto ipnotico, forse a causa del rumore. Dallo strepito di fondo della pioggia si staccava il ronzio penetrante della DKW che per un effetto di accumulazione acustica nella mia testa (era un giorno intero che lo sentivo) si era intensificato e pareva non più fuori ma dentro la testa, ossessivo e insieme quasi riposante… Eravamo già oltre Marostica, filavamo come in trance verso il ponte sull’Astico.
Il ponte mancava, distrutto alla fine della guerra, e là dove la strada bruscamente interrotta si affacciava al greto dell’Astico su un salto di parecchi metri, c’era un modesto mucchio di ghiaia a fungere da riparo. Nel buio e nella pioggia non c’era alcun pericolo che questo mucchio si potesse vedere; bisognava sapere che c’era, in luogo del ponte.
Io e Lelio eravamo andati in Altipiano non si sa se per ritrovare le cose di lassù, o per separarci da loro, lasciarle per sempre. Ci eravamo spostati da un luogo all’altro, seguendo un filo istintivamente. Era come un ricercare musicale, ma su quali motivi? Il segreto del paesaggio di rocce e boschi che dai Castelloni di San Marco declina alla dolce piana di Marcésina? l’amara gioventù della Rosina a Frizzón? o a Camporóvere, seduto su uno sgabello nel vano di una porta, macilento, soft-spoken, micidiale, il Broca in persona?
Sul piano della cronaca, il dopoguerra per me è punteggiato di scontri, cadute, slittate, discese nei fossi, perdite di amici e parenti. Col casolino Luigi fu sulla curva a elle con cui lo stradone di San Tornio si immetteva all’improvviso in paese. Venivamo in su forse marginalmente troppo forte, io presi male la curva: entrammo quasi subito nel fosso che c’era allora sulla destra della strada, fondo e pieno di ortiche; in acrobazia, io riemersi ancora al mio posto sulla moto pochi metri più in là, ma il casolino Luigi non era più con me, era nel profondo delle ortiche. Ce n’è stati tanti altri. Ulderico Teodoro (fu con la Matchless) lo deposi in mezzo alla strada a Vicenza, sul viale di Porta Santa Croce, davanti alla Montecatini. È un rettilineo, non c’era alcuna necessità di cadere: fu una di quelle slittate del tutto gratuite che faceva la Matchless. Aveva piovuto, c’era fango sull’asfalto, una moto normale avrebbe potuto tutt’al più sbandare un po’ ma lei all’improvviso si gettò per terra, io stetti con lei e dopo un po’ ci fermammo, mentre Ulderico Teodoro si trovò posato sul fango con le gambe in aria, come uno che sta in un cesto, e continuò per conto suo, sfrecciando in mezzo al traffico.
Ma sono altri, più indefiniti e più curiosi, i caratteri di quella stagione che contano per me: per esempio il senso di interruzioni improvvise, di andare ogni tanto a sbattere addosso a qualcosa, di venire fermati; o il senso (tutto diverso) di vagabondare, di percorrere spazio, diretti in qualche parte che forse non c’è…
Con quali amoti o quali altri mezzi automobili abbiamo attraversato la pianura, intendendo salire su quali montagne a fare che cosa?
Non credo un comizio, quegli angosciosi comizi dove era così facile dire cose che piacessero alla povera gente (è strano, la gente allora era povera), ma che erano false e dicendole svegliavano in te un controcanto agro… punture come di aghi o spine… E neanche, direi, a scegliere posti per costruirci un giorno fabbriche o succursali di fabbriche di incerta natura. Se c’era (e c’era) Renzo, col suo istinto per il pragmatico, non poteva essere un viaggio del tutto senza meta, ma non so più dove fossimo diretti, né di preciso con che veicoli, certo esclamando ogni tanto “tusi!” come per proporre o riassumere o vedere un po’ (le posture di allora) e sempre con l’orecchio ai possibili incappi dei motori: attraversando i paesi restati quanto antichi e nudi, con la gente seduta sugli scalini, qualche carro di fieno nelle strade, un uomo che spazzava la corte, una ragazza sbilanciata dal secchio dell’acqua tornando dalla fontana, donne al focolare nelle cucine. Come sembrava infondata, inetta, la pretesa di salvare l’Italia, che in parte non era salvabile, non da una banda di mezzi pitocchi, e in parte si sarebbe arrangiata da sé…
Dobbiamo averla attraversata come in volo, la pianura antica, che pareva così vasta negli anni in cui la percorrevano a piedi le nostre zie andando a radicchi dalla prima mattina al primo scuro, la pianura-base, il supporto del mondo, improvvisamente non molto più grande di un fazzoletto di media grandezza: e siamo arrivati ai piedi dei monti, oltre Piovene, a un’osteria.
Il fianco alto e umido della montagna incombeva sull’osteria: era quasi sera, e i lampi guizzavano. Dentro, attorno a una tavola da osteria chiacchieravamo con le voci roche, ogni tanto qualcuno accennava a cantare qualcosa, goffamente: e la sbàttola arguta delle donne, il silenzio degli uomini più vecchi legavano forte coi nostri impulsi eccitati. Io sedevo col fianco alla tavola; alla mia sinistra c’era Renzo, premuroso, reticente, gentile con me come sempre, Renzo di cui dicevano «È un killer». Anch’io mi comportavo con gentilezza, e dicevo cortesie all’ostessa (lontana in fondo alla tavola coi figli minori attorno) e alla figlia davanti a me, qui dove faccio una crocetta. Non era specialmente bella, questa figlia, o molto procace, non le splendevano gli occhi o i capelli, era una ragazza qualunque, un po’ serva un po’ padroncina, modestamente disinvolta, nei panni ordinari di una giovane paesana…
Tutta la valle tuonava, era in arrivo la pioggia e le acque senza colore dell’Astico, le acque di vetro, ora imbevute dei riflessi del buio, inarcavano le piccole schiene col suono strisciato che di giorno non tracima dagli argini, galleggia appena sopra i sassi, ma di notte rimonta nella valle nera e riempie l’invaso.
Fui colpito con violenza nella zona della bocca dello stomaco, qualcosa venne a darmi sulla blusa militare inglese, che non sentivo veramente come divisa, ma come forma formante: la blusa-verità; e i raggi dei miei occhi accennavano a incurvarsi, piegandosi verso il punto dove la seggiola folceva il corpo della ragazza… e vidi che Renzo seguiva i raggi dei miei occhi, mi vedeva intuire la ragazza e impallidire, e vidi che sorrideva con simpatia, lui più giovane, quasi materna… e fu così… è stato così che mi sono distratto da ciò che stavamo facendo o cercando, qualunque cosa fosse.
Un’altra impressione ricorrente è la disgiunzione delle cose. Ci sono immagini molto vivide che non si capisce bene cosa c’entrino le une con le altre. Si sovrappongono momenti e luoghi diversi, come se in quei mesi fossimo un po’ dappertutto, simultaneamente; e ogni immagine fa da perno per un ventaglio di altre immagini più antiche e più recenti.
Una volta, a Mestrino, non riuscivo a rimettere in moto la DKW, e andai a chiedere aiuto a una caserma di inglesi che c’era lì vicino. Non era un bisogno assoluto, volevo anche sfoggiare il mio inglese. Lasciai la moto sulla strada, entrai in cortile e spiegai che così da alleati a alleato avevo bisogno di uno strattone. Sbagliai però la parola chiave, e invece di “motor-cycle” dissi che lo strattone mi occorreva per il mio “motor-car”. Gli inglesi mi dissero e poi mi ripeterono più volte che lì in quel momento avevano solo dei grandi mostri corazzati, assurdo mettere in moto uno di quei bestioni per riavviare un motor-car privato. Io però gli ruppi talmente i coglioni, con tanta (e in parte così incomprensibile) eloquenza che a un certo punto un sergente disse a un caporale: «Avanti, dai un fottuto tirone a questo fottuto motor-car». E il caporale andò a prendere uno dei mostri.
Quando vidi le proporzioni del fottuto mostro mi inquietai. Uscimmo dal cortile ruggendo e raspando. Il caporale mi disse: «Dov’è il motor-car?». E io dissi: «Eccolo lì» additando la DKW. Il caporale dovette credere che lo stessi prendendo per il culo. Mi disse scandendo le parole: «Questo non è un fottuto motor-car, questa è una fottuta motor-bike». E io gli dissi: «Eccolo! mi pareva!». Lui mi diede una gigantesca corda di ferro, da trainare i carri armati, con un gancio che attaccai alla forcella davanti: e poi mi impresse uno strattone di due o tre metri che conteneva un vero e proprio shock culturale.
Ciò che seguì fu convulso, sganciato il cavo, noi proiettati sulla nazionale, lei imballata, io come in un rodeo, e il caporale che faceva un fottuto dietro-front col mostro.
Un giorno a mezzogiorno arrivò il pitocco. Era seduta a tavola la famiglia, qualcuno dal sottoportico si affacciò a dire che c’era un amico mio che non voleva entrare, io uscii col tovagliolo in mano e al solo vederlo pensai: per fortuna! Il mio amico andò a sedersi in cortile sullo scalino della lissiara, al sole: i miei gentilmente insistettero per mandargli un piatto di minestra, entrai io stesso a prenderla e la portai fuori e stetti lì a fargli compagnia: mangiava con garbo seduto sullo scalino, non mi diceva nulla, mi sorrideva, sentivo un odore dolce e penetrante, di pidocchi, di sudore… Tenerlo qui; dedicargli il resto della mia vita…
Spostando un momento il conta-fili: anni dopo arrivò un po’ così anche Bill, neozelandese, specialista dei libelli politici inglesi del Seicento, spettinato, discinto, con un enorme zaino… Ora tutto in paese era pace, spasso, Liliana, giostre in Prà… Lo portammo alle Due spade, un alloggio modesto, ma lui non voleva, voleva dormire nel suo sacco, in un angolo del cortile. Inutile dirgli che lì da noi non si usava, una volta avevamo Giacomo Golo, ma era un accattone di mestiere, un professionista… non capirebbero… Bill aveva non mi ricordo se 8000 lire per tutto il viaggio, o forse 80 mila, dalla valle del Tamigi alla Nuova Zelanda… Cercavo di spiegare ai miei: non fanno così per bisogno ma per sport, si chiama trekking… Ripetevo a mio padre: «Te lo assicuro, è un professore della mia università» (in realtà era un semplice lecturer, anzi un assistant lecturer, ma mi era parso meglio promuoverlo). «Un professore?» Mio padre non riusciva a credere che lassù i professori dormissero per terra nei cortili… Mio zio Checco, vedendolo, era ammutolito: a suo tempo viaggiava anche lui un po’ rough, ma con decoro, la bombetta e i calzoni lunghi, questo era in mutande…
Lo avevo affidato un momento alla Liliana, alla sera lo ritrovai alle giostre in Prà, girava nei calci-in-culo con entusiasmo, li alternava con le barche, voleva pagarsi lui i giri, erano quelle le sue vere spese di viaggio. Gli lasciammo pagare solo un giro, la Liliana pareva che si divertisse, le altre ragazze ridevano contente: gli anglosassoni sono eccentrici, “neozelandese” suonava bene, tutti ridevano…
Come torna struggente il pensiero del pitocco! Era in realtà un idiota: ma siccome non diceva quasi nulla e sorrideva, non era necessario prenderne atto. Lo avevo conosciuto a Lavarone, nel Sanatorio dei Partigiani, la nostra Davos. Nel mio entusiasmo di amore universale avevo voluto farmene un amico, trattarlo assolutamente da pari a pari: questo non si può, quando venne al paese a trovarmi improvvisamente percepii il vero, roba da matti, Dostoievski… Certo non era per me, non dava senso, era un sacrilegio…
Il pitocco, finita la minestra, mi guardava come un animale innamorato del padrone.
È curioso, quante cose si mettono a fuoco sul punto del mezzogiorno.
A casa di Franco, a Vicenza, seduto a tavola con la famiglia dialogavo con Franco su questioni di alta politica. Suo padre si intromise, espresse qualche idea che mi parve retriva, io rimbeccai brevemente, e poiché lui voleva continuare il contraddittorio (anziché dirmi: «Ecco che finalmente ci vedo chiaro! grazie, grazie!») gli dissi severamente: «El tasa lu, che nol capisse gnente!». Ero a casa sua, stavo mangiando alla sua tavola, avevo almeno trent’anni di meno: e lui, invece di alzarsi, e tirarmi su dalla sedia, e appiopparmi una pedata nel culo (portava scarpe alte di foggia antica), tacque.
E il bello è che nessuno dei presenti si arrabbiò, non la mamma di Franco (che nei due anni della guerra civile ogni volta che venivo clandestinamente a trovarla mi diceva graziosamente – era graziosa, quasi francese nello stile – : «E soprattutto, mi raccomando, omertà assoluta!»), e non Franco stesso che pure aveva un senso molto vivo dell’onore dovuto al padre e alla madre e che con suo padre in particolare – come mi ha detto molti anni dopo – aveva assunto fin dall’infanzia un atteggiamento di riverenza alieno da ogni critica o sfida. Gli pareva un essere molto grande e sostanzialmente ignoto, di cui lui frequentava la zona attorno alle scarpe e alla parte terminale dei calzoni: il resto era immerso in strati remoti… Non aveva paura, gli pareva soltanto di non contare niente, di essere del tutto trascurabile… “Tutt’al più” (è un intercalare di Franco) si sentiva come un cagnetto che si strofinava con qualche cautela a quelle scarpe, ai risvolti dei calzoni…
E ancora a mezzogiorno, ancora a tavola, in casa del direttore della Montecatini di Vicenza, padre del mio compagno e sodale Marietto e di quattro o cinque altri figli e figlie, un giorno che mi fermai a desinare con loro, feci (così, chiacchierando, in perfetta innocenza) delle critiche, forse solo delle riserve, moderne, rosselliane, su certe scelte tattiche dei suoi operai in sciopero. Fu un disastro. Stavamo a tavola, con l’intera famiglia patriarcale schierata in sequenze ordinate… All’idea che qualcuno criticasse i suoi operai, l’ingegnere si agitò talmente che non riuscì nemmeno a rispondere, gli si strozzò la voce, diventò rosso, poi improvvisamente quasi viola: si alzò da capotavola con la salvietta al collo e fece alcuni passi non si capiva in che direzione… Vidi che barcollava, dovemmo prenderlo, distenderlo su un divano, slacciargli il colletto…
E io che ero amico degli operai! E lo sgomento improvviso di accorgermi che stavo per creare non nuova luce sulla concezione dello sciopero in una democrazia moderna, ma parecchi nuovi orfani!
Nei mesi che seguirono la guerra, sentivo in modo acuto e confuso la necessità di un inventario. Era una percezione discontinua, che si è poi tornata a formare in me ogni volta che ho ripensato a quel tempo. Mi angosciava (nel modo saltuario in cui funzionava allora il principio-angoscia, con irritanti striature di tranquillità) di non saperlo fare, l’inventario. Come quelle paralisi leggere, quando una mano o una gamba “si addormentano”, e pare impossibile non riuscire a prendere una cosa, o fare un passo come al solito: ma non si riesce, si è frustrati, irritati e sorpresi.
Ci voleva un inventario, anche solo per sommi capi, e pareva facile farlo, bastava elencare le cose essenziali nel loro ordine naturale… E invece, niente, l’inventario si inceppava, era un’illusione che fosse già lì pronto a farsi esporre: era come se non avessi niente da inventariare!
Forse la frustrazione di allora (di cui non ero del tutto conscio) spiega la volontà ricorrente di provare a fare il mio inventario in via postuma, e gli innumerevoli schemi, abbozzi e assaggi che ne sono nati. Si trattava di elencare ciò che ero e che avevo in quel momento: definire i parametri principali della mia e nostra “posizione” intellettuale e sociale, ma anche psicologica e biologica. Lo scopo ultimo era di analizzare la realtà profonda della situazione, ammesso che ci fosse; andar giù a cercarla, in apnea se necessario; ma intanto ero disposto a studiare almeno le superfici, vicine e lontane. Ci sono elenchi che cominciano appunto con gli anni di età, e quanti denti avevo (31 da un certo punto in poi), e quanto pesavo, e che stivali portavo (australiani), e fino a che ora mi sarebbe piaciuto dormire al mattino; e all’altro estremo le inquadrature cosmiche, la Galassia, il Gruppo Locale, l’origine dell’idrogeno, e la formazione degli elementi, e i primordi della vita, dell’intelligenza, della società, della storia, giù fino ai nostri tempi, e all’Italia, e al cortile di casa mia.
Non mi è mai andata dritta, non ho mai compilato un inventario serio. Tra l’altro è chiaro che bisognerebbe distinguere tra il principio di questo periodo e la sua fine, come sono entrato nel dopoguerra, e come ne sono uscito; di inventari insomma ce ne vorrebbero due… Potrei tutt’al più prendere qualche articolo individuale, per esempio spiegare come fu che persi il 32° dente, un molare: me lo tolse un dentista di Vicenza, in modo ostile e senza puntura. Ho trovato di recente i dettagli di questa storia in un vecchio resoconto che è intitolato un po’ capricciosamente L’assassinio dell’avvocato Tricarico. Ecco il testo:
«Mi venne male a un dente, era un’esperienza nuova, e pensai di andare da un dentista che si chiamava Fiori, che non conoscevo ma sapevo che era parente di due anziane signore nella cui casa avevo abitato a Padova. Era il tempo in cui si cercava di fare tutto, anche le visite ai dentisti, attraverso le conoscenze e le parentele. Non ero molto conscio del fatto che la carie...