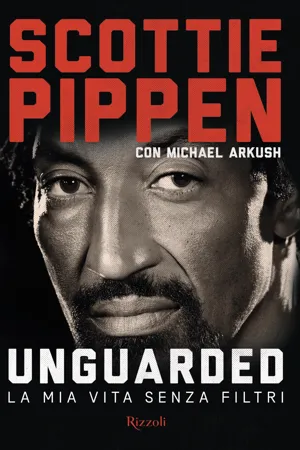Vorrei aver vissuto un’infanzia idilliaca, di quelle così comuni nella provincia americana di fine anni Sessanta e inizio anni Settanta.
Ma non è stato così.
Non ricordo precisamente il giorno in cui il nostro angolo di universo fu sconvolto. So solo che per molto tempo mio fratello Ronnie, allora tredicenne, non era più in giro a giocare con noi. Era all’ospedale per via di un grave infortunio capitatogli durante l’ora di ginnastica. Più che di un infortunio, in realtà, si era trattato di un’aggressione. Avevo tre anni quando accadde, ed ero il più giovane di dodici figli, tra fratelli e sorelle.
Ronnie stava aspettando l’inizio della lezione quando, dal nulla, un bullo gli aveva sferrato un pugno a tradimento sulla schiena. Era caduto a terra e non era più stato in grado di rialzarsi. Non appena era venuta a saperlo, mia sorella Sharon, che aveva due anni in meno di lui, si era precipitata in palestra, ma le autorità avevano già sgomberato l’area e non permettevano a nessuno di avvicinarsi. Era da un po’ che il bullo spintonava Ronnie nei corridoi della scuola. Sharon lo aveva esortato a reagire, ma lui non aveva voluto. Era fatto così. Non ho mai conosciuto nessuno con un animo più gentile del suo.
Un giorno, dopo mesi di ospedale, finalmente tornò a casa.
Ricordo che mi sentii come se lo stessi incontrando per la prima volta. Era paralizzato dal collo in giù e non avrebbe più camminato. Solo molti anni dopo venni a sapere l’intera storia di come mia madre, Ethel Pippen, lo aveva fatto uscire dall’ospedale.
Si trovava a poche ore da Hamburg. I miei genitori andavano a trovare Ronnie ogni fine settimana. Mia madre aveva il suo bel daffare a crescere tutti noi, mentre mio padre, Preston Pippen, un veterano della Seconda guerra mondiale, tagliava tronchi alla cartiera Georgia-Pacific di Crossett, a una trentina di chilometri da casa, dove producevano carta igienica, fazzoletti e asciugamani di carta. Tutti conoscevano qualcuno che lavorava alla cartiera, un posto che emanava un odore ben preciso che si sentiva da qualsiasi punto di Hamburg. È impossibile descriverlo ma, credetemi, era fetido.
Comunque, una domenica, quando arrivarono all’ospedale, a mamma e papà venne detto che non potevano vedere Ronnie. I medici lo avevano inserito in un nuovo programma di riabilitazione ed erano preoccupati perché pensavano che, se i miei genitori avessero continuato a coccolarlo, Ronnie non avrebbe fatto progressi.
La schiena di vostro figlio è a posto, dissero i medici. Il problema è nella sua testa. È per questo che non cammina più.
I medici lo avevano spostato dal suo letto nella sezione principale dell’ospedale al reparto psichiatrico. Conoscendo la mamma, che era più dura di tutti i Bad Boys (i Detroit Pistons) di fine anni Ottanta e primi anni Novanta messi insieme, posso facilmente immaginare l’occhiata che diede ai medici quando le dissero quello che avevano fatto. Era uno sguardo che conoscevo bene. E faceva paura.
«Non me ne andrò di qui finché non avrò visto mio figlio» insistette.
«Se glielo lasciamo vedere, signora» la avvertirono, «dovrà portarlo via con sé. Non lo cureremo più.»
Nessun problema. La mamma era più che felice di portare Ronnie dove doveva stare. A casa sua.
«Faccia come vuole» acconsentirono alla fine. «Non ci interessa. Morirà comunque.»
«Se morirà comunque» disse lei, «morirà accanto a me.»
Mia madre non parlava quasi mai di quel giorno all’ospedale. E quando lo faceva, crollava. Mi chiedo se una parte di lei temeva che i medici avessero ragione.
Dopo qualche tempo che Ronnie era tornato a casa, cominciammo ad avere un quadro più chiaro di quello che gli avevano fatto all’ospedale. Non c’era da stupirsi che avesse gli incubi ogni notte.
Non erano dovuti all’incidente, ma al modo in cui era stato trattato.
Ogni volta che lo mettevamo a dormire, sapevamo che gli incubi sarebbero tornati. Solo che non sapevamo quando. Ronnie si svegliava in piena notte, tutto sudato, e cominciava a urlare. Mia mamma, i miei fratelli e le mie sorelle facevano di tutto per tranquillizzarlo.
«Non dovrai mai più tornare là dentro» lo rassicuravano.
Dopo che mio fratello si calmava, almeno momentaneamente, la mamma si occupava di noi. Anche se alcuni miei fratelli erano già usciti di casa, c’era sempre molto da fare.
«Tornate a dormire» ci diceva. «Domani mattina dovrete alzarvi presto.»
Nessuno però si svegliava presto quanto lei. Molte mattine, quando avevo cinque o sei anni, andava a fare le pulizie in casa d’altri. Ogni centesimo in più era prezioso.
Vorrei solo che allora avessimo avuto i soldi per perseguire le persone che avevano causato tanto dolore al mio povero fratello.
Le infermiere dell’ospedale gli lasciavano un vassoio di cibo accanto al letto, dicendogli che poteva mangiare quando voleva. Ma Ronnie non riusciva a nutrirsi da solo. Non poteva muoversi. Stava semplicemente sdraiato lì, impotente, affamato.
Ronnie aveva paura del buio. Quando andava a letto, dovevamo tenere la luce della stanza accesa e ci azzardavamo a spegnerla solo quando eravamo sicuri che si fosse addormentato. Dopo circa un mese, cominciò a sentirsi più a suo agio e a chiudere gli occhi con solo un piccolo abat-jour acceso accanto al letto. La schiena era piena di piaghe da decubito. Stava a noi medicargliele e pulire il letto ogni volta che si sporcava.
Giorno dopo giorno, con molta fatica e molto amore, ci prendevamo cura di lui, tutti insieme, per rimetterlo in salute.
Gli facevamo il bagno. Gli davamo da mangiare. Lo aiutavamo a fare i suoi esercizi. Ci vollero anni, ma alla fine portammo Ronnie al punto in cui riusciva a muoversi utilizzando due bastoni, il che gli valse il soprannome di Walking Cane, “bastone da passeggio”. Imparò anche ad andare al supermercato su una bicicletta adattata.
Ora che ha più di sessant’anni, vive ancora a Hamburg, nello stesso lotto di terra dove è cresciuto. Mia sorella Kim si prende cura di lui. Io vado a trovarlo ogni volta che posso. Ronnie mi ha ispirato come nessun altro. Aveva tutto il diritto di arrendersi, di maledire il destino che gli era toccato in sorte. Ma non l’ha mai fatto. Ha lottato duramente per costruirsi una vita produttiva e felice. La più grande storia di successo della famiglia Pippen non sono io. È lui.
Ha continuato a credere in se stesso, indipendentemente da quali e quanti ostacoli si è trovato davanti. Ha passato molte serate alla sua preziosa radio CB, parlando per ore e ore con i camionisti di tutta l’America. È tuttora il suo ponte verso il mondo.
Probabilmente, dovrei odiare il bullo che ha causato così tanti danni a lui e alla nostra famiglia. Ma non ci riesco. Era un bambino anche lui, e i bambini fanno cose orribili gli uni agli altri. Allo stesso tempo, non capisco perché lui o qualcuno della sua famiglia non abbia mai chiesto scusa a mio fratello o ai miei genitori. L’anno scorso il bullo, che bazzica ancora da quelle parti, si è fatto vivo e ha chiesto di vedere Ronnie.
Mio fratello non era interessato. Come biasimarlo? Troppo tardi, ormai, per scusarsi.
Non gli ho mai chiesto di quel giorno in palestra o di quello che gli hanno fatto all’ospedale. Non vedo il motivo di rivangare quei momenti dolorosi. Per lui e per noi.
***
Circa dieci anni dopo che Ronnie era stato aggredito, la mia famiglia subì un altro shock. Quel giorno me lo ricordo. Fin troppo bene.
Papà era seduto sul divano e si stava godendo la cena. Niente gli piaceva di più che guardare una partita di baseball in televisione. Da giovane era stato un gran giocatore. A quel tempo, aveva circa sessant’anni ed era in invalidità a causa dell’artrite. L’artrite lo affliggeva a tal punto che quando veniva a vedermi giocare a baseball nella Little League restava seduto nel suo camion parcheggiato fuori, invece di assistere alla partita dalle gradinate.
Quella sera, la mamma aveva le prove di un revival in chiesa, in fondo all’isolato. La sua fede era tutto per lei.
All’improvviso, papà lasciò cadere il piatto e cominciò a scivolare lentamente giù dal divano. Vomitava strabuzzando gli occhi, con il cibo che gli usciva dalle narici. Non sapevo cosa fare. Kim, che gli aveva appena portato la cena, corse da un vicino per chiedergli di andare in chiesa a cercare la mamma, che arrivò a casa prima dell’ambulanza.
Papà stava avendo un ictus nella parte destra del corpo. Non so perché, ma davo per scontato che si sarebbe ripreso. Ero troppo giovane per capire come un ictus può ridurre una persona. Dopo quella notte, non sarebbe più stato in grado di camminare né di parlare. Poteva dire sì o no, ma non riusciva a formulare una frase completa, tranne, stranamente: “Sai cosa intendo”. Non abbiamo mai capito perché proprio quella frase e nessun’altra. Era pienamente consapevole di quello che gli era successo, e questa deve essere stata la parte più dolorosa. Non riesco a immaginare la disperazione e la frustrazione che deve aver provato, giorno dopo giorno, sentendosi prigioniero nel suo corpo, senza alcuna speranza di poter evadere.
Ancora una volta, ci demmo tutti quanti da fare per essere d’aiuto, in tutti i modi possibili. Questa è una delle innumerevoli benedizioni di appartenere a una grande famiglia in cui ci si vuole bene.
Lo imboccavamo, lo portavamo sotto la doccia e, siccome non poteva controllare le sue funzioni corporali, lo pulivamo quando si sporcava. Uno dei miei fratelli lo sollevava mentre io facevo scivolare un pannolino sotto di lui, o viceversa. Anni dopo, mi sono chiesto se i problemi alla schiena di cui ho sofferto nella mia prima stagione a Chicago fossero dovuti al sollevamento pesi o al fatto di dover prendere in braccio il papà e Ronnie. Erano tutti e due pesanti.
La mamma, come al solito, sapeva come gestire la situazione. Si assicurava che suo marito non si sentisse mai escluso. A tavola, mangiavamo tutti insieme, lui seduto sulla sua sedia a rotelle. Lentamente fece progressi e dopo un po’ non ebbe più bisogno di essere imboccato. A volte, quasi mi dimenticavo della sua disabilità.
La mamma dimostrò una forza notevole, che in buona parte le veniva dalla fede. Non l’ho mai sentita lamentarsi.
A cosa sarebbe servito?
Sua madre, Emma Harris, era ancora più tosta di lei. Si diceva che fosse in grado di lavorare duro quanto un uomo. Non faccio fatica a crederci. Anche lei non si autocommiserava. Forse perché era cresciuta in un’epoca in cui i neri del Sud non si lamentavano del loro destino. Semplicemente, accettavano ciò che il buon Dio gli dava in sorte e facevano tutto il possibile per migliorare la loro condizione, giorno dopo giorno.
La mamma era cresciuta in Louisiana, raccogliendo il cotone con sua madre fin da piccola. Alla fine del raccolto, il proprietario della fattoria ricompensava i lavoratori con un bonus. Un anno la gratifica non arrivò e la famiglia se la cavò a malapena mangiando il cibo che loro stessi coltivavano nell’orto.
Nel 1940, quando mia mamma aveva sedici anni, un uragano causò un’inondazione in gran parte del Sudest e la famiglia si trasferì in Arkansas. Quand’ero bambino, ogni tanto andavamo a trovare i parenti che erano rimasti in Louisiana. Ero sempre stupito dal fatto che tre famiglie vivessero in una piantagione. Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, i neri avevano fatto molta strada, grazie all’abolizione della segregazione razziale, al Civil Rights Act e al Voting Rights Act, ma ne rimaneva ancora parecchia da fare.
Ero all’ultimo anno delle scuole medie quando papà ebbe l’ictus. Da quel momento in poi, non poté più essere il padre di cui avevo bisogno, e nemmeno mostrarmi ciò che serviva per essere un uomo; in particolare un nero in un mondo di bianchi.
Con l’aiuto dei miei fratelli maggiori trovai la mia strada, anche se il vuoto che sentivo sarebbe rimasto, nonostante in seguito io abbia cercato di colmarlo con l’aiuto di persone che stimavo, nere o bianche. Tra questi, c’erano i miei allenatori di basket delle superiori e dell’università. Non li vedevo per forza come figure paterne. Tuttavia da ognuno di loro ho acquisito alcuni valori fondamentali che mi hanno poi guidato per il resto della vita.
Un’altra cosa che mi mancava era la libertà di cui godevano i ragazzini della mia età.
In genere, quando tornavano da scuola, gli altri uscivano a giocare, a esplorare, a essere… ragazzini. Non avevano nessun impegno e potevano pensare solo a divertirsi. Per me era diverso. Quando tornavo a casa mi mettevo al lavoro, pronto a sbrigare qualsiasi incombenza mia mamma o i miei fratelli o le mie sorelle avessero in serbo per me. Persino i compiti a casa passavano spesso in secondo piano.
Non c’è dubbio che fossimo poveri. Quando sono nato, nel settembre del 1965, la nostra casa aveva solo quattro camere da letto e per molti anni condividemmo un unico bagno. Capitava che lo usassimo in tre contemporaneamente: uno al lavandino, un altro nella vasca, un altro ancora seduto sul water. Nessuno si faceva problemi. Per molto tempo non abbiamo avuto un telefono. La gente telefonava alla nonna, che viveva lì accanto, e lei veniva a chiamarci.
Nonostante tutto, non mi sentivo povero. Mi sentivo fortunato.
Di cibo in tavola ce n’era sempre parecchio. Coltivavamo zucche, mais e altre verdure nell’orto e allevavamo maiali e polli. Non mancava nemmeno l’amore. Molti ragazzi neri non hanno mai avuto un padre nella loro vita, o una madre devota ai suoi figli come lo era Ethel Pippen.
Diversamente da molti ragazzi che c...