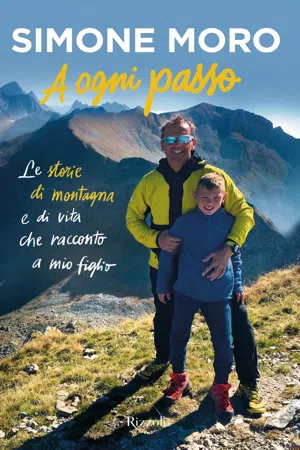La Foresta non era una vera foresta.
Era al massimo un boschetto, non più grande di due campi da calcio. Non si trovava lontano dallo stadio di Bergamo e, in fin dei conti, nemmeno dal centro. Quando ci entravi, però, i rumori della città scomparivano. Non esistevano le voci dei passanti, il motore delle automobili, le grida dei bambini. C’erano solo il fruscio delle foglie e il canto degli uccellini tra i rami.
Forse è per questo che io l’ho sempre chiamata “Foresta”.
«Vado a giocare nella Foresta» dicevo ai miei genitori.
«Ci vediamo nella Foresta» dicevo ai miei amici.
O magari la chiamavo così perché sentivo già il richiamo dell’Avventura. Anche se ero solo un ragazzo di città.
Era irresistibile.
Per raggiungere la Foresta, bisognava risalire un fiumiciattolo. Una specie di canale che tutti chiamavano e conoscevano con il nome di “Riolo”, cioè “piccolo rio”. Dal momento che non c’erano strade o sentieri che lo costeggiavano, chiunque volesse seguirlo era obbligato ad affondarci dentro. Letteralmente.
Non potevo farlo con le scarpe con cui andavo a scuola: se mi avessero visto tornare a casa con le suole infangate, i miei genitori avrebbero capito dov’ero andato. Non dico che loro non le immaginassero, le mie esplorazioni. Certo che le immaginavano. Dico solo che era meglio se la mia passione restava il più possibile segreta. E poi non è piacevole entrare nell’acqua con le scarpe leggere.
Ecco perché, in quel momento, mi trovavo di fronte alla grande cassa degli attrezzi di mio padre.
Quando la aprii, sentii un odore pungente. Buonissimo: era terra bagnata. Ci volle qualche secondo prima che i miei occhi riuscissero a mettere a fuoco il contenuto: vanghe, pale, annaffiatoi, sacchi, zappe…
Papà costudiva lì dentro tutto ciò che serviva per curare l’orto. Anche se era un impiegato di banca, ogni giorno, dopo essere tornato dal lavoro, si sfilava la camicia e si metteva a curare l’orto e la terra o a innaffiare le piante, a rimuovere le erbacce. Un’abitudine che aveva conservato dall’origine contadina e povera della sua famiglia.
Trovai quello che stavo cercando sul lato destro e più nascosto della cassa: gli stivali.
Li afferrai (la plastica impermeabile era spessa) e me li infilai: i piedi ci scivolarono dentro senza sforzo. E vorrei ben vedere: papà portava il 43, io (a malapena) il 36! Mi arrivavano praticamente oltre al ginocchio.
Poi li sfilai, li ripiegai e li misi dentro allo zaino. Quello che mia madre aveva realizzato e cucito utilizzando i brandelli di un vecchio paio di jeans, esattamente come aveva fatto per dotarmi della mia cartella di scuola. Avrei tirato fuori gli stivali, che ci stavano a malapena, una volta lontano da casa dove nessuno poteva scoprirmi.
Prima, però, mancava un’ultima cosa: il cordino di plastica dello stendibiancheria. Lo arrotolai e ficcai anche quello nello zaino.
Ero pronto. Scavalcai il cancello e… giù di corsa verso il Riolo!
Il mio amico Luca mi stava aspettando. Anche lui indossava gli stivali, e anche i suoi erano troppo grandi. Dopo esserci salutati, sparimmo dietro l’angolo della via, corremmo verso il bordo del boschetto, ci entrammo e superando la sponda del Riolo ci immergemmo in quello che in fondo era un piccolo ruscello che per noi rappresentava il nostro grande corso d’acqua d’Avventura.
Un passo dopo l’altro iniziammo a percorrere il rio. L’acqua non era alta, non ci arrivava nemmeno al ginocchio e gli stivali bastavano per non bagnarci i pantaloni. A poco a poco, il Riolo si trasformò, ai miei occhi, in un fiume gigante. Un fiume dove avanzavamo alla ricerca di…
«Indossiamo gli stivali delle Sette Leghe!» dissi a quel punto.
Luca mi guardò con un’espressione strana.
«Non li conosci?» chiesi, stupito.
Lui fece no con la testa.
«Non hai mai letto Pollicino?»
Di nuovo no con la testa.
«C’era una volta…» cominciai io, ma il mio amico mi interruppe.
«Non puoi farmi il riassunto? Altrimenti qui facciamo notte.»
«Gli stivali delle Sette Leghe sono degli stivali magici. Basta un passo, e si percorre un sacco di strada.»
«Non mi sembra niente di spettacolare…»
«Se ti avessi raccontato tutta la storia, sarebbe stata molto più divertente» risposi, dandogli una pacca sulla spalla. «Quello che voglio dire è che, con questi stivali, possiamo arrivare dovunque vogliamo…»
«Ora zitto!» mi bloccò Luca. Poi indicò qualcosa.
Guardai in quella direzione. Stavamo raggiungendo il sentiero sterrato che conduceva alla Cascina Bassanelli, l’ultima casa prima del lato meridionale della Foresta. In effetti, l’odore del letame cominciava a raggiungerci: c’erano una stalla, l’aia, le bestie. Il motivo per cui dovevamo restare in silenzio era questo: i Bassanelli odiavano gli intrusi. E io ero piuttosto sicuro che odiassero ancora di più i ragazzini.
Come l’orco cattivo di Pollicino.
In effetti qualche marachella l’avevamo combinata in passato.
Trattenemmo entrambi il respiro e rallentammo il passo. Cercavamo di non far rumore, mentre avanzavamo nell’acqua. Non che fosse davvero possibile, ma ci provavamo lo stesso. Un passo, un altro.
«C’è qualcosa laggiù» bisbigliò Luca. Aveva gli occhi spalancati.
Era vero: le foglie di un cespuglio, poco lontano dalla sponda, ondeggiavano con insistenza. Troppa insistenza, dal momento che non c’era vento. Incuriosito, uscii dal Riolo e mi avvicinai.
«Ma che fai?» chiese Luca. «Magari è pericoloso e ci vede!»
«Lo sai che non ci può succedere niente di male nella Foresta» risposi.
Raggiunsi il cespuglio e, senza prestarci troppa attenzione, gli tirai un calcio. All’istante, sbucò fuori dalle foglie una palla bianca. Che si mise a correre in tondo agitandosi tutta.
Era una gallina.
Il mio amico tirò un sospiro di sollievo ma al tempo stesso era allarmato per il rumoroso chiocciare. «Dev’essere una di quelle dei Bassanelli.»
Io annuii e seguii per un po’ la gallina con lo sguardo. Sfrecciava via, terrorizzata da questi due ragazzini che avevano invaso il suo territorio.
Poi notai qualcosa di molto più interessante.
Mi precipitai di nuovo nel Riolo e cominciai a correre (per quanto si possa correre con degli stivali di sette taglie in più e con l’acqua che arriva al ginocchio). Luca, dietro di me, cercava di tenere il mio passo.
Dopo un po’ lo sentii sbattere forte contro la mia schiena. Ma non era colpa sua: mi ero fermato di colpo e lui non aveva avuto il tempo di frenare.
«Che ti è preso?» disse Luca, massaggiandosi la testa.
«Luca, ti presento l’albero perfetto!»
Non sapevo ancora riconoscere i diversi tipi di alberi. Però sapevo che aveva tutto ciò che ci serviva. Non era né troppo alto né troppo basso e, soprattutto, cresceva proprio in mezzo al Riolo. Le sue radici affondavano nell’acqua bassa e raggiungevano entrambe le sponde.
Senza perdere tempo, mi sfilai lo zaino e tirai fuori il cordino dello stendibiancheria. Mi arrampicai sul tronco e ne legai un’estremità attorno a un ramo sporgente. Sembrava abbastanza solido. Poi tornai giù stringendo in mano l’altro capo del filo. Infine uscii dal canale e mi misi sulla sponda.
Chiusi gli occhi. Il Riolo si era trasformato di nuovo in un fiume gigante. Uno di quelli di Jack London: melmosi, in piena, zeppi di animali pericolosi. Tutt’attorno, la Foresta si estendeva all’infinito, raggiungeva le colline e, ancora più in là, le montagne. Una distesa di alberi che arrivava fino all’Everest.
A quel punto, il filo dello stendibiancheria diventò una liana. Feci qualche passo all’indietro, presi la rincorsa e…
«La storia di Tarzan invece la conosci?» strillai.
Non ascoltai la risposta di Luca: stavo già volteggiando sopra il Riolo. Andavo a prendere la mia Avventura.
Per esplorare la Foresta c’era bisogno dell’attrezzatura adatta. Come succedeva con gli stivali, dovevo recuperare in casa qualunque cosa mi servisse. Prendevo di nascosto gli arnesi di mio padre per riportarli poi indietro prima che si insospettisse.
Se, per esempio, volevamo costruire una casa sull’albero, servivano: la roncola per tagliare i rami, le corde per legarli insieme, i chiodi e il martello per fissarli. (Avere una casa sull’albero era l’unico modo per andare nella Foresta anche quando pioveva o in previsione di un improvviso temporale.)
Quando mi misi in testa di rubare la sega impiegai tre giorni per realizzare il progetto, perché era molto grande e non entrava nello zaino. Il primo giorno la smontai e portai via la lama seghettata. Il secondo giorno portai via l’intelaiatura. Il terzo giorno lo sprecai per capire come rimontarla.
Sarebbe stato più semplice andare dal ferramenta e comprarne una nuova più piccola. Ma non potevo. Ecco perché:
- Non ricevevo la paghetta. Era usanza sconosciuta in famiglia.
- Se avessi chiesto del denaro ai miei genitori, loro mi avrebbero domandato a che cosa mi servisse. E non sapevo se si sarebbero mai convinti a darmelo per le mie esplorazioni della Foresta.
- Il gusto del proibito rendeva tutto più bello (questo era il motivo più importante).
Nella Foresta ci andavo in inverno e in estate. Ci andavo da solo. Con Luca. Ci andavo con Luca e con Marco. A furia di andarci, arrivò il momento in cui cominciò a starmi stretta. Continuava a essere la mia Amazzonia, ma percepivo che non c’era niente di nuovo da scoprire. Conoscevo già tutto.
Così, iniziai a chiedere in giro: «Ma dove nasce il Riolo?».
Mi rispondevano in maniera confusa.
«In collina.»
«Da un altro fiume.»
«Boh.»
Oppure chiedevo: «Ma dove finisce il Riolo?».
E di nuovo mi rispondevano in maniera confusa.
«Nel Po.»
«Nell’Adda.»
«Boh.»
Ma anche se le risposte fossero state esatte o più precise, non me le sarei fatte andare bene lo stesso: l’Avventura si vive sempre in prima persona. Toccava a me scoprire dove iniziava il Riolo.
Così, una mattina, diedi appuntamento a Luca all’albero di Tarzan. Avevamo entrambi i piedi infilati negli stivali e lo zaino sulle spalle. Mi ero anche portato dietro la merenda: il panino con la mortadella della salumeria Santini.
«Pronto?» chiesi.
«Pronto» rispose Luca.
E partimmo, decisi a trovare la sorgente del Riolo. Dopo la Foresta, il canale attraversava alcuni campi in cui il verde era interrotto qua e là da gruppi di case. “Pianura urbanizzata” la chiamavano a scuola.
Via via che avanzavamo, il terreno cominciava a salire e ci ritrovammo, quasi senza rendercene conto, in coll...