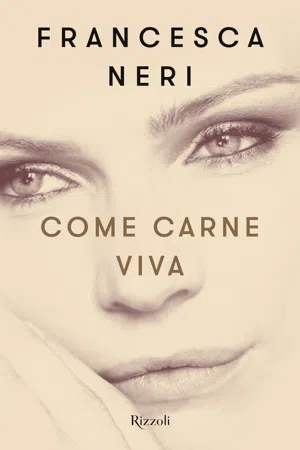Appena ho potuto me ne sono andata di casa. A luglio ho preso la maturità, a settembre ero a Roma. Un’iscrizione all’università era l’unico motivo che, agli occhi della mia famiglia, poteva giustificare un trasferimento, ed è ciò che ho fatto. Dovevo battezzare una facoltà e ho scelto Giurisprudenza. Diventare avvocato non era un sogno né un’ambizione, ma un’ipotesi che ritenevo percorribile. Ciò che realmente mi interessava era mettere quanti più chilometri possibile tra me e Trento. Giurisprudenza c’era anche a Bologna, e molto blasonata, ma Roma era più distante e lì già studiava mio fratello, pareva ragionevole.
Roma nel mio immaginario era la scenografia terrificante in cui mio padre ambientava i resoconti apocalittici delle sue esperienze fuori Trento, un luogo ove confusione, disordine e pressappochismo regnavano incontrastati. Dovete immaginare Heidi che saluta le malghe, scende dai pascoli con i vestiti in un fagottino e precipita nella grande città. Ero del tutto impreparata. Ai rumori, al traffico, alle feste di piazza, alle bandiere giallorosse che sventolavano da ogni finestra. Non avevo mai chiamato un taxi, non avevo mai preso la metropolitana. Mi distinguevo per l’accento trentino e il carattere austero, diffidente. Alla sorpresa ho reagito subito con la chiusura.
Stavo in una stanza con vista stazione. La mattina prestissimo correvo in università per accaparrarmi un posto in una delle sterminate aule a gradoni – frequentavano tutti – e poi stavo lì accampata ore e ore, in attesa dell’inizio delle lezioni. Per il diritto non provavo alcun afflato, mi interessava molto di più scoprire la città, anche se mi intimoriva, frequentare i cinema aperti al mattino (una novità assoluta, per me). Stavo sveglia di notte per guardare i film che passavano a tarda ora. Era una passione, come è per tanti. Come era per mia nonna.
Con la stessa leggerezza, e nessuna consapevolezza, nessuna velleità, mi sono iscritta a una scuola di teatro. Il corso era basato sul metodo Fersen, una evoluzione del metodo Stanislavskij messa a punto da Alessandro Fersen, uno dei più grandi drammaturghi e registi teatrali del secondo Novecento. È tutto basato sull’improvvisazione: non c’è un testo da seguire, l’attore sale sul palco ed è nudo, perché deve parlare, agire, reagire in base a ciò che gli suggerisce la sua personalità. Secondo Fersen, che aveva svolto anche studi di antropologia, l’uomo ha in sé la naturale attitudine alla dissociazione – nel senso teatrale del termine – che la nostra società ha però represso con decisione. Per permettere all’attore di recuperare questa facoltà psicoscenica, Fersen lo sollecitava con due tecniche opposte e contrastanti, definite “dell’abbandono” e “del controllo”. Guarda caso, abbandono e controllo erano esattamente le due forze opposte e contrastanti che si agitavano dentro di me.
La mia prima volta sul palco è stata dirompente, come se una bomba mi fosse esplosa dentro facendo saltare i lucchetti di tutte le celle in cui ero convinta di aver rinchiuso i miei demoni. Era un disastro tutto nascosto, tutto interno: non sono, che so, svenuta, non mi sono accasciata a terra piangente, né mi sono messa a gridare o sono fuggita. Fuori era successa tutt’altra cosa, ugualmente degna di nota: la mia improvvisazione era piaciuta. Gli altri studenti del corso, l’insegnante, si erano emozionati. Tutte quelle mie rovine per la prima volta non erano una cosa solo mia, che iniziava e finiva dentro di me: avevo trovato il modo di farle uscire – le avevo usate – e loro mi avevano permesso di compiere una magia, far provare ad altri la mia stessa emozione.
Più avanti avrei scoperto che ci sono due modi di essere attori: si può sfruttare di più la tecnica oppure l’istinto. Io appartengo alla categoria degli istintivi, quella di chi recita rispecchiandosi nel personaggio al punto da provare le sue emozioni per davvero. Non per finta. Una caratteristica che avrebbe dovuto indurmi a scegliere tutt’altra professione, ma il senno di poi è venuto, appunto, “poi”. Oggi so la sofferenza e la fatica che mi è costato, le volte che ho rischiato di distruggermi solo perché avevo accettato un ruolo che mi assomigliava troppo, o troppo poco. Quella ragazzina di diciannove anni era più che altro inebriata dalla novità, dalla sfida con se stessa – io, che mai avrei immaginato di essere in grado di esprimermi davanti agli altri, che ero così riservata, non solo ci ero riuscita, ma ci ero riuscita bene. Gli altri, e tra loro chi ne sapeva più di me, l’insegnante, gli attori più esperti, mi dicevano: «Brava», «Bravissima», «Splendida», «Grande». Nessuno mi diceva: «Sei matta», sul palco non ero sbagliata. Ero un enfant prodige. Piacere agli altri per qualcosa che sapevo fare era una forma di riconoscimento che mai avrei creduto di ricevere e di cui sono diventata immediatamente dipendente. Il mio bisogno innato di andare d’accordo con tutti, di piacere a tutti: saziato. Ecco un ambito in cui l’approvazione altrui, e la soddisfazione, e il godimento per l’una e l’altra cosa fluivano con naturalezza: per averne ancora mi sarebbe bastato continuare a recitare, senza ulteriori sforzi. Se si eccettuano quelli emotivi, certo. Ma in quel momento era tutto così scintillante: per la prima volta ottenere ciò che spasmodicamente volevo – apprezzamento, gratificazione, accoglienza in una cerchia di persone che parevano simili a me – mi era parso semplice, non mi sono chiesta quale prezzo avrei pagato, se ce ne fosse uno, se stessi prendendo un abbaglio.
Nel 1984 ho partecipato a due provini, uno per l’Accademia di arte drammatica e uno per il Centro Sperimentale di cinematografia. La prima mi ha scartato, il secondo mi ha preso.
Addio Giurisprudenza, addio. Senza alcun rimpianto né l’ombra di mezzo dubbio mi sono trasferita a Cinecittà. Erano gli anni di Saranno famosi e io ci vivevo dentro – solo, non a New York. Frequentare il Centro Sperimentale è stata una delle esperienze più preziose che potessi fare. Il primo anno ho seguito corsi di dizione, ballo, mimo, canto, regia, montaggio, fotografia, sceneggiatura, scenografia, costumi e chiaramente recitazione. Mi ha dato quel che si dice una visione globale. Ma a chiamarmi, a parlarmi era il cinema.
Irrequieta lo ero sempre stata, ma la distanza dalla famiglia, eliminando ogni forma di controllo, mi ha reso frenetica, impaziente. Nei tre anni di Centro Sperimentale ho cambiato una mezza dozzina di case: dalla stanza con vista stazione mi sono trasferita prima in una sorta di collegio suggerito da un’altra fuorisede di Trento, poi ho convissuto con tre ragazze conosciute al corso di teatro, poi sono volata per qualche mese a Chicago, per scappare dall’ennesimo fidanzato sbagliato.
Avevo visto sulla bacheca dell’università che una famiglia americana cercava una au pair, avevo telefonato ed ero partita. Così, d’emblée, senza pensarci. Sono finita in una villa gigante in un quartierino modello Wisteria Lane alle porte della città, nel completo isolamento. Avevo litigato con i miei genitori, non ci parlavamo, non credo di essermi mai più sentita così sola. Per fortuna ho fatto amicizia con un’altra au pair, una ragazza tedesca con cui quanto meno potevo parlare in una lingua che padroneggiavo: per il resto del tempo stavo zitta o balbettavo qualcosa in un inglese stentato. Il mio lavoro consisteva nel badare a tre ragazzine viziate ed egocentriche, che mi erano affidate per la gran parte della giornata e tutte le sere, tranne una – il mio giovedì libero. Un giovedì, appunto, ho acceso il televisore e c’era Roma città aperta. In inglese, ma non importava: ho pianto tutte le mie lacrime, e non sono più riuscita a smettere. Piangevo di giorno e di notte, talmente spesso e con un tale scoramento che i genitori delle tre Erinni si sono preoccupati e hanno tentato di risollevarmi portandomi a una festa al circolo italoamericano. Volevano essere gentili, ma ogni tentativo di deglutire gli spaghetti scotti incollati uno all’altro da una salsa immangiabile mi rendeva più chiaro che mi ero schiantata sul fondo del mio barile, e che scavare era una pessima idea. Meglio osare una risalita. Era ottobre, sono tornata indietro e ho cominciato una vita nuova.
Per combinazione Andrea, mio fratello, stava iniziando l’ultimo anno di studi, aveva deciso di lasciare la sua stanza al Lamaro Pozzani, la residenza universitaria in cui aveva vissuto fino a quel momento, e stava cercando un appartamento per uno. Ne abbiamo cercato uno per due.
Risolta la questione casa, mi sono applicata a un’altra fondamentale ricerca: un analista. Anzi, un’analista, volevo una donna. Basta esplosioni, basta malessere persistente, basta incubi ricorrenti. “Con l’analisi raccoglierò le mie rovine e ricostruirò il mio paesaggio interiore, metterò tutto in ordine e andrà meglio” pensavo.
Un compagno di studi di Andrea aveva una zia psicologa e mi ha indirizzato da lei. Questa signora era molto accogliente, molto competente, ma avevo l’impressione di chiacchierare con una delle anziane zie di mio padre. Non osavo confessarlo all’amico di mio fratello, in compenso ne ho parlato con lui, che mi ha rassicurato: «Diglielo, è lì per questo. Dille che pensi di aver bisogno di un’altra persona». Così gliel’ho detto, e lei si è rivelata carina proprio come mi era sembrata: «Posso indicarti due professionisti, che però non sono psicologi: sono psicanalisti». Mi ha spiegato la differenza, specificando che scegliendo uno psicoanalista avrei dovuto compiere un tragitto, diverso in base all’approccio di riferimento dell’analista stesso. Mi sembrò fantastico, non vedevo l’ora di salpare per il mio tragitto, quindi ho preso nomi e numeri di entrambi i medici, uno più giovane e uno meno. Ho incontrato entrambi, poi ho scelto il più anziano dei due.
Lanfranco Marra è stato una delle colonne portanti della mia vita, la persona in assoluto che mi ha conosciuto di più e la prima da cui mi sia mai sentita davvero capita. Junghiano, messo di fronte alla profondità e vastità dei miei buchi neri, non è scappato ma si è spinto oltre i compiti prescritti dal suo ruolo: è stato per me padre, madre, fratello, amico, compagno di viaggio – di un viaggio meraviglioso durato oltre vent’anni, più di un terzo della mia vita.
I primi tempi ci vedevamo spessissimo, avevo molto bisogno di un porto sicuro, una bussola che mi aiutasse a orientarmi tra i miei pensieri. E poi mi piaceva, mi piaceva tanto, e non solo perché adoro raccontarmi se qualcuno mi ascolta. Era proprio la psicologia a interessarmi, il funzionamento della mente umana. Nel tempo libero ho cominciato a studiarla, ad approfondire le varie correnti. Un paio d’anni più tardi – già lavoravo come attrice – per un periodo ho covato l’idea di cambiare settore, di diventare psicologa, e Marra mi ha incoraggiato, mi consigliava dei saggi da leggere, mi ripeteva che sarei stata “adatta” per quel ruolo. Ma il mio mestiere già mi aveva assorbita, schiavizzata, credevo di non poterne fare a meno, e ho continuato a interrogare i miei demoni nello studio di Marra e a lasciarli uscire sul set, incanalando così la mia energia, a volte sfogandola – più spesso, indagando il mio lato oscuro.
Oggi non mi vergogno a parlarne, al tempo le mie pulsioni più recondite e mostruose mi facevano paura. O meglio, facevano paura alle aspettative degli altri su come avrei dovuto essere, cui avevo dato un tale credito da scambiarle per mie. Nel tentativo di aderire a quell’immagine di me le reprimevo, ma prima o poi loro trovavano il modo di infilarsi tra le maglie della rete troppo stretta con cui le avevo imprigionate e mi si rivoltavano contro. Ero perennemente in lotta con me stessa – la parte che credevo fosse buona contro quella che credevo fosse cattiva – peccato che fossero entrambe mie. Sono uscita dal circolo vizioso confessandomi ciò che credevo inconfessabile seduta sul divano di Marra, oppure quando mi ci trovavo faccia a faccia sul set. Forse è soprattutto per questo che l’ho amato, il mio lavoro, anche se mi sfiniva.
La mia prima volta come comparsa è stata in Amarsi un po’… di Carlo Vanzina. Il protagonista era Claudio, che ventisei anni dopo sarebbe diventato mio marito e che naturalmente manco mi ha notato nel gruppo delle venti o trenta compagne di scuola di Tahnee Welch: con le nostre divise tutte uguali ci fermavamo nel cortile dell’istituto a chiacchierare (e riempire il fondo della scena), mentre lui, in primo piano, andava a prenderla. Cinquantamila lire, ho guadagnato quella volta. Non mi è parso vero: era una cifra pazzesca! Campavo grazie alla borsa di studio e a quello che generosamente mi passavano i miei genitori, ma certo non avevo grandi disponibilità. Per potermi permettere l’analista (un lusso) pranzavo e cenavo alla mensa universitaria e compravo poco altro a parte i biscotti per la colazione. Ho cominciato a consultare compulsivamente la bacheca del Centro Sperimentale, dove miriadi di volantini segnalavano quali produzioni cercavano comparse, generici o controfigure. Ho fatto di tutto: dalla schiava pittata di nero in un film con Richard Gere alla controfigura di Hanna Schygulla in Il futuro è donna, di Marco Ferreri. Negli anni le cinquantamila lire sono diventate prima settantamila, poi addirittura centomila, tantissimo.
Nel frattempo ho cominciato a lavorare per davvero. Fino a quel momento vivevo un’illusione, come se fossi la protagonista del mio personale film: una strana versione di Heidi, sempre vestita di nero, inquieta e malinconica, che si misura con una città più grande di lei, sperimenta, prova, ricerca, scopre – cresce, e nel crescere gli orizzonti si allargano, le possibilità anche, le opportunità pure, e lei si esalta. Mi sentivo prestata al cinema, diciamo così. Non la consideravo una scelta definitiva, “la mia strada”. Studiavo per fare l’attrice, vivevo le prime esperienze da attrice, ma non la consideravo una cosa reale. L’unica cosa vera, dal mio punto di vista, era il sobbollire dei miei sentimenti, come sempre mescolati tra loro, e il fatto che a volte riuscissi a metterci sopra un coperchio, a volte a addomesticarli, a volte mi sommergessero, a volte fossi io a scegliere di lasciarli esondare.
Poi è successo, ho recitato per davvero. Per lavoro, intendo. Enzo Muzii mi ha assoldato per una particina in uno sceneggiato: sarei stata la figlia di Valeria Moriconi in Fuori scena. Non pensavo di essere all’altezza, ed è per questo che ho partecipato al provino e che ho detto «sì» quando mi hanno comunicato che ero stata scelta: per dimostrarmi che lo potevo fare, che potevo andare oltre quello che credevo un mio limite. Ho studiato il personaggio, sono andata sul set, ho recitato, ed è stato difficile, ma anche bello. Bello diventare un’altra che comunque, in parte, ero io. Bello che tutto quel ribollire così estenuante potesse trovare un suo senso sullo schermo, per me e per chi avrebbe guardato. Bello anche impegnarmi, provare, migliorare, riprovare, fare e disfare e rifare e alla fine sentirmi dire: «Sei stata brava». E «Tu farai grandi cose», «Tu diventerai una grande attrice». Non ci credevo fino in fondo – non mi era mai capitato prima di essere considerata diversa in positivo, perché di talento, perché possedevo determinate qualità. Era così inebriante, e ho deciso: se po’ fa’, o quanto meno proviamoci.
La grande occasione è arrivata nel 1989, a venticinque anni. Avevo già traslocato sei o sette volte, convivevo con un fidanzato di poco più grande di me, produttore alle prime armi, ero diplomata al Centro Sperimentale e avevo girato un paio di film: potevo considerarmi un’attrice emergente, ma non per questo ero matura. Dell’adolescente cresciuta non avevo magari l’aspetto, ma l’ingenuità e il candore sì. Ero senza filtri, del tutto impreparata a governare le dinamiche e i movimenti della vita adulta.
A maggio sono andata con un gruppetto di amici e colleghi a Cannes, tra i quali il produttore del mio secondo film, Bankomatt. Una sera mi ha raccontato di aver incontrato un collega spagnolo: «La protagonista del suo film ha dato forfait, mi ha chiesto se avevo qualcuna da segnalargli e ho fatto il tuo nome. Ti va di incontrarlo?». Sono rimasta di stucco: io, in una produzione spagnola? Solo l’ipotesi mi pareva stupefacente. «D’accordo» mi sono affrettata a rispondere.
Il giorno successivo ho incontrato il produttore spagnolo, che ha tratteggiato sommariamente la situazione: avevano acquistato i diritti cinematografici di un libro di Almudena Grandes, che in Spagna stava sbancando; il regista sarebbe stato Bigas Luna, che conoscevo per aver visto una sua opera al Centro Sperimentale. «La protagonista doveva essere Ángela Molina, ma non se la sente più. Se ti va, posso chiedere a Bigas di venire qui a Cannes e domani facciamo un provino. Che ne dici?»
Che potevo dire? Che andava bene. Anzi, benissimo.
Bigas Luna era uno spirito polemico, dissacrante, ossessionato dall’amore, dal sesso, dal desiderio come strumenti di ricerca di sé, di esplorazione del proprio lato oscuro. Io il mio lato oscuro lo esploravo più che altro dall’analista, in maniera intellettuale – non mi sarebbe venuto in mente di usare il corpo. La trama del film ancora nessuno me l’aveva raccontata, nemmeno conoscevo il titolo del libro, ma era ragionevole supporre che i temi fossero questi. Avevo accettato, è vero, un provino con Bigas Luna era palesemente una grande possibilità, ma ciò non significa che non avessi qualche resistenza. E poi c’era un enigma: perché Ángela Molina si era tirata indietro?
Al rientro in albergo ho esposto le mie preoccupazioni al mio compagno: il fidanzato era tentato dallo scoraggiarmi, ma il produttore non ce l’ha fatta e mi ha spinto a prendere la decisione più giusta. «In fondo è solo un provino» mi ha detto. E dunque, il giorno successivo, eccomi in un uno splendido hotel fuori Cannes, in attesa di Bigas Luna.
È stato lui a spiegarmi che avrei dovuto interpretare Lulù, una quindicenne graziosa e inesperta che viene iniziata al sesso da un amico del fratello, di diversi anni più grande di lei. I due successivamente si sposano, hanno una figlia, e coltivano diverse perversioni sessuali. Potremmo considerare il film un racconto di formazione: Lulù, innocente e pura, scopre attraverso il sesso lati di sé che altrimenti mai avrebbe investigato e mette alla prova i propri limiti.
Di fronte a quest’uomo tondo e accogliente, alla storia estrema che intendeva raccontare, sono rimasta senza parole.
«Te la senti di fare un provino?» mi ha domandato. «Vorrei vederti in due scene: una di dialogo e un monologo mentre ti masturbi con un vibratore.»
In casa mia, naturalmente, la sola paro...