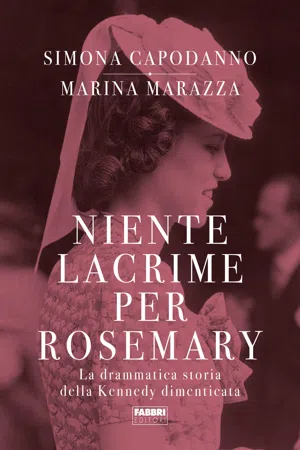La spagnola
Aveva un nome quasi carino e quantomeno ingannevole: spagnola. Pareva più il titolo di una canzone romantica che non una minaccia. E invece.
Tra il 1918 e il 1920 l’umanità fu squassata da una delle pandemie più devastanti della Storia. Un’influenza insolitamente violenta che contagiò non meno di cinquecento milioni di persone in tutto il mondo, provocando la morte di oltre cento milioni, per lo più giovani sani e robusti, sia uomini che donne. Fu questo il fatto più insolito a essere registrato, oggetto di analisi negli anni successivi: se le pandemie tendono a fare vittime tra i più deboli, i vecchi e i bambini, in questo caso il virus sembrò nutrirsi di sé stesso, attaccando i più forti con una aggressività tale da non lasciar scampo.
I focolai iniziali si erano manifestati quando ancora infuriava la Prima guerra mondiale; e furono gli accampamenti militari a diventare l’epicentro di quell’ondata mortale, che non risparmiò nemmeno le aree più remote del globo, con due sole eccezioni. La lontanissima isola di Marajó, alla foce del Rio delle Amazzoni in Brasile, e la sperduta isola di Sant’Elena, ultima prigione di Napoleone Bonaparte, non registrarono alcun malato. Ma per il resto, fu una devastazione che impegnò allo spasimo medici, infermiere, ospedali di tutto il mondo, spesso impotenti di fronte alla forza del morbo.
Passò alla storia con il lezioso nome di influenza spagnola perché i primi a darne notizia furono i giornali spagnoli, non soggetti alla censura di guerra, come invece accadeva per quelli di tutti i Paesi belligeranti. Ma di spagnolo non aveva un bel niente. La pandemia parlava americano. Si era sviluppata, secondo gli esperti, nei campi militari del Kansas, mietendo migliaia di vittime fra i robusti soldati che erano riusciti a non morire nelle malsane trincee d’Europa.
L’onda di morte si spostava con grande rapidità e nella sua folle corsa distruttiva era destinata a entrare presto in collisione con una delle famiglie più in vista, più potenti e famose, non solo degli Stati Uniti ma del mondo intero. Non avrebbe contagiato nessuno dei suoi illustri esponenti, ma avrebbe causato indirettamente qualcosa di ancora più drammatico, un segreto da nascondere tra le pieghe di un’omertà soffocante. Una stirpe ricca di talento, di onori, di denaro e di potere, eppure gravata da una sofferenza senza limiti; una vera e propria maledizione, che attraverserà tutta la sua storia fino ai giorni nostri: la martoriata dinastia dei Kennedy.
Proprio in quegli anni, Rose Fitzgerald Kennedy, moglie del patriarca della famiglia, il potente imprenditore Joseph Kennedy, aveva messo al mondo i suoi primi rampolli, destinati a diventare famosi: Joseph Junior, chiamato come il papà, nato nel 1915, e John, detto Jack, il futuro mitico presidente degli Stati Uniti, nato nel 1917.
Il dottor Frederik L. Good, nomen omen, era l’ostetrico personale di Rose e l’aveva già aiutata con i suoi due primi figli maschi, nati entrambi in casa. Ora che Rose era incinta del terzo erede, niente faceva dubitare che anche questo bambino sarebbe nato senza alcun problema nella villetta dipinta di grigio in fondo alla strada alberata, al numero 83 di Beals Street, a Brookline, nel circondario di Boston, dove i Kennedy erano andati ad abitare dopo il viaggio di nozze, nel 1914.
L’infermiera che era stata assunta per assistere Rose nei suoi ultimi mesi di gravidanza era intenzionata a svolgere il suo lavoro con coscienza. Aveva controllato lo stato di salute di madre e figlio ogni giorno, annotando in un diario il peso crescente della signora, la sua alimentazione, la frequenza cardiaca. Aveva monitorato l’attività intrauterina del feto, la sua posizione corretta nel canale del parto e, alla fine del nono mese, aveva trasformato la stanza di Rose in un’attrezzatissima camera asettica, organizzata meglio di quanto accadesse nella maggior parte degli ospedali dell’epoca. Tutto secondo i dettami più recenti della medicina. All’epoca le donne del popolo partorivano in situazioni spesso disperate, senza poter contare nemmeno sulle più elementari condizioni igienico-sanitarie, senza medicinali di base, difficilissimi da reperire, perché i pochi che si producevano venivano inviati al fronte. Rose, invece, poteva disporre di un’assistenza di prim’ordine: le piaceva avere tutto sotto controllo. Anzi, non poteva farne a meno.
Solo che chiunque abbia un minimo di esperienza sa che è impossibile prevedere tutto: è cosa nota che l’uomo pianifica e Dio ride.
Infatti, quel venerdì 13 settembre 1918, quando Rose Fitzgerald Kennedy avvertì le prime doglie e l’infermiera capì che era il caso di mandare a chiamare il dottor Good, il maligno virus della spagnola decise di mettersi di mezzo. Negli ultimi mesi in molte aree del mondo pareva iniziare la sua fase calante, ma non nella zona di Boston, dove si registrava una spaventosa recrudescenza. Come da copione, il virus colpiva giovani in salute, uomini robusti e donne di sana costituzione, soprattutto se gravide. Ecco perché il dottor Good, in quanto ostetrico e ginecologo, lavorava senza sosta giorno e notte, spostandosi da un quartiere all’altro della città per tentare di arginare le morti e il contagio. Ecco perché da Rose Kennedy, per quanto di sicuro la sua paziente più facoltosa, non poté andare subito. In maniera del tutto imprevista, Rose si trovò per diverse ore senza assistenza medica, seguita soltanto da un’infermiera diplomata, che aveva ricevuto indicazioni fin troppo precise su come comportarsi durante un parto in assenza del medico e che si dimostrò incredibilmente determinata a seguire la procedura fino in fondo, al di là di ogni logica e buon senso.
Sally: La brava infermiera
Sono pochi i mestieri adatti a una donna, ma senz’altro la maestra e l’infermiera rientrano nella categoria. Soprattutto se si tratta di un’infermiera che ha a che fare con i bambini. Ai tempi di mia madre Mary, c’era poco da scegliere, per una immigrata irlandese negli Stati Uniti: andavi a servizio presso una famiglia benestante o facevi l’operaia in un buco malsano, dove sputavi i polmoni per quattro spicci.
A me è andata meglio. La mamma è morta contenta, orgogliosa. La piccola Sally, figlia di Mary la serva, che aveva sgobbato tutta la vita nelle case di gente ricca, ha studiato, ce l’ha messa tutta ed è arrivata a indossare un bel grembiule bianco e una cuffia. È diventata Sally l’infermiera. Anch’io lavoro per i signori, come mia madre, chiaro, ma non è la stessa cosa. Prima di tutto posso scegliere, e i Kennedy – se non altro – hanno sangue irlandese, come noi Moloney. E poi ho una certa autorità, le signore mi stanno a sentire e fanno quello che dico. Non viceversa. Prima viene il medico, certo. Ma quando il dottore non c’è, chi comanda? L’infermiera, ovvio. Io.
Ho pensato che non fosse un compito tanto difficile aiutare la signora Rose a mettere al mondo il suo terzogenito. Non era una di quelle primipare spaventate che non sanno da che parte si comincia e vanno in isteria alla prima contrazione. Ne aveva già avuti due, di figli, sempre nati in casa col dottor Good. All’epoca io non ero ancora arrivata e ad assisterla c’era la mia collega, la vecchia Phoebe, che era andata in pensione l’anno prima. Il primogenito, Joe Junior, aveva tre anni, e il secondo, John, che però tutti chiamavano Jack, aveva diciotto mesi. Il terzo parto di solito è una passeggiata. E poi lei era abbastanza giovane, aveva ventotto anni e godeva di buona salute, anche se non c’era troppa carne sulle ossa nemmeno al nono mese.
A Dio piacendo, in famiglia nessuno aveva preso la spagnola, che stava dando un gran da fare al dottor Good. Cominciava così, quello schifo di malattia, con la tosse, i dolori alla schiena, la febbre. Due settimane prima la signora Rose aveva avuto un po’ di raucedine e tutti ci eravamo allarmati, una gran strizza. Ma le era solo andata via la voce per un colpo d’aria alla gola, niente di grave. Invece per molti non c’era stato scampo: mio zio Fred, che fabbricava bare a Newton, aveva fatto affari d’oro, finché non aveva cominciato a tossire anche lui ed era finito lungo e disteso dentro la deluxe di mogano foderata di raso bordò. La migliore del catalogo.
In quei giorni medici e infermiere erano merce rara, nel senso che eravamo tutti impegnatissimi, negli ospedali e nelle case private, a star dietro al contagio. E comunque, l’idea di partorire a casa era la migliore, già quando non c’erano pandemie in corso: la bella villetta dei Kennedy era più pulita e sterile di qualunque ospedale e finire in una struttura pubblica avrebbe significato molte più probabilità di beccarsi il contagio.
Erano giorni che controllavo mamma e bambino. Il mio mestiere lo so fare bene, io: sono uscita seconda del mio corso, e solo perché prima di me c’era quella stronzetta inglese con la puzza sotto il naso. Priscilla White si chiamava, che era figlia di un medico e sosteneva di discendere dai Padri Pellegrini. Gli esaminatori devono aver avuto un occhio di riguardo, ma pazienza, seconda su quaranta è già un bel piazzamento per la figlia di Mary la serva. Mia madre nemmeno sapeva tenere in mano una penna e mio padre l’unica cosa che leggeva volentieri erano le scritte sull’etichetta della bottiglia di whisky.
Io una cosa l’ho sempre avuta buona: la memoria. Quello che mi insegnavano mi si fissava nel cervello subito. Da piccola vincevo tutte le gare all’oratorio quando si trattava di citare passi delle Scritture, parola per parola. Solo una delle mie maestre, la signorina Michelle, che insegnava francese, mi diceva che non basta ripetere a pappagallo. «Sally, fai funzionare le tue cellule grigie: non devi imparare a memoria, devi ragionare.» Ma non è vero, perché per tutti gli altri insegnanti andava bene così, nessuno chiedeva di ragionare, e anche dopo al corso per le infermiere andava bene così: ti interrogavano sui brani del manuale, e io ero sempre la più preparata.
Quindi, quando mi ero resa conto che stava cominciando il travaglio, ero pronta a fare del mio meglio. Avevo mandato ad avvisare il dottor Good e nel frattempo sapevo benissimo quali erano i miei doveri. Prima di tutto: predisporre un ambiente asettico. Il medico combatte la febbre puerperale grazie alla diligenza dell’infermiera. La stanza dove la signora Rose avrebbe partorito doveva essere pulitissima. In secondo luogo, dovevo badare all’umore della paziente, incoraggiarla, metterla a suo agio, farle sentire che era accudita nel migliore dei modi. E poi provvedere alla sua impeccabile igiene personale: bagno caldo e clistere saponato, rasatura del perineo, pulizia dei glutei e delle cosce con soluzione di bicloruro asettico.
Stava andando tutto bene, perché la signora Rose si lasciava fare, e io mi davo d’attorno a preparare tutto quello che sarebbe servito al medico. Il manuale parlava chiaro: «Un’infermiera deve prevenire i bisogni del dottore».
La signora Rose però stava cominciando a soffrire parecchio, il travaglio stava procedendo più in fretta del previsto. Del resto, si trattava del terzo parto e non vedevo l’ora che il dottor Good arrivasse. Avevo interrogato Frank, il figlio del giardiniere che era corso ad avvisarlo, ma lui non mi aveva dato grande soddisfazione.
«Ha detto che arriva appena può e di aspettarlo» era stato tutto quello che mi aveva saputo dire il ragazzo, persino un po’ stizzito.
Di aspettarlo, quindi. Ed era logico: l’infermiera assiste il medico, ma il manuale parla chiaro, se succede qualcosa alla mamma o al bambino, di chi è la responsabilità? Non deve succedere niente finché non c’è il dottore. È lui che se la deve vedere.
Così ho sorriso alla signora Rose. «Devi tener duro, cara» le ho detto, tamponandole la fronte sudata. In quei momenti potevi anche prenderti delle confidenze, quando stringevi loro la mano, intanto che si contorcevano per il dolore come bisce. «Non spingere, Rose» le ho detto, assaporando quell’istante. La potevo anche chiamare per nome e darle del tu. Ah, mi spiaceva solo che mia madre non fosse lì per vedermi, in quel momento. Era lei a dover fare quello che le dicevo io. «Il bambino non deve ancora uscire. Chiudi le cosce, strette strette, brava, e aspetta. Il dottor Good sarà qui a momenti. Noi non dobbiamo far altro che pazientare.»
Il dottore era stato chiaro: aveva detto di aspettarlo. Si sarebbe preso centoventicinque dollari per la prestazione, del resto. Ma Rose aveva cominciato a gemere forte.
«Non ce la faccio, buon Dio, non credo di farcela…»
«Certo che ce la fai» ho ribattuto. Mi avevano insegnato che è molto importante essere decise. «Ora ti aiuto.»
Ho tenuto la mia mano in posizione per impedire al bambino di uscire per quasi due ore, finché il dottor Good non ha suonato alla porta, e quando è entrato in camera gli ho sorriso.
Poteva essere orgoglioso di me, avevo fatto esattamente quello che dovevo. Avevo tenuto calma Rose facendola pregare ad alta voce, asciugandole il sudore e le lacrime. Non era stato facile respingere la testa dentro l’utero, ma ci ero riuscita. Brava, no?
Invece l’ho visto dare un’occhiata alla scena, a Rose pallidissima, con gli occhi sbarrati e due chiazze rosse all’altezza degli zigomi.
«Da quanto tempo il bambino è nel canale del parto?»
«Un paio d’ore, dottore. Sono riuscita a non farlo uscire. Quando ho mandato Frank ad avvisare lei ha detto di aspettarla e…»
«Togliti di torno» mi ha interrotta lui, chinandosi tra le gambe della partoriente.
Bel ringraziamento.
L’infermiera che assiste Rose finisce per prendere la decisione più sbagliata in assoluto: invece di lasciare che la natura faccia il suo corso, dice alla partoriente di non spingere e trattiene il feto all’interno del canale uterino per oltre due ore. Quando il dottor Good finalmente arriva e fa...