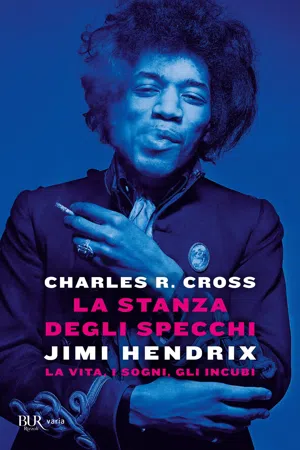Jimi Hendrix nacque il giorno dopo la festa del Ringraziamento del 1942. L’arrivo di questo bel bambino in salute, del peso di due chili e otto, venne salutato da tutti come un’autentica benedizione divina. Nel telegramma con cui la zia informava il padre del lieto evento, spiccava la frase: «Le cose ora vanno meglio». Quell’affermazione avrebbe potuto tranquillamente fare da epigrafe alla vita vissuta fino a quel momento dall’intera famiglia Hendrix e, più in generale, riassumere l’esperienza della comunità afroamericana negli Stati Uniti. Le cose erano andate male per molto tempo, ma forse questa nuova generazione poteva sperare in un miglioramento generale, in un mondo più giusto. Entrambi i rami della famiglia celebrarono la nascita di Jimi come un nuovo inizio. «Era il bambino più bello che si potesse desiderare», ricorda sua zia Delores Hall. «Era delizioso.»
Jimi era nato a Seattle, nello stato di Washington, nel reparto maternità del King County Hospital, successivamente ribattezzato Harborview. L’ospedale godeva di una splendida vista sul grande bacino naturale del Puget Sound. Seattle stava lentamente emergendo come una delle principali città portuali della costa pacifica degli Stati Uniti e nel 1942 contava una popolazione di 375.000 abitanti. Durante gli anni del conflitto mondiale, era una città in forte espansione; i numerosi cantieri navali fabbricavano scafi per la marina e gli stabilimenti della Boeing producevano i bombardieri B-17, quelli che avrebbero permesso alle forze alleate di vincere la guerra. Nel 1942, le fabbriche lavoravano ventiquattro ore su ventiquattro e il grande afflusso di lavoratori provocò un allargamento dei confini cittadini, cambiandone per sempre la connotazione razziale e demografica. Nel censimento del 1900, soltanto quattrocentosei abitanti di Seattle avevano dichiarato di essere di colore, all’incirca l’uno percento della popolazione. Nel corso del decennio 1940-50, alimentata dai fabbisogni lavorativi della macchina bellica e da una vasta immigrazione dal Sud, la componente di afroamericani raggiunse un picco di 15.666 unità, diventando così la principale minoranza razziale della città.
I genitori di Jimi non appartenevano all’ondata di immigrati giunti durante il conflitto, ma la Seconda guerra mondiale avrebbe comunque svolto un ruolo importante nelle loro vite. Al momento della nascita di Jimi, suo padre Al era un soldato ventitreenne dell’esercito degli Stati Uniti, di stanza a Fort Rucker, in Alabama. Al aveva chiesto al suo diretto superiore una licenza di paternità per recarsi a Seattle; la licenza gli venne negata e finì addirittura in prigione. I suoi superiori decisero di incarcerarlo perché erano convinti che sarebbe scappato pur di essere presente al parto. Si trovava nella baracca adibita a guardina quando arrivò il telegramma di congratulazioni della cognata. In seguito si lamentò per il fatto che, in circostanze analoghe, ai soldati bianchi la licenza era stata concessa, ma le sue lamentele passarono inascoltate. Al non avrebbe conosciuto suo figlio fino al compimento del terzo anno di età.
La madre di Jimi, Lucille Jeter Hendrix, aveva soltanto diciassette anni quando lo mise al mondo. Per un malaugurato scherzo del destino, Lucille scoprì di essere incinta proprio nella settimana in cui Al andò sotto le armi. Si sposarono il 31 marzo 1942 presso il municipio della King County nel corso di una cerimonia officiata da un giudice di pace, e vissero insieme da marito e moglie per soli tre giorni prima della partenza di Al. L’ultima delle tre sere, ci fu un party presso il Rocking Chair, il club dove anni dopo sarebbe stato scoperto il talento di Ray Charles. Lucille non aveva ancora l’età legale per bere ma, in quei frenetici tempi di guerra, la cosa importava poco ai gestori dei locali. La coppia brindò a un futuro incerto e al ritorno di Al sano e salvo dal servizio militare.
Le circostanze fecero sì che il primo figlio della giovane coppia di sposi arrivasse proprio mentre Al si trovava a cinquemila chilometri di distanza, e questo creò una ferita che avrebbe turbato per sempre l’unione tra Al e Lucille. Ovviamente una separazione come la loro non era inusuale negli anni turbolenti della Seconda guerra mondiale. L’attacco a Pearl Harbour del dicembre 1941 aveva scatenato un’ondata di follia a Seattle e in altre città della West Coast, dove la paura di un’altra offensiva giapponese faceva da sfondo al dramma della disgregazione di migliaia di famiglie. Il giorno precedente il matrimonio di Al e Lucille, Seattle divenne la prima città degli Stati Uniti in cui gli americani di origine giapponese vennero radunati e mandati in campi di prigionia. Alla fine furono ben 12.892 le persone dello stato di Washington di origini giapponesi a essere imprigionate, e tra queste parecchi erano amici e vicini di casa della coppia.
La relazione fra Al e Lucille non venne però minata soltanto dai disagi della guerra. Al era un uomo attraente, anche se basso di statura, mentre Lucille era una ragazza di straordinaria bellezza che i passanti si giravano a guardare per strada. A parte la reciproca attrazione fisica e la passione per la danza, i due avevano poco altro in comune su cui fondare un matrimonio. Entrambi provenivano da un background familiare di estrema povertà, e Al aveva lasciato Seattle sapendo che sarebbe stato in grado di fare ben poco per mantenere la moglie e il figlio durante la permanenza nell’esercito. La loro era stata una storia d’amore molto breve – un autentico matrimonio lampo, in realtà – senza alcun appoggio da parte di parenti e amici. Essendo in sostanza una ragazza madre, Lucille sarebbe stata costretta ad affrontare grosse difficoltà legate appunto alla giovane età, alla razza, al ceto sociale e alla situazione economica. E proprio quel suo stato di povertà avrebbe alimentato la profonda sfiducia di Al Hendrix nei suoi confronti, spingendolo in seguito a sollevare dubbi sulla sua lealtà, sulla fedeltà coniugale e addirittura sulla paternità di Jimi.
* * *
Riesaminando l’albero genealogico degli Hendrix, è facile notare come i temi della paternità e della consanguineità siano stati cause frequenti e ricorrenti di dissidi. La storia familiare rispecchia quella di molti altri discendenti di schiavi, nel senso che ben poco di queste vicende è stato registrato negli annali della storia scritta dai bianchi. Jimi Hendrix sarebbe diventato uno dei primi musicisti rock di colore apprezzati da un vasto pubblico bianco, ma le sue origini etniche erano un complesso mix multirazziale di nativi americani, schiavi africani e padroni bianchi.
Il nonno materno di Jimi era Preston Jeter, nato a Richmond, in Virginia, il 14 luglio 1875. Sua madre era stata una schiava, e come molti altri ex schiavi di Richmond, aveva conservato il proprio lavoro di domestica anche dopo la fine della Guerra civile. Il padre di Preston era l’ex padrone della madre, anche se non è mai stato accertato se il figlio fosse il frutto di uno stupro o di un atto consenziente – se di consenso si può parlare in una relazione tra padrone e schiava. Da giovane, Preston aveva preso la decisione di lasciare il Sud dopo essere stato testimone di un linciaggio. Si era diretto a nordovest perché aveva sentito dire che lì le condizioni di vita dei neri erano migliori.
Preston aveva venticinque anni quando arrivò a Roslyn, nello stato di Washington, una piccola città mineraria situata centotrenta chilometri a est di Seattle sulle Cascade Mountains. Sfortunatamente, a Roslyn s’imbatté in esplosioni di violenza razziale analoghe a quelle del Sud, provocate dal tentativo da parte di dirigenti dell’industria mineraria di soffocare uno sciopero dei minatori bianchi ricorrendo a manodopera di colore. Lo sceriffo della contea scrisse al governatore una lettera d’avvertimento: «Ci sono risentimenti nei confronti dei negri e... temo che ci sarà presto uno spargimento di sangue». Poco dopo si verificarono numerosi assassinii a sfondo razziale. «L’omicidio è ormai un fatto regolare», osservò un cittadino.
Nel 1908, gli afroamericani erano diventati una componente tollerata, se non proprio accettata, dell’industria di Roslyn. Una foto dell’epoca ritrae Preston in mezzo ad altri minatori di colore davanti all’unico saloon che era consentito loro frequentare, il Color Club gestito da Big Jim E. Shepperson. Ma l’intolleranza razziale restava comunque alta, e quando l’esplosione di una miniera uccise quarantacinque uomini, tra cui parecchi afroamericani, i bianchi non consentirono la sepoltura delle vittime di colore nel cimitero della città. Alla fine in città ci si ritrovò con ben ventiquattro cimiteri diversi, ciascuno destinato a una diversa etnia o confraternita.
Dopo dieci anni trascorsi a Roslyn, Preston andò a lavorare in una miniera di Newcastle, sempre nello stato di Washington. Nel 1915 trovò lavoro a Seattle, come giardiniere. A questo punto, ormai sulla quarantina, pensò di cominciare a cercarsi una moglie. Leggendo il «The Seattle Republican» trovò l’inserzione di una giovane donna in cerca di marito.
* * *
La donna dell’annuncio era Clarice Lawson, la nonna materna di Jimi Hendrix. Clarice era nata a Little Rock, in Arkansas, nel 1894. Come molti afroamericani dell’Arkansas, la lista dei suoi antenati comprendeva sia schiavi neri sia indiani Cherokee. Clarice avrebbe raccontato ai suoi figli che il governo degli Stati Uniti aveva dato la caccia ai suoi antenati Cherokee, i quali erano stati aiutati e nascosti da alcune famiglie di schiavi, e che i due gruppi avevano finito per celebrare alcuni matrimoni misti.
Clarice aveva quattro sorelle maggiori. Le cinque giovani Dawson andavano regolarmente dalla loro casa nell’Arkansas fino al Delta della Louisiana per raccogliere il cotone. Nel corso di uno di questi viaggi, Clarice, che ai tempi aveva appena vent’anni, venne aggredita e stuprata. Non appena scoprì di essere incinta, le sorelle decisero di portarla a ovest e di trovarle rapidamente un marito. Scelsero lo stato di Washington dopo aver sentito dire da alcuni lavoranti delle ferrovie che quella zona offriva grandi opportunità per la gente di colore.
A Seattle fecero pubblicare un annuncio di ricerca di marito, senza menzionare lo stato di gravidanza di Clarice. Preston Jeter rispose all’annuncio e, nonostante fosse di diciannove anni più vecchio, i due cominciarono a frequentarsi. Quando le sorelle di Clarice divennero insistenti riguardo al matrimonio e gli offrirono del denaro in dote, Preston si fece sospettoso e interruppe la relazione. Clarice partorì e il bambino venne dato in adozione. Le sorelle offrirono altro denaro a Preston perché sposasse la povera Clarice. L’uomo acconsentì e i due si sposarono nel 1915. Il matrimonio sarebbe durato trent’anni, fino alla scomparsa di Preston, ma le insolite circostanze del loro incontro avrebbero messo a dura prova la loro relazione.
Sia Preston sia Clarice erano venuti nel nordovest con l’intento di iniziare una nuova vita in un luogo in cui il colore della pelle fosse un problema meno accennato rispetto a quanto accadeva da altre parti. Questo era almeno in parte vero a Seattle, dove non esistevano esempi di segregazione paragonabili alle fontanelle per soli bianchi del sud razzista. La discriminazione che gli afroamericani si trovavano ad affrontare nel nordovest era più sottile, ma ne limitava comunque le opportunità. A Seattle, i neri vivevano quasi esclusivamente in una zona chiamata Central District, sei chilometri quadrati che contenevano alcuni dei palazzi più vecchi e fatiscenti della città. All’infuori di questo quartiere, i proprietari affittavano raramente i loro appartamenti a gente di colore e molte circoscrizioni avevano leggi che proibivano la vendita di terreni e immobili a persone di etnia non bianca. Nonostante le loro alternative in termini di alloggi fossero limitate, gli afroamericani avevano anche dei vantaggi nella segregazione de facto di Seattle. Nel Central District si era sviluppata una comunità molto unita, in cui una forte componente di orgoglio razziale favoriva il fiorire dei rapporti di vicinato. «Era una comunità abbastanza piccola perciò se anche non conoscevi una persona, conoscevi comunque la sua famiglia», ricorda Betty Jean Morgan, abitante di vecchia data del quartiere. Il Central District ospitava anche nativi americani, cinesi, italiani, tedeschi, giapponesi e filippini. Le scuole locali erano caratterizzate da un collage di etnie diverse. Nel quartiere – era anche il centro della vita della comunità ebraica cittadina – c’erano abbastanza minoranze etniche e religiose da far sviluppare un pluralismo culturale decisamente unico per quei tempi, non solo a Seattle ma in tutti gli Stati Uniti. La studiosa di storia Esther Hall Mumford ha intitolato Calabash la sua storia della Seattle nera, in omaggio alla tradizione africana di cucinare in un pentolone abbastanza capiente da poter sfamare l’intero villaggio; quella metafora – un quartiere aperto al prossimo e autosufficiente – calzava perfettamente alla descrizione del Central District di Seattle della prima metà del Ventesimo secolo. Quei forti legami sociali e quella connotazione di grande accoglienza da parte della comunità avrebbero esercitato un impatto decisivo sulla vita dei suoi membri.
La comunità nera di Seattle aveva i propri quotidiani, ristoranti, negozi e addirittura un proprio quartiere dei divertimenti raccolto attorno a Central Street, dove locali notturni e sale da gioco ospitavano le esibizioni di musicisti jazz e blues conosciuti a livello nazionale. La scena musicale era talmente vibrante che il direttore di un giornale la paragonò a quella della State Street di Chicago o della Beale Street di Memphis. Anche se i locali di Jackson Street non erano mete abituali per Preston e Clarice Jeter, costituivano un epicentro colorato e vibrante che avrebbe presto fatto da sfondo alla giovinezza dei loro figli e, successivamente, del loro nipote Jimi Hendrix.
* * *
La sfida più grande per i neri di Seattle – quella che metteva tutte le altre in secondo piano – era trovare un lavoro decente. La società bianca di Seattle tollerava gli afroamericani nella maggior parte delle situazioni, ma le uniche professioni aperte ai neri erano attività di servizio come il cuoco, il cameriere o il facchino alla stazione.
Come da copione, Preston trovò un posto presso i cantieri navali durante uno sciopero; di norma, si trattava di un lavoro riservato esclusivamente ai bianchi. Clarice trovò un impiego come domestica, mansione svolta, secondo un censimento del 1910, da oltre l’ottanta percento delle donne afroamericane di Seattle. Clarice, come gran parte delle madri di colore dei tempi, si occupava di bambini bianchi proprio mentre cominciava a sua volta a mettere al mondo figli.
Nel corso dei dieci anni successivi, Clarice avrebbe avuto otto figli, due dei quali sarebbero morti durante l’infanzia, mentre altri due sarebbero finiti in adozione. Lucille, la più giovane dei piccoli Jeter, era nata nel 1925, prematura di otto settimane. A causa delle complicazioni dovute a un tumore e della depressione post-parto, Clarice rimase in ospedale per sei mesi dopo la nascita di Lucille. Preston, che all’epoca aveva cinquant’anni e soffriva a sua volta di problemi di salute, non poteva occuparsi della famiglia; così inizialmente furono le tre sorelle di Lucille – Nancy, Gertrude e Delores – a prendersi cura della bimba. Le infermiere la portarono a casa in un giorno di dicembre tormentato da una tempesta di neve, fatto piuttosto insolito per Seattle. «Dovettero fare molta attenzione nel salire la collinetta che si trovava di fronte a casa nostra», ricorda Delores Hall, che ai tempi aveva appena quattro anni. «Me la misero in braccio e mi dissero: “Fai attenzione, perché questa è la tua nuova sorella”.»
I Jeter affrontarono enormi sfide durante i quattro anni seguenti. Clarice faceva avanti e indietro dall’ospedale per diversi problemi fisici e mentali, e i bambini vennero mandati in affido presso una grande famiglia tedesca che viveva in una piccola fattoria a nord di Greenlake. In questa zona abitata prevalentemente da bianchi, venivano spesso scambiati per zingari, un’altra minoranza etnica non molto ben vista dalla comunità bianca di Seattle.
Quando Lucille compì dieci anni, la famiglia era di nuovo riunita nel Central District. Da adolescente, Lucille aveva bellissimi occhi e una figura snella e slanciata. «Aveva lunghi capelli lisci, neri e folti, e un bellissimo ampio sorriso», afferma la sua migliore amica delle scuole medie, Loreen Lockett. Preston e Clarice erano particolarmente protettivi nei suoi confronti, infatti le proibirono di andare a ballare fino ai quindici anni. Graziosa e vivace, Lucille attirava l’attenzione perfino a quell’età. «Era una ragazza molto carina e un’ottima ballerina», ricorda James Pryor. «Aveva la pelle molto chiara e dei bellissimi capelli. Poteva tranquillamente passare.» L’espressione “passare”, nel linguaggio parlato dagli afroamericani del tempo, stava a indicare qualcuno con una pelle così chiara che poteva passare per bianco agli occhi del mondo. È chiaro che, in un certo senso, si trattava di un imbroglio, ma dal punto di vista lavorativo, questo spalancava un ventaglio di alternative solitamente negate alla maggior parte dei neri. Perfino all’interno della comunità afroamericana del tempo, la pelle chiara e i capelli lisci erano requisiti di bellezza, e Lucille possedeva entrambi.
Secondo tutti i resoconti, la quindicenne Lucille era educata e un po’ immatura. Aveva anche un certo talento musicale e sapeva cantare. Di tanto in tanto si iscriveva a gare amatoriali e in un’occasione vinse anche un premio di cinque dollari. Comunque la cosa che più le dava gioia era trovarsi su una pista da ballo con un partner in gamba. Una sera di novembre del 1941, mentre si recava a un ballo presso la Washington Hall, Lucille fece un salto a casa di una compagna di classe. Aveva appena compiuto sedici anni, frequentava le scuole superiori, ed era tutta eccitata al pensiero di assistere a un concerto del leggendario pianista jazz Fats Waller. In visita a casa della sua amica c’era un giovane proveniente dal Canada. «Lucille», le disse la compagna di classe, «ti presento Al Hendrix.»