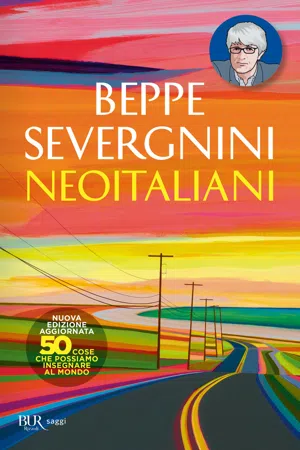L’Italia è stato il primo Paese fuori dall’Asia a sperimentare il coronavirus. È stato il primo a scegliere la chiusura, il 9 marzo 2020. L’immagine degli autocarri dell’esercito che portavano via i defunti di Bergamo è stampata nella memoria collettiva. Anche le province di Brescia, Lodi e Cremona hanno sofferto molto: i giornali locali erano camposanti di necrologi, ogni giorno se ne andava un conoscente. Crema, dove sono nato e vivo, è stata una città-fantasma per due mesi. La gente era angosciata. Però è rimasta a casa.
In maggio l’Italia ha riaperto, con cautela. È stata consentita una limitata attività sportiva all’aperto, quindi le visite a parenti, partner e amanti («affetti stabili» ha dichiarato il governo, aprendo un dibattito nazionale su ciò che rende stabili i propri affetti). Le fabbriche e le imprese di costruzione sono tornate al lavoro. Qualche giorno dopo, tra accortezze e litigi, è toccato a negozi, bar e ristoranti. Le scuole sono restate chiuse, non si sa perché. Indossare la mascherina è rimasto obbligatorio. Ci portavamo in faccia un promemoria verdeazzurro: quello che era accaduto, quello che non dovrà più accadere.
L’Italia ha tracciato un percorso che si è ripetuto, con tempi diversi, in ogni Paese colpito dal Covid. Prima la sottovalutazione; poi l’incredulità, l’ansia, il lockdown. Quindi la reazione: battute e meme sugli smartphone, sbalzi d’umore, la rassicurazione dell’inno nazionale. A quel punto abbiamo capito. La sfida contro il virus sarebbe stata una corsa sulla lunga distanza; e abbiamo iniziato a correre.
A Crema l’ospedale era sopraffatto dai malati, molti erano gravi e avevano necessità della terapia intensiva. L’esercito italiano ha costruito un ospedale da campo in pochi giorni, nel parcheggio. Una brigata sanitaria, composta da cinquantadue medici e infermieri, è arrivata da Cuba per aiutarci. Per tutto il mese d’aprile le sirene delle ambulanze hanno riempito l’aria. Intorno cielo blu, alberi in fiore e la più splendente primavera da molti anni.
Ora che questi sono diventati ricordi, forse possiamo dirlo: ce l’abbiamo fatta. Ho raccontato alcune di queste cose sul «New York Times», il titolo era: Why Italy Coped, and Will Keep Coping, perché l’Italia ha resistito, e continuerà a resistere. La conferma – dopo un’estate colpevolmente distratta – l’abbiamo avuta in autunno e in inverno, prima dell’inizio della campagna di vaccinazione. Non è stata una battaglia: è stata una guerra, piena di ansia e dolore. Sessanta milioni di persone, nel complesso, hanno osservato le regole. Sorprendentemente, considerata la nostra reputazione indisciplinata.
Ma è davvero sorprendente?
In Italia le regole non vengono rispettate – o ignorate – come altrove. Pensiamo che sia un insulto alla nostra intelligenza osservare una norma senza prima metterla in discussione. Qualsiasi norma: legale, morale, sociale, fiscale, stradale. L’obbedienza cieca è considerata banale. Vogliamo decidere se una determinata regola si adatta al nostro caso specifico. Una volta stabilito che è così, la osserviamo. Davanti alla minaccia del coronavirus, abbiamo deciso che il blocco aveva senso; e lo abbiamo rispettato. Non è stata una decisione collettiva. È stata la somma di milioni di decisioni individuali.
Ci siamo riusciti anche perché avevamo le risorse sociali e psicologiche per farlo. Realismo, resilienza, inventiva, il sostegno delle famiglie allargate, l’istinto – talvolta addirittura esibizionistico – all’altruismo e alla generosità.
Ci ha aiutato il fatto di essere un popolo socievole. Il web ci ha fornito nuovi strumenti, utili nell’emergenza. Le relazioni personali e familiari – la cui importanza ha prodotto tanta scadente letteratura internazionale, ma non può essere sottovalutata – si sono rivelate cruciali. I maschi hanno cucinato, aggiustato, riordinato come mai in passato. Se avevano figli, hanno trascorso tempo con loro. Ogni mamma s’è trasformata in un’insegnante, aggiungendo quel lavoro a tutti gli altri. Gli amici si sostenevano a vicenda. L’aperitivo su Zoom o sul balcone non è durato a lungo. Ma la forza e la pazienza che abbiamo dimostrato, deposti i bicchieri, è stata sorprendente.
Una pandemia – come una guerra, come qualsiasi grave crisi – è rivelatrice. Ci fa capire meglio le persone, le comunità, le organizzazioni e le nazioni.
Gli Stati Uniti d’America sono nati da una ribellione, nella cultura nazionale resiste il culto della libertà individuale: e s’è visto. Dal Michigan alla Pennsylvania, molti cittadini sono scesi in strada – alcuni, armati – a chiedere una riapertura rapida, aizzati dallo stesso presidente – Donald Trump – che, dopo aver minimizzato i rischi, aveva ordinato le restrizioni. Gli scossoni assestati dal coronavirus – scossoni sociali, economici, politici – hanno portato alle rivolte del movimento Black Lives Matter e poi alla sconfitta dello stesso Trump.
La Francia ha sempre mostrato un certo talento per la protesta di piazza, e le proteste sono arrivate: prima nelle periferie, poi in centro a Parigi, protagonisti anche medici e infermieri. Gli svedesi credono nella società aperta, e sono stati tra gli ultimi a chiudere, con riluttanza. I russi sono rassegnati al potere, ed è accaduto di nuovo con il Covid: nessuno sa cos’è accaduto davvero. In Gran Bretagna minimizzare è la religione ufficiosa di Stato; ma stavolta l’understatement ha portato a sottovalutare la minaccia. Solo il dramma personale del primo ministro Boris Johnson – ricoverato d’urgenza, ha rischiato la vita – ha convinto gli inglesi a rivedere il proprio punto di vista.
In Italia nessuna rivolta, poche manifestazioni, nessuna violenza, tanto meno una protesta armata. Qualche giustificato mugugno, tutt’al più, davanti alle indecisioni del governo, nazionale e regionale. L’inizio della campagna di vaccinazione è stato caotico, e ha mostrato episodi di egoismo contagioso. Ma poi la grande maggioranza degli italiani – del Nord e del Sud, di ogni condizione sociale e con qualsiasi livello di istruzione – ha deciso che le misure sanitarie avevano senso. I governanti dovrebbero ringraziare i governati, per una volta.
Ci sarebbe un modo di dimostrare questa gratitudine. Il governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi – utilizzando i molti denari in arrivo dall’Unione Europea – dovrebbe cercare di creare una nuova Italia, non solo di riaprire quella di prima. La burocrazia e l’eccessiva regolamentazione sono state spesso aggirate, durante l’emergenza; e l’Italia non è crollata, anzi. Lavorare da casa, per esempio, è diventato la norma per milioni di persone, in pochi mesi abbiamo compiuto enormi progressi in materia. Progressi che, in tempi normali, avrebbero richiesto anni; perché ministeri, uffici pubblici e privati, aziende e sindacati avrebbero trovato ogni pretesto per rimandare.
I nuovi italiani hanno mostrato di saper essere pazienti e, all’occorrenza, diligenti. Ora abbiamo bisogno di organizzazione, rapidità e precisione. Viviamo un tempo emotivo, e le emozioni sono il carburante italiano. Ma non bastano. Lo abbiamo capito? Credo di sì.
Esistono caratteri nazionali capaci di nascondere le incertezze dietro la vivacità. Noi italiani siamo fatti così. A ogni età, in ogni parte di Italia e in ogni condizione sociale sappiamo usare l’esuberanza come una cortina fumogena: soprattutto verso gli stranieri, ma non solo.
Nel tempo di pandemia è accaduto di nuovo. La reazione all’emergenza richiedeva empatia, prontezza, capacità d’immaginazione: tutte specialità della casa (italiana). Per superare il dolore – centotrentamila morti, ma probabilmente sono stati molti di più – abbiamo allestito una rappresentazione che serviva a consolare e a consolarci. Da una fragilità per noi inammissibile, abbiamo tirato fuori una forza inimmaginabile.
La prontezza con cui abbiamo affrontato la sfida del Covid – sperimentando tecnologie domestiche e nuove forme di socialità – non deve ingannare: è stata durissima per tutti, per alcuni più che per altri. Poi, lentamente, il trauma è stato rimosso. Di quella fragilità rimangono ombre e ricordi. La nostra mente ha iniziato a catalogarli, cestinando quelli più sgraditi.
Ci sono cose che non dobbiamo dimenticare, invece. Per esempio: la pandemia ha dimostrato che in Italia non siamo più abituati all’incertezza. Pensate a quanto avete letto, visto, ascoltato e ripetuto un corollario di annunci, paure, ansie, precauzioni, incomprensioni, litigi. Abbiamo l’illusione del controllo, e ogni tanto si rivela per ciò che è: un’illusione.
È inutile negarlo: siamo esseri umani, esseri fragili. Non c’è da vergognarsi, né da essere sorpresi. Siamo i cittadini degli Stati Esauditi dell’Occidente. I rischi della vita quotidiana in altre parti del mondo – rischi sanitari, alimentari, climatici, politici, polizieschi, militari – sono sconosciuti per chi vive in Italia e in Europa. Sarebbe interessante capire cosa pensano del Covid i giovani africani che, per venire qui, hanno sfidato il deserto, le prigioni libiche e il mare: potrebbero sorprenderci.
Le epidemie sono state affrontate, nei secoli, col passaparola, che poteva diventare isteria e calunnia (ce lo ha raccontato Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi). Poi sono arrivati i giornali; quindi i bollettini radio e i notiziari televisivi. Oggi sappiamo molto e molto in fretta: probabilmente troppo. Siamo iperinformati e ipersensibili. Abbiamo attraversato la prima pandemia social: le notizie che ci scambiavamo – a voce, per iscritto, per immagini – erano emotive e frammentarie. La sovrabbondanza di informazioni – spesso imprecise, talvolta false – diventava ansiogena. Virologi ed epidemiologi, spesso assai loquaci, hanno qualche responsabilità: frastornati dalla notorietà, alcuni di loro hanno contribuito alla confusione.
C’è chi parla di autosuggestione collettiva: ma ogni spavento nasce dentro di noi. Fuori accadono solo fatti, più o meno comprensibili. Perché siamo diventati tanto sensibili? Forse perché, insieme ai rischi, sono diminuiti gli imprevisti. In tasca portiamo un aggeggio che ci consente di conoscere le condizioni del traffico, la posizione dell’auto che verrà a prenderci, le previsioni meteo, la distanza da percorrere. Gli imprevisti esistono, lo sappiamo; ma li abbiamo confinati in una casella apposita, come nel gioco del Monopoli.
Gli strumenti che abbiamo a disposizione ci hanno disabituato all’imprevedibilità che ha accompagnato le generazioni prima di noi. Forse per questo temiamo tanto le malattie, che hanno segnato la storia dell’uomo. Averne sconfitte moltissime è meraviglioso; ma ci lascia psicologicamente vulnerabili davanti a quelle che restano. L’ipocondria ha smesso di essere una patologia, è diventata un aspetto della condizione italiana.
C’è un racconto familiare che non dimentico. Mio padre Angelo era nato nel 1917 in una cascina a Offanengo, nella campagna cremasca, settimo figlio in una famiglia di agricoltori. Contrasse l’influenza spagnola, che tra il 1918 e il 1920 uccise tra cinquanta e cento milioni di persone nel mondo, seicentomila in Italia. I genitori lo lasciarono nella culla in una stanza poco riscaldata, affidandosi alla provvidenza: dovevano pensare agli altri figli. Mio padre guarì, e sopravvisse: per quasi cent’anni. Raccontava spesso questo episodio, confermato dalle zie che ai tempi erano adolescenti, come un fatto della vita. Accadeva, un secolo fa, che una famiglia numerosa perdesse un figlio.
Tempi crudeli, che nessuno rimpiange. Tempi che stendevano sulla popolazione una patina di fatalismo che confinava, da un lato, con la rassegnazione, dall’altro, con il coraggio. Oggi siamo, insieme, più forti e più deboli. La medicina ha fatto passi da gigante, la sanità pubblica è, con l’istruzione gratuita e obbligatoria, la più grande conquista della nostra società. Fatichiamo però ad accettare che esistono fenomeni difficili da controllare. Eventi che ci costringono a usare parole antiche: contagio, quarantena, isolamento.
Chissà se noi italiani impareremo qualcosa da quanto è accaduto. Per esempio, se ricorderemo di essere fragili e di aver bisogno di aiuto. Se capiremo che, mentre passiamo in questo mondo, possiamo affrontare meglio le difficoltà unendo le forze e le intelligenze. Davanti al virus e a tutto il resto.
Ringraziare era doveroso. Ringraziare, guardare e salutare, senza far perdere tempo. Perché chi deve montare un ospedale da campo in tre giorni non ha tempo per la conversazione. Sono arrivato, ho appoggiato la bicicletta al cavalletto: da casa, ho pedalato per settecento metri. Mai avrei immaginato di vedere le gru, i camion e le tende gialle con le croci rosse nel parcheggio davanti al pronto soccorso, appena dietro l’edicola chiusa. Crema è piccola, spiccia e robusta. Ma ha avuto bisogno di aiuto, in marzo; e l’aiuto è arrivato. L’Ospedale Maggiore – che all’inizio ha assistito Codogno e la bassa lodigiana – non ce la faceva più.
È arrivato il 3° Reparto Sanità «Milano», di base a Bellinzago Novarese. Esercito italiano, trenta uomini. Quindici – mi aveva spiegato il tenente colonnello Michele Ricci, che li comandava – sarebbero rimasti a Crema dopo l’allestimento: trentadue degenze, tre in terapia intensiva. Poi è sopraggiunta una brigata sanitaria cubana, ospitata presso la Caritas diocesana. I militari alloggiavano nell’ex tribunale. Carro-attrezzi, allacciamenti, pulizie: le imprese locali non hanno voluto essere pagate. Domenica 28 marzo 2020, la parte militare era finita. Lunedì, i medici e i sanitari di Crema si sono coordinati con i colleghi di Cuba. Martedì, il primo paziente è entrato nell’ospedale da campo. Da quel momento, i malati sono arrivati senza sosta, a ogni ora, per un mese.
Michele Ricci è di Massafra, provincia di Taranto, è stato in missione in Kosovo, Afghanistan, Iraq: vederlo a Crema era surreale. Le ambulanze si susseguivano: lo stesso suono di sempre, ma noi non eravamo quelli di prima. Abbiamo attraversato il campo in allestimento insieme al sindaco Stefania Bonaldi, che era stanchissima, ma riusciva a sorridere dietro la mascherina. Ci conosciamo da anni. A Crema ci conosciamo tutti. Conoscevamo i morti, conoscev...