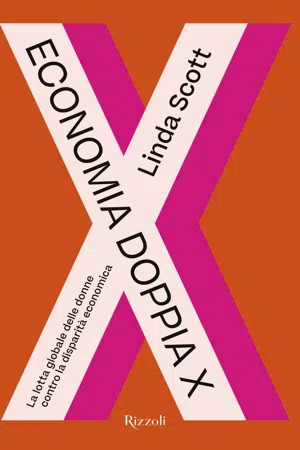Mentre l’auto procedeva per le buie strade di Accra sentii il cuore sussultare. L’autista descriveva le scene cui passavamo accanto, la voce piena di rabbia e dolore.
Centinaia di ragazze adolescenti, senza casa, si muovevano come ombre nella notte. Alcune, seminude, si lavavano dentro a catini, lì in mezzo alla via; non avevano altro posto in cui andare. Altre dormivano una sull’altra. «Fuggono dai villaggi» spiegò l’uomo al volante. «I genitori vogliono venderle in spose a uomini che non conoscono, farne mogli costrette a lavorare come animali di giorno e a sottomettersi sessualmente la notte. Scappano in città, nella speranza di sfuggire a quel destino.»
Molte avevano il pancione o tenevano per mano dei bambini. Secondo l’autista, nei villaggi gli stupri erano all’ordine del giorno, ma quelle strade non erano più sicure. «Un’intera generazione sta crescendo per strada, sin dalla nascita» disse in tono angosciato. «Non conosceranno mai una famiglia, una comunità. Come impareranno a distinguere tra ciò che è giusto e ciò che non lo è? Cosa accadrà al Ghana quando questi bambini diventeranno adulti?»
Gran parte di quelle ragazze lavorava nei mercati, trasportando gli acquisti dei clienti in ceste tenute in equilibrio sulla testa, ma alcune finivano nel giro della prostituzione. Altre rimanevano intrappolate in un incubo vecchio di secoli: la tratta degli schiavi è ancora una realtà nell’Africa occidentale, e i suoi proventi alimentano le principali associazioni criminali del pianeta.
Già nella hall del mio hotel mi sentivo come appena sbucata da un’altra dimensione. Da tempo conducevo ricerche sul campo tra i poveri di tutto il mondo, ma non mi era mai capitato di osservare nulla che mi turbasse quanto ciò che vidi durante la mia prima notte in Ghana.
Ero arrivata nel pomeriggio, per gettare le basi di un progetto promettente; il mio team di Oxford avrebbe avviato un’iniziativa volta ad aiutare le ragazze delle campagne a continuare il loro percorso scolastico. Saremmo partiti da cose semplici – ad esempio, fornire gratuitamente degli assorbenti – ma valeva comunque la pena provarci: far studiare le ragazze fino alle scuole secondarie è un potente incentivo economico per le nazioni più povere. Le donne maggiormente istruite apportano un contributo fondamentale sul mercato del lavoro, sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi, e ciò stimola la crescita. Inoltre fanno il primo figlio più tardi, dunque hanno meno bambini: ciò riduce il tasso di crescita della popolazione, altrimenti fuori controllo. E poi le madri che hanno ricevuto un’istruzione migliore crescono i figli in modo diverso, insistendo perché finiscano la scuola, mangino bene e ricevano cure mediche adeguate. Insomma, contribuiscono a spezzare le catene della povertà che intrappolano l’Africa.
Quella sera, però, incontrai qualcuno che mi mostrò cosa accadeva quando le stesse forze che spingono le ragazze ad abbandonare la scuola arrivano addirittura a farle scappare dalle loro case. Quelle giovani disperate finivano in una spirale negativa il cui influsso si estendeva in tutta la regione, condannando generazioni intere a pericoli e sofferenze. Una forza distruttiva che, lo sapevo bene, si propagava nel mondo, portando violenza e instabilità anche in altri Paesi; perché il traffico di esseri umani è una delle attività più proficue per le organizzazioni criminali internazionali. Ciò che ho visto quella notte ha cambiato per sempre il modo in cui affrontavo il mio lavoro, trasmettendomi un senso di urgenza che non è più svanito.
Al cuore di questo libro vi è una verità che pare improbabile: la parità salariale tra uomini e donne sarebbe in grado di arginare alcuni dei più gravi mali del mondo, contribuendo nel frattempo alla prosperità comune. Nelle pagine che seguiranno, racconterò molte storie simili a quella emersa dalle ombre di Accra; ripercorrerò alcune delle mie esperienze personali – dai villaggi dell’Africa alle baraccopoli dell’Asia, dai consigli di amministrazione a Londra alle università degli Stati Uniti – e mostrerò come lo stesso schema di esclusione economica si ripeta in luoghi tanto diversi, sempre con un impatto negativo.
A partire dal 2015, una mole sempre maggiore di dati ha confermato che un identico schema di disuguaglianza economica affligge la popolazione femminile di tutte le nazioni; a prescindere dal Paese cui si fa riferimento, sono sempre gli stessi meccanismi a tenere in piedi le disparità. Le barriere all’inclusione economica delle donne vanno oltre il lavoro e lo stipendio, ovunque; esse includono proprietà, capitale, credito e mercati. Questi ostacoli, associati ai vincoli di matrice culturale solitamente imposti alle donne (limitazioni alla libertà di movimento, vulnerabilità legate al loro ruolo riproduttivo e la costante minaccia della violenza), finiscono per dar forma a un’economia sommersa tutta al femminile: quella che io chiamo l’«Economia a doppia X».
Se la comunità globale si impegnasse a rimuovere tali impedimenti, vedremmo l’alba di una nuova era; un’era di pace e prosperità senza precedenti. Nel corso dei decenni passati si è sviluppato un movimento, pur contenuto, che mira proprio e semplicemente a questo: eliminare le barriere. Sebbene ancora poco diffuso, l’impegno per un’emancipazione economica femminile ha ora portata globale e annovera fra i suoi sostenitori alcune tra le più importanti istituzioni mondiali, in numero crescente: governi nazionali, agenzie internazionali, associazioni benefiche, organizzazioni religiose e multinazionali.
Quanto a me, ho supportato questo movimento fin dagli esordi. Ho iniziato conducendo una ricerca che valutava diversi progetti tesi ad aiutare le donne a raggiungere l’autonomia finanziaria. In un primo momento il mio impegno mi ha portata in zone rurali, soprattutto in Africa; ho messo alla prova le mie idee e quelle degli altri, lavorando a stretto contatto con donne di Paesi diversi e in condizioni differenti. Ho anche organizzato un meeting di specialisti internazionali, il Power Shift Forum for Women in the World Economy, in occasione del quale chi lavorava a questa causa poteva condividere quanto stava imparando. Poi, a partire dal 2015, mi sono focalizzata su qualcos’altro: nonostante continui a fare ricerca in aree disagiate, partecipo anche a incontri politici di alto livello mirati a incentivare riforme globali, il che mi porta a viaggiare tra le grandi capitali del mondo.
Mi rammarico spesso per ciò che vedo. I ministri che gestiscono l’economia mondiale tendono a sminuire chi sostiene i diritti delle donne, trattando quelle persone come fossero i membri di un club per signore. L’Asia-Pacific Economic Cooperation (l’organismo di cooperazione e crescita economica spesso indicato come APEC) e il G20 potrebbero organizzare una «settimana delle donne» o mettere in piedi gruppi di interesse, e inserire nei propri comunicati delle prese di posizione ufficiali sul tema; invece, non sembrano intenzionati a supportare, nei loro progetti, le esigenze specifiche di metà della popolazione. Si rifiutano di vedere quanto l’esclusione delle donne danneggi i sistemi economici di cui si occupano, e come invece una loro inclusione attiva nei bilanci nazionali sarebbe foriera di quella crescita che cercano tanto disperatamente. Trascurano l’Economia a doppia X solo in virtù di un pregiudizio.
Ecco perché abbiamo bisogno di voi. Grazie a questo libro, spero di reclutare molte voci, mani e menti alla causa dell’inclusione economica femminile. Propongo azioni concrete, ragionevoli ed efficaci, e vi chiedo di aderire a questo movimento indipendentemente da origini, etnia, orientamento sessuale e identità di genere di ciascuno di voi. Vorrei raggiungervi a prescindere dal fatto che lavoriate in una fabbrica, in un ufficio, in una fattoria, a casa o online. Ogni volta che leggerete «Noi dovremmo fare questo…» o «Noi possiamo dedurne…», sappiate che intendo tutti noi.
Ma perché solo ora si incomincia a parlare di questa economia sommersa? Per colpa di due ostacoli: l’assenza di dati e una visione ottusa dei nostri sistemi di scambio. Le misurazioni economiche si concentrano sui passaggi di denaro, ma gran parte del lavoro femminile – ad esempio la cura domestica o l’impegno nei campi – non viene retribuito. Inoltre, il nucleo più ristretto sul quale raccogliamo dati è di norma quello familiare, all’interno del quale i contributi portati dalle donne vengono tipicamente attribuiti a un capofamiglia maschio. Anche solo per queste due ragioni, il più delle volte i nostri sistemi non rilevano l’impatto economico dell’attività femminile.
A peggiorare la situazione, di rado le istituzioni – dalle università ai governi – hanno raccolto e analizzato i dati distinguendo per genere. Negli anni Settanta, all’esplodere del movimento femminista, pochissime donne erano entrate nelle università; di conseguenza nessuna disciplina si era concentrata su di loro. Nel corso degli ultimi cinquant’anni, mentre le accademiche aumentavano in numero e importanza, tutta una serie di discipline – storia, antropologia, psicologia, biologia, sociobiologia, archeologia e medicina, solo per citarne alcune – sono state trasformate dall’impatto di una semplice domanda: «E le donne?». Eppure, alcuni ambiti non sono stati ancora lambiti da quest’ondata di cambiamento, e l’economia è uno di questi. Nel frattempo, l’assenza di dati consistenti suddivisi per genere ha reso impossibile comparare in modo sistematico la condizione delle donne qui con quella delle donne là, o delle donne di oggi con quelle di un tempo.
L’ostacolo più grande, comunque, è stato l’atteggiamento sprezzante degli economisti nei confronti del mondo femminile, che li ha distolti dall’occuparsi della questione. Chi gestisce gli ingranaggi delle economie nazionali si forma in dipartimenti e istituti dove si insegna a considerare l’economia come una macchina posta su un piano superiore rispetto ai terreni in cui si sviluppano problemi quali l’esclusione di genere, e dunque indifferente a simili questioni. È proprio nelle università che gli economisti imparano a sminuire e ignorare le donne come categoria.
Di recente, l’ostilità degli economisti maschi nei confronti delle colleghe è stata al centro di una serie di articoli apparsi su «New York Times», «Washington Post», «Financial Times» ed «Economist». L’interesse della stampa è nato da uno studio che ha rivelato, con precisione agghiacciante, come quei signori si riferiscano nel privato al genere femminile: è stato analizzato un milione di post provenienti da un gruppo di discussione online, dove studenti e docenti di economia spettegolavano del proprio settore; l’intento era verificare se, negli scambi informali, gli economisti parlassero in maniera differente di colleghi e colleghe. Le parole più usate per riferirsi a una collega sono risultate: calda, lesbica, sessismo, tette, anale, sposarsi, nazifemminista, puttana, figa, vagina, poppe, incinta, gravidanza, carina, sposarsi, imporre, splendida, arrapata, cotta, bella, segretaria, scaricare, shopping, appuntamento, no profit, intenzioni, sexy, frequentata e prostituta. I termini impiegati in relazione agli uomini sono invece risultati: matematico, prezzo, consulente, libro di testo, determinato, Wharton, obiettivi, Nobel e filosofo. Le economiste hanno confermato ai reporter che simili espressioni incarnano il discredito verso le donne trasmesso alle giovani leve dai colleghi più anziani.1
A livello globale, l’economia è il campo di studi universitari in cui è più forte il predominio maschile; le diseguaglianze in tale ambito superano persino quelle in settori come la matematica, l’ingegneria e le materie tecnico-scientifiche in generale. Oggigiorno, con il numero di scienziate in costante crescita, in Paesi come gli Stati Uniti oltre la metà delle borse di dottorato viene assegnata a studentesse; per quanto riguarda l’economia, però, quella quota è ferma a meno di un terzo.2 E la rappresentanza femminile non è aumentata negli ultimi decenni, perché gli economisti non ritengono ci sia alcun problema in merito. Come ha spiegato l’economista Shelly Lundberg: «Nella maggior parte delle discipline, il senso comune suggerisce che la diversità sia di per sé una ricchezza. Eppure, nell’ambito delle scienze economiche tradizionali si tende a rigettare tutto ciò. È un riflesso della propensione a ritenere tale condizione frutto di efficienti dinamiche di mercato: gli economisti sono inclini a credere che, se non ci sono molte donne in questo ambito, è perché non ne sono particolarmente attratte, o non sono abbastanza produttive».3
Tuttavia, la cultura diffusa nei dipartimenti di economia suggerisce una spiegazione diversa. L’80 per cento delle professoresse del settore afferma infatti di aver sperimentato discriminazioni sessuali sul luogo di lavoro, con diffusi fenomeni di bullismo. In molte fanno esplicito riferimento all’esposizione delle proprie ricerche, così come richiesto a nuove assunte, giovani professoresse e dottorande: in quelle occasioni si trovano sempre bersagliate dagli sguardi indagatori e ostili degli accademici di sesso maschile, che paiono «voler inchiodare l’oratrice alla lavagna». Il 46 per cento di loro sostiene di non intervenire né esporre le proprie idee durante le conferenze accademiche, per paura di essere trattate in modo scorretto. Nel 2018 l’American Economic Association ha riconosciuto che, nel settore, la misoginia produceva «comportamenti inaccettabili [che] si sono diffusi grazie a una tacita tolleranza». Leah Boustan, economista di Princeton, spiega che i professori del suo ambito accademico considerano le donne come una categoria inferiore, il cui ingresso nel settore minaccia il loro status; perciò le intimidiscono, sperando di indurle a mollare e mantenere così intatto il proprio prestigio.4
Le discipline economiche hanno un enorme impatto sulla società, per via del loro ruolo nel consigliare i governi. «Se la visione del mondo di questa materia è distorta da sistematici bias di genere» ha scritto l’«Economist», «ciò ha conseguenze importanti sui politici e su quanti si rivolgono agli accademici per ottenere analisi, consigli o addirittura perle di saggezza.»5 I pregiudizi di quei professori nei confronti delle donne si traducono in un atteggiamento negativo rispetto al tema dell’economia femminile. Ecco perché è così difficile per l’Economia a doppia X ottenere un posto tra le priorità globali.
Anche il quadro filosofico alla base di questo atteggiamento intransigente rappresenta una barriera importante. Il suo principio cardine è che l’economia si sviluppi a partire dai comportamenti collettivi di singoli individui razionali e informati, i quali agiscono in modo autonomo compiendo scelte libere nel proprio interesse. Si ritiene che un sistema simile, se lasciato a se stesso, si organizzi in modo tale da produrre i risultati migliori possibili per ciascuno – non importa quante disuguaglianze sembrino esserci – come se fosse guidato dalla celeberrima «mano invisibile» di Adam Smith. Se una donna non trae benefici da un’economia così descritta, può significare solo due cose: o ha dei deficit innati o ha selezionato da sé quegli svantaggi.
Ma l’Economia a doppia X si trova a lottare con un quadro che contraddice queste semplici premesse, tanto da smentire l’intero impianto filosofico costruito su di esse. Come vedremo nel corso del libro, la possibilità di scelta delle donne – intese come categoria – è altamente limitata: le informazioni importanti vengono loro taciute, e sono punite se manifestano qualcosa di anche lontanamente simile a un interesse personale. Di rado è loro permesso di compiere scelte indipendenti in campo economico, e sono spesso costrette ad agire in modo irraz...