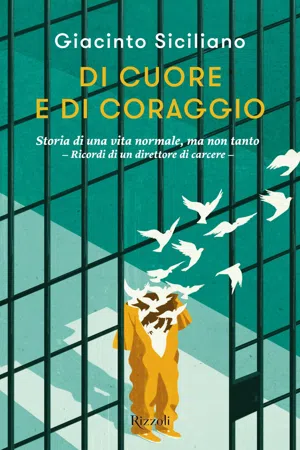Opera, 2007-2017
«Direttore, qua non funziona un cazzo!»
L’uomo, barricato dietro il cancello di ingresso del primo reparto dove erano accolti i detenuti di criminalità organizzata, non la smetteva di urlare. Sembrava caricato a molla e continuava a lanciare insulti e accuse rivolte a tutto e a tutti.
Avevo appena preso servizio e stavo facendo il mio primo giro del carcere: Antonio, uno degli agenti addetti al reparto, mi guardò, guardò il detenuto, poi sollevò gli occhi al cielo: «Dottó, questo è uno dei peggiori che abbiamo a Opera».
Il “peggiore” si chiamava Roberto Cannavò e mi stava dando il suo benvenuto. Accettando quell’incarico non pensavo certo di andarmi a mettere in una situazione tranquilla, ma se il buongiorno si vede dal mattino, quel mattino del 23 maggio 2007 avevo capito che negli anni a seguire non mi sarei annoiato. Mi ero avvicinato a lui e gli avevo detto: «Allora che facciamo? Vuole stare tutto il giorno a sgolarsi? Vuole fare il detenuto o il carcerato?».
«Qui non funziona niente, la sanità non funziona, lei deve rimettere tutto a posto…» Continuò così ancora per qualche minuto fino a che riuscii a blandirlo invitandolo a parlarne in un altro momento nel mio ufficio. Così feci nei giorni seguenti e, dopo aver ascoltato ancora tutta la lista delle sue lamentele, lo invitai a riflettere: poteva proseguire a urlare dietro le sbarre, a piangere per tutto quello che secondo lui non funzionava oppure poteva ragionare con calma e dirmi in modo costruttivo qual era il problema, ma, soprattutto, poteva chiedere sì la rivoluzione, ma solo quando lui stesso, per primo, avesse manifestato l’intenzione di cambiare strada, di dare una svolta alla sua vita. Quello che gli stavo chiedendo, in pratica, era di rimboccarsi le maniche e praticare il cambiamento partendo da se stesso. Per poi poterlo pretendere anche dagli altri.
Nel frattempo mi ero informato: Roberto Cannavò, pluriomicida legato un tempo al clan dei Cursoti catanesi, vari arresti alle spalle per rapina e altri reati in precedenza, era in carcere stabilmente dal 1993 per aver commesso più di un omicidio e ci sarebbe dovuto rimanere per sempre, senza poter accedere a nessun permesso e a nessun beneficio. Fine pena mai, con quasi due anni di isolamento diurno alle spalle, senza la possibilità cioè di partecipare ad alcuna attività, corso, lavoro, sport, di poter vedere altri detenuti. Solo un’ora d’aria la mattina e una il pomeriggio, sempre da solo. La sua era la storia di un’adolescenza spezzata, di un padre ammazzato dalla mafia per uno scambio di persona nel 1984 e dell’ingresso nella criminalità organizzata per rabbia e desiderio di vendetta. Cannavò mi guardò come si guardano i pazzi, ma qualcosa nei suoi occhi mi disse che non avevo parlato invano.
Quando il dottor Luigi Pagano, allora provveditore delle carceri lombarde, mi aveva chiamato per propormi il posto di direttore di Opera, mi ero preso le mie solite ventiquattr’ore per rifletterci per poi accettare l’incarico senza particolari perplessità. Anche a Sulmona avevo dato tutto quello che potevo, l’emergenza era rientrata da ormai un anno e mi sentivo di lasciare una situazione diversa, più gestibile e positiva. Avevo bisogno di confrontarmi con un’altra realtà e quella di Milano, che in parte già conoscevo e mi piaceva, mi sembrava una buonissima opportunità. Non era facile, lo sapevo, perché quello che mi si chiedeva dal momento in cui avrei preso servizio era ripristinare una situazione di piena funzionalità visto che, di lì a poco, sarebbe diventata operativa una nuova sezione per soli detenuti in regime di 41 bis. Io, che avevo lavorato in istituti difficili e di massima sicurezza e che forse mi portavo dietro la fama di direttore duro perché avevo quasi sempre trattato con appartenenti alla criminalità organizzata, ero stato individuato come la persona adatta a gestire quel passaggio.
All’epoca, Opera aveva solo una piccola sezione dedicata al 41 bis, dove già era recluso Totò Riina. Era un istituto molto particolare, abbastanza moderno, con una sua storia. Da alcuni anni stava però vivendo alcune difficoltà e il personale penitenziario, svuotato delle sue responsabilità, ne aveva risentito ed era demotivato. Le regole, soprattutto nella gestione dei detenuti più pericolosi, c’erano, ma, dal mio punto di vista, non erano applicate in modo conforme alle previsioni normative e alle circolari ministeriali in materia. Troppa promiscuità. Le porte delle celle erano aperte per gran parte della giornata, anche nelle sezioni che ospitavano i detenuti di criminalità organizzata. Le persone detenute avevano ampia possibilità di movimento senza che questa libertà rispondesse a un progetto, a un percorso di responsabilizzazione attiva. Era una modalità di gestione tanto diversa da quella che avevo sempre avuto, che avevo lasciato a Sulmona, e non mi sentivo a mio agio. Avvertivo la necessità di innalzare i livelli di sicurezza, ridurre le possibilità di incontro tra detenuti appartenenti a categorie diverse (mafiosi, comuni, tossicodipendenti), potenziare gli interventi, differenziare le attività educative, scolastiche e formative, che divenivano spesso il luogo di maggiore commistione e incontro.
A breve, poi, sarebbe stato aperto il nuovo reparto per i detenuti sottoposti al regime speciale del 41 bis. La struttura, che avrebbe ospitato sino a cento detenuti e che sarebbe stata la più grande in Italia riservata ai massimi vertici delle organizzazioni criminali, al mio arrivo era già stata costruita, ma non era ancora operativa. Lo sarebbe diventata presto e non potevo aspettare quel momento per prendere i provvedimenti che ritenevo urgenti. Tra questi, decidemmo di chiudere le porte delle celle in molte sezioni, anche nei reparti dell’alta sicurezza, ripristinammo orari di uscita, separammo nettamente spazi e attività evitando che detenuti di diverse categorie e tipologie potessero incontrarsi tra di loro così come previsto dalle disposizioni in materia.
L’apertura del reparto 41 bis fu repentina e avvenne letteralmente dall’oggi al domani, in seguito a un’emergenza. Era la notte del 5 novembre 2007 quando a Palermo ci fu una maxiretata e furono arrestate decine e decine di mafiosi latitanti per molti dei quali la Procura di Palermo richiese l’immediata applicazione del carcere duro.
La mattina seguente mi arrivò una telefonata dal dipartimento. «Siamo in emergenza e non ci sono posti altrove, dobbiamo aprire immediatamente la sezione» mi dissero.
Ci mobilitammo subito e in ventiquattr’ore riuscimmo a organizzare la ricezione di una decina di detenuti, nel giro di quattro mesi circa arrivammo al pienone. Da quel momento, Opera si qualificò come istituto di punta nella gestione dei detenuti sottoposti al regime speciale, ma soprattutto come carcere dove la normativa in materia veniva applicata con puntualità e rigore e dove le autorità giudiziarie chiedevano di inviare i detenuti più difficili da gestire o quelli su cui volevano particolari garanzie. Da Schiavone a Zagaria, da Riina a Santapaola, dai fratelli Lo Piccolo a Giuseppe Graviano e Giuseppe Morabito, solo per fare alcuni nomi, furono davvero tante le figure di spicco dei clan mafiosi che vi furono recluse. Se da un certo punto di vista questa tipologia di detenuti non era particolarmente difficile da gestire, se non altro per la sua tendenza ad alzare un muro di indifferenza con l’Istituzione, a stare al proprio posto e a tenere basso il livello di conflittualità palese, dall’altro, anche nella gestione ordinaria, c’erano alcuni aspetti su cui l’attenzione doveva sempre essere massima. Ogni cosa o comportamento del detenuto, in quel contesto, può assumere un significato particolare: un gesto, un atteggiamento, un flusso di comunicazione epistolare, una frase o un concetto espresso in una lettera che devi controllare prima di autorizzarne l’inoltro o la ricezione. Tutto va osservato con attenzione, tutto viene comunicato alla Direzione generale detenuti e all’autorità giudiziaria. E poi c’è la gestione del quotidiano: a differenza del detenuto “comune”, quello dentro per reati di marginalità, quello che nessuno conosce, il cui nome non dice niente, il mafioso è quello che si può permettere i migliori avvocati che al minimo cenno salgono da Palermo per fare un reclamo solo perché hai rifiutato al loro assistito la domandina per un collutorio nuovo. Su questi detenuti il livello di attenzione era così alto che era impossibile liquidare velocemente anche le più piccole faccende. No, dovevi prendere carta e penna, rispondere al reclamo per iscritto, coinvolgere il magistrato… una gestione complessa anche per quella che poteva sembrare la minima banalità. Anche in questo c’era la costante affermazione di un ruolo di vertice, di chi non accetta limitazioni non strettamente previste, rimarca la possibilità di difendersi e se possibile di vincere sempre, consapevole che ogni reclamo accolto dalla magistratura per possibili violazioni di diritti è un chiaro indebolimento del sistema che quelle persone sta gestendo.
I provvedimenti presi a Opera contribuirono a rinforzare l’idea di direttore duro, un’idea alimentata da una parte dagli incarichi rivestiti fino a quel momento e dall’altra, forse anche inconsciamente da parte mia, da alcune vicende personali. Il rigore che mi aveva sempre contraddistinto, in quel periodo divenne infatti un’esigenza imprescindibile. Io, che fino a quel momento ero sempre stato indicato come un direttore impegnato nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, all’improvviso mi ritrovai a difendermi dall’accusa di aver gestito in modo poco trasparente detenuti di criminalità organizzata reclusi a Sulmona.
Erano trascorsi appena otto mesi dal mio arrivo a Opera quando, a fine gennaio 2008, fui raggiunto da un avviso di garanzia nel quale mi si accusava di falso ideologico e omissione di comunicazione all’autorità giudiziaria di fatti costituenti reato. L’iter processuale, che mi avrebbe perseguitato per otto anni, era cominciato il giorno in cui si era insediato il nuovo governo, nel 2006, e con quello c’era stato un cambio ai vertici del DAP dove lavoravo nell’ufficio ispettivo da quando avevo assunto anche la dirigenza di Sulmona. Quel giorno avevamo deciso di fare una piccola festa per salutarci, il direttore dell’ufficio Salvatore Leopardi lasciava il suo incarico per andare a fare il PM a Palermo e lo stavamo aspettando per un brindisi. Leopardi però nella stanza non ci raggiunse mai. Mentre lo aspettavamo, vedemmo sfilare nel corridoio due magistrati, un uomo e una donna, con alcuni poliziotti accompagnati dal capo della segreteria del nostro dipartimento. Al loro passaggio ci fu il gelo, come il preannuncio di una tempesta imminente. Si diressero con passo deciso verso la stanza in fondo, quella del direttore, e vi entrarono. Ne uscirono dopo alcune ore per spostarsi in un’altra sede distaccata dove avrebbero dovuto acquisire degli atti. Non si sapeva molto di quello che era successo, solo voci che si accavallavano senza controllo. A quel punto li seguii anch’io, perché ero responsabile di una delle due sezioni dell’ufficio dove erano diretti. Mi presentai e, appena mi individuarono, mi bloccarono e mi fecero sedere su una sedia in corridoio dicendomi di aspettare. Là rimasi per ore senza la possibilità di poter parlare con nessuno. Quando, più tardi, sopraggiunse il dottor Leopardi, uno dei due magistrati uscì velocemente dall’ufficio e ordinò a un agente di controllarci a vista affinché non parlassimo tra di noi. «Questi due non si devono vedere, non devono parlare!» Questi due… usò esattamente tali parole, che mi suonarono molto crude: non eravamo imputati, non eravamo niente, ma l’ordine suonava così perentorio e il tono così giudicante! Dopo ore di attesa, su quella sedia sotto gli occhi di tutte le persone che passavano in quell’area, con modi che trovai altrettanto forti, fin quasi violenti, mi interrogarono fino all’una di notte. Mi chiesero perché ero lì, per quale motivo ero stato scelto per dirigere il carcere di Sulmona, perché Leopardi avesse scelto me per l’ufficio ispettivo, cosa facessi in quel posto. Mi chiesero se mi era mai successo da direttore che un detenuto volesse dare notizie in merito alla cattura di un latitante e cosa avessi fatto… Non era facile, in quel clima, ma risposi per come potevo e sull’ultima domanda riferii spontaneamente su quello che sarebbe diventato il caso Cutolo.
Con l’avviso di garanzia furono avviate anche le intercettazioni sui miei numeri di telefono. Dalle mie conversazioni telefoniche non venne fuori nulla di interessante per le indagini.
Dopo l’avviso di garanzia, mi presentai all’interrogatorio previsto, io solo tra i coimputati. In un clima pesante e violento, dissi tutto quello che sapevo e potevo. Non bastò, fui rinviato a giudizio dopo un’udienza preliminare in cui l’accusa disse di me delle cose indicibili, incredibili… non ero io, non potevo essere io la persona che descrivevano… i fatti contestati, i giudizi di valore… la vergogna, ancora quella, e il disonore. Fui indicato come esecutore di ordini impartiti dal mio superiore, il direttore dell’ufficio in qualità di presunto mandante… questo si legge nell’atto di imputazione.
Quelle accuse e il costante clima di sospetto alimentato da una certa stampa avrebbero reso molto difficile il mio lavoro a Opera, dove gestivo i massimi vertici della criminalità organizzata. Ecco perché, nel mio primo periodo in istituto, diffidente e scottato com’ero da quello che mi stava accadendo, iniziai a interpretare le norme e le circolari ministeriali in modo ancora più rigoroso di quanto avessi fatto fino ad allora. Sui giornali, nel giro di qualche tempo, ero diventato il direttore che proteggeva i mafiosi e lavorava con i servizi segreti deviati… una macchia sul mio onore che non mi avrebbe fatto dormire tranquillo per anni e che, ancora oggi, rappresenta un grande dolore.
La mia rigidità andò però a confrontarsi con una realtà in cui da sempre c’era stata molta attenzione alla persona, alle attività di recupero e di osservazione dei detenuti, a progetti innovativi e interessanti. In cui c’erano molti spazi particolari, da sfruttare in modo originale. Era un aspetto di Opera che mi affascinava e non volevo ignorare, anche perché era impossibile non essere contagiati da un contesto in cui c’era molto fermento rispetto ad altri che avevo conosciuto e in cui lavoravano svariate figure, compresi tanti volontari. Perciò, oltre ai provvedimenti “restrittivi”, quello che feci da subito fu di lavorare alla creazione di un buon clima, di valorizzare il ruolo di ognuno e fare in modo che tutti ritrovassero l’entusiasmo che avevano perso e l’orgoglio del loro ruolo. Una volta ripristinate regole, ruoli e competenze, non fu difficile riavviare l’intera macchina e riprendere in mano il discorso del trattamento e dell’osservazione, rivalorizzarlo e potenziarlo per dare la possibilità ai detenuti di intraprendere un percorso di evoluzione e cambiamento.
Se a Opera da una parte c’erano gli irriducibili alla Riina, quelli “indifferenti” a ogni tipo di attività, dall’altra c’erano detenuti, anche di alta sicurezza, su cui si poteva lavorare. E fu su questi detenuti che decisi di fare una scommessa e un investimento. Così com’era successo a Sulmona, negli anni a venire avrei avuto grandi sorprese e soddisfazioni.
La musica era finita di colpo sull’ultimo verso della canzone e i due fasci di luce sottile che avevano illuminato il solo volto del cantante sul palco buio si erano spenti lasciando brillare un’immagine su un maxischermo alle sue spalle. Avevo un nodo alla gola, un’emozione forte amplificata dalla tensione altissima che sentivo in tutto l’auditorium. L’applauso non arrivò subito, ci volle qualche secondo prima che partisse, come se tutti dovessero riprendersi da una specie di piccolo shock emotivo. Avevo visto quello spettacolo più volte e ancora non mi ero abituato alla forza dirompente di Signor tenente. Canzone scritta da Giorgio Faletti nel 1994, con un richiamo alle stragi di Capaci e via D’Amelio, è il racconto in prima persona di un giovane appuntato dei carabinieri sulle difficoltà di servire lo Stato, senza riconoscimenti, per pochi soldi e rischiando ogni giorno la vita. Proprio come quei ragazzi morti ammazzati di cui si parla nella canzone.
Non era stato facile trovare un interprete per quel brano. In molti, tra i detenuti che facevano parte del laboratorio di musical, non se l’erano sentita, chi per un motivo chi per un altro… troppo impegnativo e di rottura in quel contesto. Alla fine, uno che si era offerto c’era stato. Ed era la persona che ora, tra gli applausi della sala, si era girato di spalle al pubblico e guardando l’immagine di Falcone e Borsellino sul maxischermo stava dicendo: «Orgoglioso di essere siciliano!». Che detto da un ergastolano appartenuto a Cosa Nostra faceva una certa impressione.
Il 12 ottobre 2015, il concert show L’amore vincerà, per la regia di Isabella Biffi, in arte IsaBeau, interpretato da quindici detenuti del circuito dell’alta sicurezza di Opera andò in scena nell’auditorium dell’Expo. Non era la prima volta che portavamo fuori quel gruppo che si era esibito anche al teatro Arcimboldi, all’Ariston di Sanremo, passando per la sede istituzionale dell’auditorium del Palazzo di Regione Lombardia. Ogni volta era stato un successo. E non solo di pubblico o di incassi, ma una vittoria contro il pregiudizio e gli ostacoli, sempre numerosi, di poter portare fuori dall’istituto detenuti, quasi tutti ergastolani, che nella loro vita precedente si erano macchiati di crimini violenti.
Questa specie di magia l’aveva resa possibile l’arte del teatro, con il laboratorio di musical partito a Opera otto anni prima, che si confermava un incredibile strumento di riscatto in grado di trasformare le persone, di farne emergere la bontà prima sopraffatta dalla negatività, di «trasformare il veleno in medicina», come ripeteva spesso la regista. Di fede buddista, fervidamente convinta che cambiare è possibile e che la vita sia una evoluzione continua verso qualcosa di grande, che dietro l’ostacolo, anche il più insormontabile, ci sia un enorme beneficio, avevo conosciuto Isabella quando con un mio carissimo amico, Claudio Illarietti, che sarebbe poi diventato suo marito, molti anni prima, a Monza, in concomitanza con la kermesse sanremese, avevamo realizzato il Festival di Sanquirico, una bella parodia del Festival della canzone italiana. Con loro avevo riallacciato i contatti tornando a lavorare a Milano e ospitando a Opera, nel Natale del 2007, una rappresentazione musicale realizzata con le donne detenute nel carcere di Monza.
Fu uno spettacolo interessante, leggero e gradevole per tutti, ma era successa una cosa che non mi era proprio piaciuta. Salito sul palco per il saluto finale, mi rivolsi duramente a un gruppo di detenuti che per tutta la durata dell’intrattenimento avevano fatto apprezzamenti anche pesanti sulle ragazze che cantavano. Ribadii l’importanza del momento, quella del rispetto, la necessità di crescere tutti insieme se si volevano fare cose belle in grado di cambiare realmente la vita delle persone e la percezione di quel posto. Ci fu un momento di gelo, ma subito dopo scoppiò un grande applauso, dagli ospiti esterni, dagli stessi detenuti che con quel gesto avevano preso le distanze dai pochi che si erano comportati con superficialità, evidenziando totale mancanza di rispetto, per delle compagne e per loro stessi. C’erano i presupposti per lavorare…
Ero arrabbiato, ma anche fiducioso. Quell’episodio e il fatto di avere ripreso i contatti con Isabella e Claudio avevano messo in moto qualcosa nella mia testa… quel genere di pensieri che, prima o poi, mi portano a lanciare una nuova sfida, ad alzare sempre di più l’asticella nel confronto con i detenuti. Portare la musica e il teatro a Opera poteva essere una cosa bella, ma doveva essere l’occasione per costruire un nuovo modo di vivere il carcere, di stare insieme, di sfruttare il tempo, di stimolare le persone, accompagnarle, metterle alla prova. E se possibile valorizzare l’esempio di chi era in grado di prendere le distanze da atteggiamenti superficiali e da un mondo sbagliato.
La mia missione a Opera, se così si può chiamare, non doveva solo essere quella di mantenere la sicurezza, riempiendo per quanto possibile il tempo e lo spazio dei detenuti, di impegnarli in mille attività giusto per poter dire «qui facciamo questo e quello», ma portare i detenuti a mettere in discussione il loro mondo di valori (o meglio...