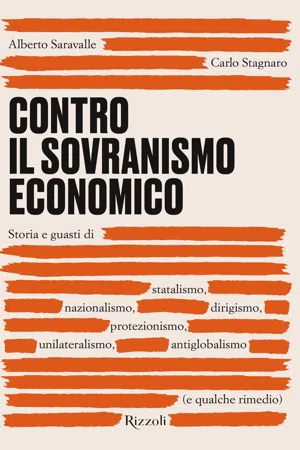Il mondo di ieri
Stefan Zweig nel Mondo di ieri descrive magistralmente l’Europa felix, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del secolo scorso, nella quale i diritti erano garantiti, le monete erano stabili e si poteva viaggiare liberamente senza passaporto da un Paese all’altro. Nel campo sociale si registrava un continuo, costante progresso «e persino il problema dei problemi, la povertà delle masse, non appariva più insuperabile». Non si temevano più le guerre e si era convinti «che i confini e le divergenze esistenti tra le nazioni o le confessioni religiose avrebbero finito per sciogliersi in un comune senso di umanità, concedendo così a tutti la pace e la sicurezza, i beni supremi». Insomma, il progresso in ogni settore della vita e della società sembrava inarrestabile e l’idealismo liberale che permeava le coscienze induceva a ritenere di trovarsi sulla via giusta, quella che conduce al migliore dei mondi possibili. Come poi sia andata a finire, a distanza di solo pochi anni, lo sappiamo bene, ma questa è un’altra storia.
Con qualche variazione, potremmo dire che una situazione simile era venuta a crearsi nel periodo che va dalla fine della Seconda guerra mondiale ai primi anni Duemila. Nel nuovo ordine economico internazionale, nato nel 1944 a Bretton Woods dalle ceneri del conflitto, si perseguiva anzitutto la stabilità monetaria. Memori delle svalutazioni e dei controlli sui cambi che negli anni Trenta avevano gravemente minato il sistema internazionale dei pagamenti e pregiudicato il commercio internazionale, fu disegnato un sistema nel quale gli Stati dovevano mantenere valute convertibili e cambi stabili con il dollaro (che era sua volta agganciato all’oro, e tale rimase fino al 1971).
D’altro canto, per prevenire il reiterarsi dei conflitti commerciali che avevano comportato, nel periodo tra le due guerre, una significativa riduzione degli scambi, impartendo il colpo di grazia alle economie già messe in ginocchio dalla Grande Depressione, fu concluso il General Agreement on Tariffs and Trade (GATT, 1947). Gli Stati membri si impegnarono a ridurre progressivamente le barriere (soprattutto tariffarie), attraverso una serie di negoziati multilaterali. Il progetto, rimasto incompiuto nell’immediato dopoguerra, fu portato a compimento parecchio tempo dopo, negli anni Novanta, con l’istituzione dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che definì in maniera più puntuale le regole in materia, introducendo un meccanismo di soluzione delle controversie.
In seguito, gli Stati intrapresero forme di cooperazione economica su base regionale sempre più stretta (CEE, EFTA, Mercosur, ASEAN, NAFTA) che in taluni casi non si limitarono ai rapporti commerciali, ma si estesero via via anche ad altri settori. Fin dalla sua istituzione nel 1957, per esempio, alla Comunità economica europea (CEE) furono riconosciute competenze in materia di politica agricola, dei trasporti e della concorrenza, per poi ampliarsi nel corso del tempo (ambiente, consumatori, reti transeuropee, coesione economica, sociale e territoriale, sanità, industria ecc.), comportando una maggiore integrazione tra gli Stati membri. Fino al grande passo, la firma del Trattato di Maastricht (1992), che sanciva la creazione dell’Unione economica e monetaria.
Sul piano industriale, dopo la lunga fase di espansione delle imprese statali, a partire dagli anni Ottanta, con la diffusione delle politiche di privatizzazione, diminuì la presenza pubblica nell’economia (prima in Europa, ma ben presto anche in tanti altri Paesi di più recente industrializzazione). Alle privatizzazioni si accompagnarono spesso, nel caso dei servizi pubblici, ampie liberalizzazioni: lo Stato passò così dal ruolo di proprietario a quello di regolatore.
Tratto saliente della politica economica in tutto l’Occidente fu poi la tutela della concorrenza che consentì di aprire sempre nuovi mercati. Nate negli Stati Uniti tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, le leggi antitrust si diffusero poi ovunque (l’Italia adottò la legge sulla concorrenza solo nel 1990). Nel Trattato di Roma del 1957 la concorrenza era addirittura inclusa tra gli obiettivi della Comunità economica; oggi – dopo il Trattato di Lisbona (2007) – è, più semplicemente, la condizione per realizzare un mercato interno libero e dinamico. A prescindere da queste modifiche, è restata però invariata la decisa azione delle istituzioni dell’Unione affinché al proprio interno la concorrenza non sia falsata. L’unificazione europea, infatti, presuppone l’integrazione dei mercati: questa, a sua volta, è incompatibile con la segmentazione e l’impenetrabilità dei mercati nazionali. Pertanto, la politica della concorrenza non è un accessorio, ma uno degli elementi costitutivi dell’UE.
Infine, gli investimenti diretti esteri crebbero in misura significativa, un po’ per effetto dei fenomeni sopra descritti (privatizzazioni, liberalizzazioni, abolizione dei controlli sui movimenti di capitali ecc.) e un po’ per la graduale rimozione degli ostacoli da parte di quegli Stati le cui economie avevano iniziato ad aprirsi più tardi al mercato. Nel complesso, il consensus delle élite e delle istituzioni economiche internazionali era a favore di politiche liberali, soprattutto negli ambiti del commercio internazionale e della regolamentazione dei mercati. Dunque, vi era una forte pressione ad allentare i controlli e spalancare le porte agli investitori stranieri (pur tra molte contraddizioni e resistenze).
La conversione della Cina e dei Paesi dell’ex blocco sovietico a logiche di mercato, che si registrò, rispettivamente, con l’ascesa al potere di Deng Xiaoping nel 1978 e il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, indusse molti analisti e osservatori a ritenere che una nuova era si fosse aperta: la globalizzazione si sarebbe ben presto affermata portando prosperità ovunque. Insomma, per parafrasare il titolo di un influente libro di Francis Fukuyama del 1992, si pensava che la storia fosse finita: il capitalismo e la democrazia liberale si erano imposti come ultimo orizzonte politico possibile, e la loro diffusione avrebbe consentito al benessere di germogliare ovunque.
… e quello di oggi
Immaginiamo ora di salire sulla DeLorean, la mitica macchina di Ritorno al futuro, e fare un piccolo salto nel tempo, che ci consenta di ripercorrere il ventennio trascorso dai primi anni Duemila fino al giorno d’oggi. Quasi superfluo sottolineare che il panorama economico che troviamo è mutato radicalmente. Anzi, potremmo dire che è quasi irriconoscibile. Che cosa è successo di così rilevante?
Innanzitutto, la stabilità monetaria non è più la norma. Gli Stati perseguono la propria politica economica facendo ampio ricorso alla leva monetaria e ciò innesca spesso reazioni a catena. La Banca centrale europea (BCE), per esempio, per diversi anni ha varato un robusto programma di quantitative easing per dare ossigeno alle economie fiaccate dalla grande crisi che tra il 2007-2008 ha contagiato buona parte del mondo, comportando l’indebolimento dell’euro e favorendo le esportazioni dei prodotti europei. L’annuncio di nuovi stimoli ha scatenato reazioni molto piccate da parte degli Stati Uniti. La Cina, a sua volta, in risposta all’applicazione dei dazi americani, agli inizi del mese di agosto 2019 ha lasciato svalutare lo yuan, che è scivolato rispetto al dollaro sotto la soglia psicologica di 7. Il che ha limitato l’effetto dei dazi e reso più difficili le esportazioni delle merci statunitensi. La replica di Donald Trump non si è fatta attendere: con un tweet ha accusato la Cina di manipolare i cambi (mossa che, peraltro, il presidente degli Stati Uniti aveva compiuto pochi mesi prima anche nei confronti dell’Europa). Parole pesanti, anche se la normativa americana in materia (l’Omnibus Trade and Competitiveness Act del 1988) non consente in questi casi di applicare dazi o sanzioni, ma tutt’al più di avviare immediati negoziati bilaterali in seno al Fondo monetario internazionale (FMI). Tale designazione è stata, comunque, poi ritirata nel gennaio 2020, in vista della firma dell’accordo di fase 1 che segna un armistizio nella guerra commerciale tra le due superpotenze. Da ultimo, con l’esplosione della pandemia di coronavirus, le principali banche centrali del mondo – inclusa la BCE – hanno avviato massicci programmi per sostenere l’economia in una fase storica straordinaria.
Proprio perché la leva monetaria è divenuta uno strumento decisivo nel promuovere gli interessi economici nazionali, si sono fatti sempre più frequenti gli attacchi all’indipendenza delle banche centrali: dai tweet furiosi di Trump contro il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, per non aver ridotto abbastanza i tassi, alle continue polemiche di casa nostra sull’opportunità o meno di uscire dall’euro e riappropriarsi del controllo della Banca d’Italia. Si tratta di un curioso contrappasso rispetto alla storia dell’indipendenza delle banche centrali, che si è sedimentata negli anni mediante decisioni normative (come il «divorzio» tra Tesoro e Bankitalia avvenuto nel 1981) e grazie all’autorevolezza dei banchieri centrali (da Paul Volcker a Mario Draghi), proprio con l’obiettivo di emancipare la politica monetaria dalle pressioni politiche. In questo mutato contesto, per la prima volta in Europa, al vertice della BCE si è proceduto a una nomina «politica» (seppure di indubbia esperienza internazionale) come la francese Christine Lagarde.
Il sistema multilaterale per ridurre gli ostacoli al commercio internazionale si è bloccato. Non solo da tempo non vi sono round di negoziati, ma addirittura l’OMC è stata boicottata dagli Stati Uniti, che lamentano l’inefficacia delle sue regole per bloccare le pratiche distorsive adottate alla Cina. Così gli USA hanno impedito la nomina dei nuovi membri dell’Appellate Body – l’organo di soluzione delle controversie – rendendone impossibile il funzionamento. I tentativi di creare accordi di libero scambio tra le principali aree economiche sono naufragati. Non appena Trump ha fatto il suo ingresso alla Casa Bianca (era il gennaio 2017), gli Stati Uniti hanno ritirato l’adesione al TPP (l’accordo con dodici Stati del Pacifico e dell’Asia) e i negoziati per il TTIP (l’accordo USA-UE) sono stati interrotti. Nel frattempo, è scoppiata una vera e propria guerra commerciale tra USA e Cina, che ha comportato l’applicazione di pesanti dazi doganali su centinaia di miliardi di export, con gravi ripercussioni anche per l’Europa. E – ciò che più preoccupa – l’arma dei dazi commerciali viene sempre più spesso invocata quale strumento di ritorsione contro misure di politica economica (ma non solo) di altri Stati. Trump, sempre lui, ha minacciato per esempio di applicare dazi sui vini francesi, in risposta alla digital tax sui giganti americani del web (Google, Facebook, Amazon…) così come sui prodotti messicani per indurre le autorità di quel Paese ad attivarsi per arrestare l’ondata migratoria verso gli Stati Uniti. La stessa Unione Europea, oltre ad aver applicato misure di salvaguardia per il settore siderurgico colpito dai dazi americani, ha per contro introdotto tariffe di importazione sulle moto di manifattura statunitense, come le Harley Davidson, causando non pochi problemi alla casa di Milwaukee. Solo dopo che i danni di questa escalation per il settore manifatturiero americano sono stati evidenti (nel dicembre 2019 c’è stato un severo rallentamento), Trump e il leader cinese Xi Jinping si sono decisi a sospendere le ostilità, con la firma di un accordo preliminare, noto come «US-China Phase 1». Esso prevede una riduzione dei dazi imposti dagli americani nel settembre 2019 a fronte di un impegno della Cina a incrementare le importazioni dagli USA e accordare maggiore protezione alla proprietà intellettuale, evitando i trasferimenti forzosi di tecnologia straniera. Eventuali controversie non saranno deferite a tribunali internazionali o comunque in sede multilaterale (l’OMC), ma saranno affrontate sul piano bilaterale. La pace però è durata solo qualche mese: l’aggravarsi della crisi pandemica negli Stati Uniti ha riacceso le ostilità con Pechino.
Intanto, il processo di integrazione europea non solo si è arenato, ma si è verificato l’impensabile: la Brexit, ossia il recesso del Regno Unito dalla UE, ha costretto tutti a fare i conti con una realtà molto diversa da quella immaginata. Ci si è così resi conto che l’eterno richiamo a un’Unione Europea sempre più stretta non era altro che un’enunciazione sulla carta. Oltre a questo, con la Brexit sono stati messi in dubbio quelli che apparivano gli assi portanti del progetto di integrazione europeo, ovvero il mercato interno e l’Unione economica e monetaria. Un articolo dell’«Economist», intitolato eloquentemente «La politica economica al cuore dell’Europa sta scricchiolando», ha dimostrato come il mercato interno sia ancora troppo frammentato per quanto attiene ai servizi. Del resto, non è un caso che le grandi imprese dell’era digitale si siano formate quasi tutte fuori dall’Europa. Anche l’Unione economica e monetaria ha mostrato la propria inadeguatezza durante la crisi dei debiti sovrani e, purtroppo, la strada per farla progredire è assai lunga e difficile. Da anni si susseguono rapporti delle istituzioni europee pieni di progetti ambiziosi, cui però non fa seguito alcuna azione comune. E nel frattempo aumenta la polemica antieuropeista che talora assume anche connotazioni pericolose. L’assalto dei sovranisti alla cittadella, in occasione delle elezioni europee del 2019, è fallito, ma l’assedio continua.
Per quanto concerne la politica economica, non solo il trend favorevole alle privatizzazioni su scala globale sembra essersi fermato, ma addirittura, in molti Stati si è rilevata una netta inversione di tendenza. Ovunque si nota, infatti, un ritorno della presenza dello Stato in economia per salvare i perdenti, salvaguardare i livelli occupazionali, rimediare ai presunti fallimenti del mercato ecc. Un fenomeno particolarmente evidente nella retorica di quasi tutti i partiti europei (anche quelli a prima vista liberali: si pensi alla Francia di Emmanuel Macron). Al tempo stesso si sono fatte pressanti le richieste di allentare la politica della concorrenza per dare la priorità a precise scelte di politica industriale. In altri termini, si vorrebbero creare in laboratorio dei «campioni europei» che il nostro habitat – secondo la vulgata antieuropeista – sarebbe incapace di far crescere in maniera autonoma. Vi è anche chi vorrebbe addirittura foraggiarli perché poi, barando, vincano le battaglie contro i «campioni stranieri». È inevitabile che, in questo contesto così politicizzato, si facciano sempre più frequenti anche gli interventi dello Stato per bloccare gli investimenti dall’estero, di solito con il pretesto di proteggere le imprese «strategiche». Sappiamo bene, però, che quella di strategicità è una nozione ambigua e che sotto questa denominazione si possano nascondere ben altri obiettivi, spesso volti a tutelare interessi particolari.
Insomma, nell’arco di pochi anni, il mondo è profondamente cambiato, e non per il meglio.
Un diffuso malessere
La crisi del 2007 – e i conseguenti smottamenti del sistema finanziario globale, la recessione in Europa, la crisi del debito sovrano – ha fatto emergere in maniera patologica una serie di fenomeni che fino ad allora erano considerati fisiologici. La globalizzazione, infatti, è il contesto all’interno del quale si sono sviluppate numerose tendenze, ciascuna delle quali ha avuto (e ha) serie conseguenze. Per citare solo i macrotrend più rilevanti: il cambiamento tecnologico, la progressiva presa d’atto delle preoccupazioni per il futuro del clima, le transizioni demografiche.
La combinazione tra questi elementi ha determinato, in Occidente in generale, e in Europa in particolare, effetti rilevanti sul livello del benessere economico delle persone, sulla distribuzione della ricchezza e del reddito e sulle prospettive per il futuro, a medio e a lungo termine, che ciascuno nutre per sé e per i propri figli. In un certo senso, la profezia più suggestiva e azzeccata la dobbiamo a Karl Marx e Friedrich Engels, che nel loro Manifesto del partito comunista scrivevano: «La grande industria ha creato il mercato mondiale, il cui avvento era stato preparato dalla scoperta dell’America. Il mercato mondiale ha dato uno smisurato impulso allo sviluppo del commercio, della navigazione, delle comunicazioni terrestri. Tale sviluppo ha a sua volta retroagito sulla crescita dell’industria. E nella stessa misura in cui crescevano industria, commercio, navigazione, ferrovie si sviluppava anche la borghesia. Ed essa accresceva i suoi capitali e metteva in ombra tutte le classi di origine medievale».
Proprio così. La globalizzazione ha avuto ampie ripercussioni sulle «classi di origine medievale» dei giorni nostri, ossia su tutti quegli individui e imprese che sono stati spiazzati dalla concorrenza internazionale, dal progresso tecnologico, dalle mutate preferenze sociali, da una società la cui composizione si sposta sempre di più verso la fascia degli «anziani in buona salute» o dei «giovani anziani». Una delle dimensioni più clamorose – e che ha suscitato la massima attenzione degli studiosi – riguarda la disuguaglianza, interpretata come una delle principali determinanti dei cambiamenti politici in atto. A questo proposito, occorre tuttavia prestare estrema attenzione all’ambito nel quale tale variabile viene misurata, prima di trarre conclusioni affrettate, di tipo politico o sociale. Se guardiamo ai mutamenti di lungo termine – diciamo dalla caduta del Muro in poi – a livello globale la disuguaglianza si è significativamente ridotta, principalmente grazie al fatto che più di un miliardo di persone (soprattutto in Cina) sono uscite dalla povertà più estrema. Nel mondo anglosassone, invece, la disuguaglianza è aumentata in modo assai rilevante: se è vero che, in media, tutti hanno visto migliorare la propria condizione, la velocità con cui sono cresciuti i «primi» (il top 1 per cento, o ancora più il top 0,1 per cento) è assai maggiore di quella con la quale si sono mossi gli «ultimi». Chi è andato più lentamente sono i cosiddetti ceti medi: è proprio per questo che si parla, forse eccedendo nell’enfasi, di scomparsa della middle class. Infatti, il ceto medio ha visto accorciarsi la propria distanza dai poveri (che sono diventati meno poveri) e allungarsi quella rispetto ai ricchi (che sono diventati più ricchi). La stessa cosa si è verificata anche in diversi Stati dell...