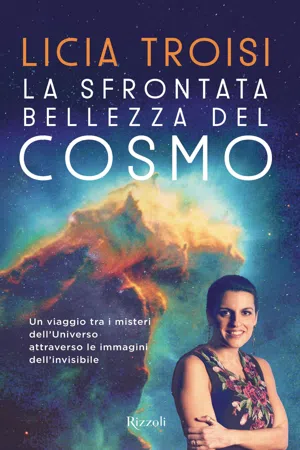La prima immagine del nostro viaggio non è un’immagine astronomica in senso stretto. E non potrebbe essere altrimenti. La storia dell’osservazione del cosmo, lo abbiamo visto, non comincia certo con l’invenzione degli strumenti con i quali potenziamo i nostri sensi, o grazie ai quali siamo in grado di ottenere immagini riproducibili. Per lunghi secoli, l’unico modo per registrare e perpetuare ciò che si osservava era disegnarlo, dipingerlo o inciderlo. Nonostante ciò, anche questo affresco, perché di ciò si tratta, ha un che di scientifico.
L’immagine in sé è facile da comprendere per chiunque: è un’adorazione dei Magi, nello specifico quella dipinta da Giotto tra il 1303 e il 1305 nella Cappella degli Scrovegni, a Padova. Però quel che ci interessa qui non è né la delicatezza dei colori né la maestria del panneggio. È piuttosto l’oggetto che si vede sopra la capanna, e che tutti noi siamo in grado di identificare a colpo d’occhio: la stella cometa.
Conosciamo tutti la storia evangelica: in cielo appare una stella, notata dai Magi, antichi sapienti orientali, che la interpretano come un segno celeste. Si mettono dunque in viaggio, seguendo il nuovo astro, fino a giungere a Betlemme, ove si imbattono nella Sacra Famiglia e in Gesù Bambino.
Le parole qui sono estremamente importanti: il Vangelo di Matteo, in cui questa storia viene raccontata, menziona una stella, in greco ἀστὴρ (astèr). Non si parla quindi di una cometa, ma di una generica stella, un prodigio che si verifica in cielo per portare testimonianza di un evento straordinario avvenuto sulla terra. E, infatti, prima di Giotto le rappresentazioni della Natività mostrano astri generici, e non comete, che pure erano un fenomeno osservato e conosciuto fin dall’antichità. Ma quella di Giotto, lo vediamo con chiarezza, è proprio una cometa. E, se la confrontassimo con l’immagine di una cometa osservata con un moderno telescopio, ci accorgeremmo anche che si tratta di una rappresentazione piuttosto accurata. E dunque?
Nel 1301, pochi anni prima che Giotto realizzasse la sua Adorazione dei Magi, si verificò un fenomeno astronomico degno di nota: il passaggio della cometa di Halley, una delle più famose e brillanti tra quelle che periodicamente ci fanno visita nei nostri cieli. L’ultima volta che abbiamo avuto modo di vederla è stato nel febbraio del 1986, la prossima sarà nel 2061. La sua periodicità è di circa settantasei anni.
Non è difficile allora immaginare che Giotto abbia assistito a questo evento, e che ne sia rimasto così profondamente colpito da decidere di rappresentarlo nella sua Adorazione. Peraltro, modificando per sempre il nostro immaginario in tema di Natività, perché è proprio da quel momento che l’astro generico di Matteo diventa per tutti la Stella Cometa.
Questa è proprio l’ipotesi che è stata fatta sia da alcuni ricercatori sia da storici dell’arte, anche se questa interpretazione non vede concordi tutti gli studiosi. C’è chi fa notare che comunque la cometa di Giotto ha ancora forti connotazioni simboliche (il numero di raggi e linee dorate, per dirne una), e che dunque non vi sia alcun reale intento naturalistico in questa rappresentazione. Ma, certo, è indubitabilmente una cometa.
Ma cos’è una cometa?
È un corpo minore, in soldoni un oggetto non abbastanza grande da poter essere classificato come pianeta o come satellite, “avanzato” dalla formazione del nostro Sistema Solare. Infatti, secondo le teorie più accreditate, il Sole e i pianeti si sarebbero formati a partire da una nube gassosa, generata in seguito alla morte di una o più stelle precedenti esplose in quei giganteschi “botti” detti esplosioni di supernova. Questo materiale avrebbe iniziato ad addensarsi nel centro, ove si sarebbe formata prima la protostella e poi il Sole, mentre dal poco che restava ‒ il Sole accentra su di sé più del 99% della massa di tutto il Sistema Solare ‒ si sarebbero formati i pianeti. Tutto ciò che è avanzato, pezzi di roccia, di ghiaccio e polvere varia, sono i corpi minori. Ma le comete sono speciali.
Innanzitutto, sono composte prevalentemente di ghiaccio, con l’aggiunta di roccia e metalli. È questo il segreto della loro coda: quando una cometa, nella sua orbita, si trova a passare nelle vicinanze del Sole, il calore della nostra stella è in grado di far sublimare il ghiaccio che la compone, ossia far passare l’acqua dallo stato solido a quello gassoso. Questo materiale, assieme alla polvere liberata, forma una chioma che circonda il nucleo cometario; tale materiale viene poi spazzato via dalla pressione di radiazione del Sole, ossia dalla forza esercitata dalla radiazione elettromagnetica emessa dalla nostra stella. Si forma così la coda che tutti conosciamo. In verità, di code ce ne sono spesso due: una è composta di polvere, più pesante, e un’altra è composta da gas ionizzato, ossia carico elettricamente e dunque maggiormente sensibile al campo magnetico solare, che ne determina la direzione. È questa la ragione per cui le due code non sono in genere allineate.
Nel 1997 i nostri cieli furono solcati da una cometa spettacolare: Hale-Bopp, che, come nel caso di quella di Halley e di altre comete, prende il nome dai suoi scopritori. Io avevo sedici anni e ne ho un ricordo nitidissimo; mi capitò di vederla durante un viaggio dal paese di mia madre, nell’Appennino sannita, verso Roma. La notte era molto buia, senza Luna, e senza sorgenti di luce artificiale. La cometa era immensa, occupava luminosissima una porzione enorme di cielo. E le due code erano facilmente visibili. È uno degli spettacoli più straordinari cui abbia mai assistito, un ricordo davvero indelebile. Per chi se la fosse persa in quell’occasione, sarà di nuovo visibile tra circa 2511 anni. Tenete duro. Scherzi a parte, salta immediatamente all’occhio la differenza di periodicità tra la cometa di Halley e quella di Hale-Bopp. Le comete vengono infatti divise in due grandi categorie in base al loro periodo orbitale, ossia il tempo che impiegano a compiere un giro completo intorno al Sole: comete di corto periodo, come quella di Halley, con periodo inferiore ai 200 anni, e a lungo periodo, come Hale-Bopp, con periodi che possono arrivare anche a milioni di anni. Esistono poi comete dalle orbite sostanzialmente aperte, che compiono un unico passaggio intorno al Sole, per poi abbandonare il Sistema Solare.
In genere le comete provengono da regioni distanti del Sistema Solare: Halley, nel punto dell’orbita più distante dal Sole (il cosiddetto afelio), raggiunge l’orbita Nettuno. Invece Hale-Bopp proviene probabilmente dalla nube di Oort, una regione sferica che circonda il Sistema Solare, la cui esistenza è stata fin qui solo ipotizzata dall’omonimo astronomo. Non è mai stata osservata per la semplice ragione che è molto distante e troppo poco luminosa per i telescopi che possediamo al momento.
Esistono poi comete di recente scoperta che provengono da regioni più prossime a noi, la cosiddetta fascia principale, una regione di spazio ricca in asteroidi, semplici pezzi di roccia vaganti delle dimensioni più varie, che si trova tra Marte e Nettuno.
Infine, ci sono le comete radenti, che letteralmente sfiorano la superficie solare, e che, come si potrà ben immaginare, non hanno vita lunga. Ma in generale l’esistenza di una cometa è costellata di pericoli, e l’impatto con i pianeti del Sistema Solare è tutt’altro che raro.
Gli anni Novanta sono stati piuttosto interessanti in termini di eventi astronomici, e nel 1994 la cometa Shoe-maker-Levi decise di finire la propria esistenza schiantandosi su Giove. Anche questo fu un evento di grande risonanza scientifica, e non solo: molti telescopi furono dedicati al suo studio, due sonde nelle vicinanze del pianeta, la Ulysses e Voyager 2, vennero puntate in maniera tale da poterlo seguire raccogliendo dati e la notizia arrivò anche sui media generalisti.
La cometa venne scoperta nel 1993, e la sua particolarità era quella di non orbitare attorno al Sole, bensì intorno a Giove; l’enorme gravità del pianeta l’aveva infatti catturata e ne aveva dilaniato il nucleo, riducendola in una serie di frammenti che si muovevano in sincronia. Studiata l’orbita dell’oggetto, fu possibile prevedere il momento dell’impatto. Giove in realtà non ha una superficie in senso proprio: si tratta di un gigante gassoso, ossia di un pianeta composto per la gran parte di gas e con un piccolo nucleo solido. Dunque, la Shoemaker-Levi terminò la sua esistenza inabissandosi nei densi strati gassosi dell’atmosfera gioviana. Ma ciò non rese l’evento meno impressionante: la serie di impatti causò vere e proprie palle di fuoco, liberando enormi quantitativi di energia, e letteralmente scavando buchi neri sulla superficie gassosa del pianeta, composti prevalentemente da detriti causati dall’impatto, e visibili per giorni.
Ma, ancora una volta, non si trattò solo di uno spettacolo straordinario: l’impatto permise di studiare tanto la composizione della cometa quanto quella degli strati più profondi dell’atmosfera di Giove. La nostra conoscenza delle comete, però, non si limita più solo alle ipotesi o a ciò che abbiamo dedotto dai catastrofici impatti di questi oggetti celesti sui pianeti del Sistema Solare. Perché sulle comete noi ci siamo stati.
Già nel 1986 la sonda europea Giotto, chiamata così proprio per via dell’affresco in apertura di capitolo, approfittò del passaggio della cometa di Halley per arrivarle a una distanza minima di 596 km, scattando un’altra immagine storica, la prima di un nucleo cometario.
Nel 2004, la missione Stardust della NASA ebbe un incontro ravvicinato con la cometa Wild 2, con lo scopo di raccogliere materiale dalla sua coda e scattare foto; la missione ebbe un tale successo che venne estesa, e nel 2011 arrivò a una distanza minima di 181 km dalla superficie di una seconda cometa, Tempel 1. I campioni raccolti vennero poi inviati sulla Terra e analizzati, in parte anche in Italia. Precedentemente, la povera Tempel 1 era stata anche “bombardata” dalla missione Deep Impact, che le sparò contro un proiettile, con lo scopo di portare alla luce parte del materiale più profondo della cometa. Dell’impatto esiste anche un video che mostra l’avvicinamento del proiettile; a vederlo, ricorda molto quei video che mostrano i missili militari colpire i loro obiettivi. Solo che qui non ci sono né morti, né feriti, né rovine; solo polvere raccolta per il bene della scienza.
Incidentalmente, la missione è stata utilizzata anche per testare la fattibilità di sparare contro una cometa per cercare di deviarne l’orbita, nel caso entrasse in rotta di collisione con la Terra. Secondo i calcoli effettuati all’epoca dalla NASA, in conseguenza dell’impatto la posizione del perielio della Tempel 1, ossia il punto della sua orbita più vicino al Sole, venne modificata di dieci metri, un valore minuscolo. Però, secondo gli stessi calcoli, l’energia liberata dall’impatto sarebbe stata in grado di modificare in modo sostanziale l’orbita di un oggetto più piccolo. In sintesi, è possibile deflettere un oggetto che sta per caderci in testa sparandogli contro qualcosa di molto massivo. Dato che esiste sempre una possibilità, per quanto piccola, che un asteroide o una cometa di grandi dimensioni impattino sulla Terra causando effetti catastrofici, sia la NASA sia l’ESA (l’Agenzia Spaziale Europea) stanno studiando la possibilità di impedire un evento del genere.
Ma se si parla di comete e di immagini iconiche, il primato probabilmente spetta alla missione Rosetta, di cui sono certa abbiate sentito parlare.
Si tratta di una missione europea che venne lanciata nel 2004, con l’obiettivo di raggiungere la distante cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. Il viaggio durò dieci anni, con numerosi flyby (sorvoli ravvicinati) intorno a vari pianeti del Sistema Solare per raggiungere la velocità necessaria al viaggio. Si tratta di una tecnica ideata da Giuseppe Colombo, matematico italiano; in sostanza, si fa passare la sonda vicino a un pianeta. La gravità di quest’ultimo tenderà ad accelerare la sonda in fase di avvicinamento, trascinandola con sé nel proprio moto intorno al Sole, e dunque nel complesso modificando la sua velocità. L’operazione che doveva compiere Rosetta era così complessa che dedicai alla sonda una delle due tesine che dovevo presentare alla sessione di laurea: ai miei tempi, oltre alla tesi occorreva discutere anche un articolo di argomento diverso da quello della specializzazione, scelto tra due alternative preparate dal candidato. Per di più, dopo l’osservazione dell’asteroide 21 Lutetia, nel 2010, la sonda andò in ibernazione, per riaccendersi solo quattro anni dopo, nel gennaio del 2014.
Nonostante siamo ormai abituati all’idea che ci siano sonde di vario tipo in giro per il Sistema Solare, l’esplorazione dello spazio resta ancora un’attività pionieristica, piena di rischi e dai risultati sempre molto incerti. Deve andare tutto bene, nello spazio, o il rischio di perdere il lavoro di anni è altissimo, e nel contempo i modi in cui qualcosa può andare storto sono pressoché infiniti. Questo per dire che esisteva la concreta possibilità che Rosetta non uscisse dall’ibernazione, e ricordo ancora l’emozione che provai quando i media, nel 2014, trasmisero il primo segnale della “bella addormentata”, ormai risvegliata.
Rosetta entrò in orbita intorno alla cometa nel settembre di quell’anno, iniziando a trasmettere immagini incredibilmente dettagliate della sua superficie. Durante i suoi due anni di attività si mantenne a una distanza dal corpo celeste compresa tra i 30 e i 10 km. Ma non è neppure per questo che è famosa. Rosetta ci ha infatti permesso di atterrare per la prima volta su una cometa. L’ha fatto il piccolo lander (modulo di atterraggio) Philae, il 12 novembre di quell’anno. Come ho detto, nello spazio spesso quel che può andare male va male, per via delle condizioni estreme nelle quali si è costretti a operare. Così è accaduto con Philae: durante la discesa, in caduta libera, quindi guidata dalla debolissima forza di gravità della cometa, andò tutto bene, ma al momento dell’impatto i piccoli arpioni del lander, che dovevano essere sparati verso la superficie e permettere un solido ancoraggio di Philae, non funzionarono, così come il razzo necessario per le manovre di “accometaggio”, per usare il neologismo coniato all’epoca. Il risultato fu che Philae rimbalzò tre volte, e infine si accomodò sulla superficie in un punto diverso da quello originariamente previsto, sul lato in ombra. Era un problema, perché Philae aveva delle batterie, che però avrebbero dovuto ricaricarsi grazie a dei pannelli fotovoltaici, che in questo modo non ricevevano la luce del Sole. Ma Philae funzionava, e da subito iniziò a inviare immagini sulla Terra. Erano le prime che provenivano dalla superficie di una cometa, un mondo così distante e alieno che fino a quel momento avevamo solo potuto immaginare grazie a film e serie televisive.
L’immagine forse più famosa trasmessa dalla sonda è in realtà un breve filmato, ottenuto montando una serie di foto scattate dal lander. Mostrano un ambiente ghiacciato, apparentemente flagellato da una tempesta di neve. In realtà, quel che si vede sono principalmente due distinti fenomeni: da un lato, il pulviscolo illuminato dal Sole, in sospensione intorno a Philae, dall’altro i raggi cosmici, particelle ad altissima energia che, quando colpiscono un rivelatore come quello con cui Philae scattava le sue foto, lasciano delle scie luminose. Ma ciò non toglie nulla alla poesia e alla struggente bellezza di quell’immagine: è la superficie di un altro corpo celeste che non sia la Terra, piccolo, freddo e distante, è una foto che proviene da più di 400 milioni di km di distanza dal nostro pianeta. I nostri corpi sono piccoli e fragili, le nostre vite brevi, e i nostri sensi limitati. Ma grazie al nostro ingegno, e alla nostra straordinaria capacità di collaborare, siamo in grado di esplorare distanze siderali e visitare oggetti celesti lontanissimi, dai quali il nostro pianeta neppure è visibile. La commovente foto di Philae, ottenuta per di più tra infinite difficoltà, testimonia di questa nostra incredibile capacità, ed è al momento l’immagine più dettagliata che abbiamo di una cometa. Un bel salto mentale dall’astro del Vangelo di Matteo, magicamente trasformato in una Stella Cometa da Giotto.