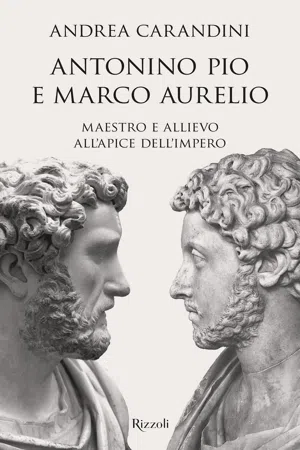A differenza dei loro predecessori, i membri della dinastia degli Antonini non hanno destinato molte risorse né speciali attenzioni alle nuove architetture e ai contesti monumentali di Roma, salvo rare eccezioni in zone di specifico interesse, connesse soprattutto al culto della famiglia imperiale nell’area centrale del Foro e nel Campo Marzio. Per questo motivo l’architettura urbana di età antonina è stata spesso ritenuta poco interessante o non originale.
Tuttavia, per valutarne opportunamente la portata, bisogna riflettere sulle necessità occorse in quegli anni di investire nella politica delle province e nel risolvere le calamità interne (Palombi 2012). Lo stesso Antonino inoltre, a quanto sembra, avrebbe stabilito di dare priorità al restauro e al completamento degli edifici pubblici già esistenti piuttosto che a intraprendere nuove imprese (Digesto, 50.10.7).
Per quanto riguarda i restauri, nel cuore di Roma Antonino è intervenuto per sanare i danni causati da eventi catastrofici come il crollo della parte superiore della gradinata lignea del Circo Massimo, che aveva causato la morte di 1112 spettatori, l’incendio che aveva distrutto il Graecostadium, oltre a ben trecentoquaranta case di Roma, e lo straripamento del Tevere (Cronografo del 354, in Valentini, Zucchetti 1940-1953, 1, p. 27; Scrittori della Storia Augusta, Vita di Antonino Pio, 9.1).
A questi si era aggiunto anche il restauro del templum novum divi Augusti, realizzato presso il Foro da Caligola in onore di Augusto divinizzato e probabilmente posto assieme a una biblioteca all’interno della piazza porticata che si può identificare con il Graecostadium, forse un mercato di schiavi (Atlas, tabb. 40-41). È possibile quindi, data la vicinanza tra i due monumenti, che il tempio sia stato restaurato da Antonino a seguito dello stesso incendio ricordato dalle fonti che aveva coinvolto il Graecostadium. Alle sei colonne già esistenti sulla fronte Antonino ne ha aggiunte altre due, ottenendo così un tempio ottastilo, come compare sulle emissioni monetali del 158-159 d.C. e sul frammento 18e della Forma Urbis severiana che forse lo riproduce. Anche il Colosseo e alcuni ponti sul Tevere (di Agrippa, Cestio e Sublicio), oltre alle sue ripae, rientrano tra i restauri attribuiti ad Antonino Pio, sempre molto attento alle infrastrutture urbane in tutto l’impero (vedi Contesti/monumenti, 4 e 6).
Venendo poi al completamento di progetti altrui, molti – e imponenti – sono i lavori che lo stesso Adriano aveva intrapreso e che non era riuscito a completare, o che aveva progettato in vista della sua morte (e successiva divinizzazione). Tra tutti il Pantheon, l’Hadrianeum a lui stesso dedicato e il mausoleo che ne avrebbe accolto le spoglie.
L’attuale aspetto del Pantheon corrisponde al rifacimento di età medio-imperiale del tempio di età augustea realizzato, con la medesima forma, da Agrippa nel luogo ritenuto sede dell’apoteosi di Romolo e della sua assimilazione a Quirino (vedi oltre). Altrove (Carandini, Papi 2019, Monumento 9, tav. 10 e bibl. precedente) abbiamo già spiegato come il progetto di riedificazione del primo Pantheon e gran parte della sua realizzazione, comunemente associati ad Adriano, siano invece da anticipare al principato di Traiano, probabilmente grazie al contributo del noto architetto Apollodoro di Damasco. I laterizi bollati impiegati nella costruzione ne confermano questa cronologia (Hetland 2015). Adriano, e anche Antonino dopo di lui, si sarebbero limitati solo a qualche restauro del tempio, che le fonti antiche attribuiscono loro utilizzando il medesimo verbo – instauravit – senza fornire ulteriori dettagli (Scrittori della Storia Augusta, Vita di Adriano, 19.9 e Vita di Antonino Pio, 8.2).
Da circa dieci anni Adriano aveva iniziato la costruzione del suo grandioso mausoleo sulla sponda destra del Tevere, ma alla sua morte, avvenuta a Baia nel 138 d.C., questo non era ancora pronto per accoglierne le spoglie mortali (Scrittori della Storia Augusta, Vita di Adriano, 19.11). Antonino si è da subito adoperato per far divinizzare il padre adottivo – operazione non scontata, visti i malumori del senato che negli ultimi tempi aveva subito gli atteggiamenti assolutistici di Adriano (Scrittori della Storia Augusta, Vita di Adriano, 27.2-3; Eutropio, Storia di Roma, 8.7.3; Cassio Dione, Storia Romana, 70.1.2-3) – e per completare il monumento funebre che ne avrebbe accolto la salma al suo rientro a Roma. Dopo un solo anno (nel 139 d.C.) il mausoleo era pronto e Adriano, nel frattempo ospitato a Pozzuoli (vedi Contesti/monumenti, 4), vi poté finalmente trovare riposo all’interno di un colossale sarcofago di porfido rosso come forse lui stesso aveva previsto (Carandini, Papi 2019, Monumenti 12-13, tav. 13a-b). Accanto a lui era la moglie Vibia Sabina e più tardi vi saranno sepolti lo stesso Antonino Pio e gli altri Antonini (CIL, VI, 984, 986, 992).
Nel 141 d.C. Antonino ha completato anche il grandioso tempio a due celle votato da Adriano il 21 aprile del 121 d.C. e dedicato a Roma e Venere sulla Velia (Carandini, Papi 2019, Monumento 20, tav. 18 con bibl. precedente). L’evento è stato immortalato con la coniazione di monete (Roman Imperial Coinage, III, 622) che raffigurano il fronte a dieci colonne (decastilo) del monumento, privo delle ulteriori colonne ai suoi lati sormontate da statue (forse di Adriano e Sabina) e delle due statue antistanti le colonne più esterne del pronao, come compariva invece sui sesterzi coniati sotto Adriano. Davanti al tempio furono inoltre posti i simulacri argentei di Marco Aurelio e della moglie Faustina, presso cui le coppie di giovani sposi facevano offerte nel giorno del loro matrimonio (vedi pp. 61-62 e fig. 9).
Più incisivo è stato invece l’intervento di Antonino, quale erede di Adriano, nell’edificare il tempio dedicato a lui divinizzato assieme alla moglie Sabina: l’Hadrianeum o templum Hadriani (vedi oltre).
Molti sono poi gli interventi che riguardano i primordia urbis, soprattutto quelli del 148 d.C., anno in cui ricorrevano i novecento anni dalla fondazione di Roma (ab urbe condita). Già a partire dal 139 si assiste alla coniazione di monete con raffigurazione di temi legati alle origini, come Anchise, Enea, i Penati, Romolo trionfatore o la grotta del Lupercal, forse restaurata in quegli stessi anni (Palombi 2012 e 2017, p. 78). Antonino aveva anche rifatto integralmente il Tempio di Vesta nel Foro (Caprioli 2007, pp. 290-292), rinnovando, forse in quel momento, il culto civico di Roma, al quale aveva aggiunto il cerimoniale legato al serpente sacro a Giunone Sospita, qui trasferito da Lanuvio (vedi Contesti/monumenti, 2 e fig. 17).
Nelle proprietà private e pubbliche appartenute alla famiglia imperiale e dislocate in varie zone della città troviamo infine nuove decorazioni e arredi databili nell’età degli Antonini. Così, per esempio, nella domus sulla sommità della Velia, identificata con la residenza del prefetto urbano, dove a età antonina si datano rifacimenti strutturali nella zona del ninfeo e nuove statue, tra cui una loricata di Antonino Pio e alcune di divinità: una Ninfa o Venere con conchiglia, una Artemide, un Apollo di cui si conserva la testa coronata di alloro e un Silvano coronato di pino (Fraioli 2017, p. 296; Carandini, Papi 2019, Monumento 19, tav. 18).
Negli horti dell’Esquilino (originariamente appartenuti alla gens Lollia) era invece il quartiere dove Adriano aveva previsto le residenze per le donne della casa imperiale. Qui, in una ricca domus rinvenuta nei pressi della Stazione Termini, hanno abitato anche Marco Aurelio e Faustina Minore assieme alla figlia Vibia Aurelia, come proverebbero i nomi impressi sulle fistulae che vi distribuivano l’acqua e la statua di Faustina Maggiore realizzata nel settore termale intorno al 160 d.C. (Carandini, Papi 2019, pp. 105-107, tav. 4b).
Ancora sull’Esquilino, negli horti che erano appartenuti a Mecenate e passati poi nella proprietà imperiale, era la casa che ospitava a Roma, già sotto Adriano, il retore Frontone, dal quale il giovane Marco Aurelio si recava per partecipare alle lezioni che qui venivano impartite (tavv. 2-3). È lo stesso Frontone nella sua corrispondenza a parlarci della sua dimora, dotata di balneum, e delle persone che lì lo frequentavano. Il tragitto che Marco percorreva, dalla sua residenza presso la domus Tiberiana fino a quella di Frontone, era di circa un chilometro e mezzo e costeggiava il Tempio di Venere e Roma e il Colosseo, prima di salire verso l’Esquilino.
La domus Tiberiana era l’abitazione palatina destinata ad accogliere i Cesari prima della loro nomina imperiale e quindi secondaria rispetto alla vicina domus Augustiana (tav. 7), la residenza ufficiale dove invece si trasferivano in seguito. Verrà equiparata a essa solo alla morte di Antonino, quando Marco si trasferisce a sua volta nella domus Augustiana, mentre Lucio Vero vi è rimasto ad abitare anche da princeps, realizzandovi tra l’altro un proprio giardino a forma di ippodromo per far correre il suo amato «cavallo alato» Volucer (Atlas, tab. 79).
Si tratta di un’articolata architettura residenziale, posta nella metà occidentale del Palatino con vista sul Campidoglio ed estesa tra la Nova via a nord e il Santuario della Magna Mater a sud, che si imposta su un sistema di imponenti sostruzioni voltate che raggiungono a nord sei livelli (Atlas, tabb. 76-80). All’interno della casa era ospitata la bibliotheca domus Tiberianae (vedi Contesti/monumenti, 7), in cui era stato alloggiato Aulo Gellio e dove erano contenuti i preziosi libri del medico Galeno (Methodus medendi, 1.1; Scrittori della Storia Augusta, Vita di Antonino Pio, 10.4), oggi identificata nel settore inserito all’interno della chiesa di Santa Maria Antiqua. Alcuni ambienti della domus Tiberiana, tra i quali anche la bibliotheca, andarono bruciati a causa di un incendio avvenuto durante il regno di Commodo, ma la struttura continuò a essere abitata anche nei secoli successivi fino a diventare la residenza di papa Giovanni VII nell’VIII secolo d.C. (Augenti 1996, p. 58).
Bibliografia principale
A. Augenti, Il Palatino nel Medioevo. Archeologia e topografia (secoli VI-XIII), in Bullettino della Commissione archeologica Comunale di Roma, Supplemento 4, Roma 1996.
D. Bruno, Region X. Palatium, in A. Carandini (ed.), The Atlas of Ancient Rome. Biography and Portraits of the City, I-II, Princeton 2017, pp. 215-280.
F. Caprioli, Vesta Aeterna. L’Aedes Vestae e la sua decorazione architettonica, Roma 2007.
A. Carandini, E. Papi, Adriano. Roma e Atene, Milano 2019.
M.T. D’Alessio, Region IX. Circus Flaminius, in A. Carandini (ed.), The Atlas of Ancient Rome. Biography and Portraits of the City, I-II, Princeton 2017, pp. 493-541.
M.G. Filetici, M. Serlorenzi, R. Palombella, L. Traini, Il restauro della Domus Tiberiana e la nuova piattaforma di raccolta ed elaborazione dei dati scientifici SITAR, in M. Serlorenzi, G. Leoni (a cura di), Il SITAR nella Rete della ricerca italiana. Verso la conoscenza archeologica condivisa, Atti del III Convegno (Roma, Museo Nazionale Romano, 23-24 maggio 2013), in Archeologia e Calcolatori, Supplemento 7, Sesto Fiorentino 2015, pp. 253-270.
F. Fraioli, Region IV. Templum Pacis, in A. Carandini (ed.), The Atlas of Ancient Rome. Biography and Portraits of the City, I-II, Princeton 2017, pp. 281-306.
L. Hetland, New Perspectives on the Dating of the Pantheon, in T.A. Marder, M. Wilson Jones (eds.), The Pantheon. From Antiquity to the Present, Cambridge 2015.
D. Palombi, Da Traiano a Marco Aurelio: la belle époque di Roma imperiale, in E. La Rocca, C. Parisi Presicce (a cura di), L’età dell’equilibrio, 98-180 d.C. Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, Catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini 4 ottobre 2012 – 05 maggio 2013), Roma 2012, pp. 35-43.
D. Palombi, Antoninus Pius and Rome: sobrius, parcus, parum largiens, in C. Michels, P.F. Mittag (Hrsg.), Jenseits des Narrativs. Antoninus Pius in den nicht-literarischen Quellen, Stuttgart...