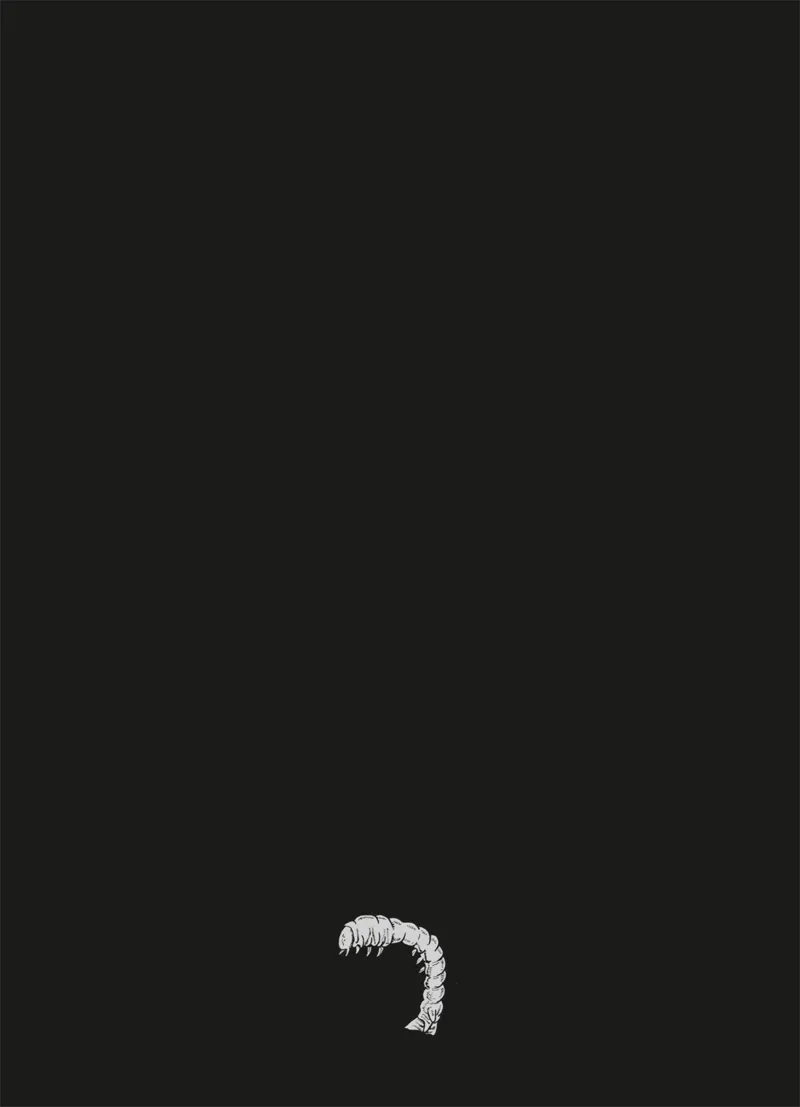Oggi ho fatto bene i conti, è un anno che sono qui, l’estate sta per finire ma ancora fa caldo, sudo nella salita e guardo il cielo privo di nuvole. Un anno, mi ripeto in testa, camminando verso il borgo. Arrivo davanti alla recinzione della comunità, apro il cancello, percorro una decina di metri e sento delle urla, gente che scappa: appare il motivo della confusione. Avanza verso di me, correndo. Raggiungo il cancello, ma è troppo tardi. Un porco, enorme, mi ha già dribblato, guadagna l’uscita, ma si trascina dietro una corda, come la coda di una cometa. Ne afferro l’estremità d’istinto e finisco a terra con un balzo strano, rallentato. Fra le mani ho il fuoco.
«È la quarta volta che ci frega» strilla il direttore della comunità, che arriva trafelato. Mi porge la mano, l’afferro e mi rialzo. Farfuglio qualche scusa.
«Non ti sentire in colpa, Nì, ce l’avrebbe fatta comunque, in un modo o in un altro. È indiavolato. È la quarta volta che me la fa…»
Mi racconta che il porco ha cinque anni e per quattro anni, alla fine di ogni estate, hanno provato a castrarlo per farlo arrivare bello grasso all’inverno e alla macellazione. Ma non c’è mai stato verso, è sempre scappato. «Questa è la quarta, grazie a te» puntualizza. Abbasso lo sguardo, fingendo di ripulirmi dalla polvere per nascondere il mio compiacimento, la mia complicità involontaria non mi dispiace affatto. «Ma stavolta qualcosa ci ha rimesso» continua, lui, ridacchiando e senza darmi spiegazione.
«È un diavolo» ripetono un po’ tutti durante il pranzo e poi, nel pomeriggio, durante il tempo in cui do una mano in comunità, fra stalle, porcilaie, ovili e campi. E anche la sera, a cena, sento i racconti sulla furbizia del maiale che ho fatto scappare: di come riesce ad aprire e chiudere i chiavistelli delle porte e a nascondersi nelle porcilaie altrui, fregarsi il mangiare degli altri suini e filarsela senza che i padroni se ne accorgano. O di quante volte durante i violenti temporali gli abitanti del borgo se lo trovano infilato sotto i letti, cacciandolo senza capire da dove sia riuscito a entrare.
È già buio quando torno verso casa. In cielo luccica un brandello di luna e devo aiutarmi con una pila per seguire il sentiero nel bosco. Ci riesco per un po’, poi non trovo più i miei punti di riferimento. Non incontro la roccia dalla vaga forma d’orso, il pino percorso dal taglio a spirale di un fulmine. I piedi mi finiscono nell’acqua di un ruscello che non dovrebbe esserci. Ecco, mi sono perso. Faccio la cosa sbagliata: cammino a caso, avanti e indietro. Un grido, spaventoso, mi blocca. Un’ombra gigantesca mi passa davanti come in volo, fermandosi a pochi centimetri dal mio volto e rimbalzando indietro di scatto. La pila mi sfugge di mano. Scappo, corro, cado, mi rialzo, ricado… Rami bassi, cespugli sconosciuti, spine. Sanguino, lo sento. Incespico e cado, sono di nuovo in piedi, sono di nuovo a terra, sempre più perso.
La corsa si ferma contro un tronco che per fortuna dev’essere morto perché crolla sotto il mio urto, ma basta a intontirmi e mandarmi a terra. Ci metto un po’ a rialzarmi, il mondo mi gira in testa.
Mi muovo nel buio per un po’, poi noto un tenue fascio di luce. Può essere solo la pila che mi è sfuggita di mano, e significa che sono tornato nello stesso punto da dove è cominciata la mia fuga. Mi blocco ripensando all’ombra di prima. Le gambe sono incerte, ma il cervello ora è lucido. Se la cosa che mi è saltata addosso si trova ancora qua, per me non ci sarà scampo. Inutile fuggire. Respiro profondamente. A lungo. Recupero la pila e con decisione la punto intorno. Il fiato mi si blocca in gola. La cosa è qui. Due occhi demoniaci mi osservano con odio bestiale. È il porco in fuga, sta vicino al tronco di un albero, ansima.
Mi fissa, scatta in avanti. Non ho la forza di muovermi. Chiudo gli occhi, stringo le braccia al petto e incasso la testa pronto al peggio. Ma non succede nulla. Rilasso le palpebre, le apro leggermente. Il maiale è di nuovo immobile. Osservo bene. C’è ancora la corda, è legata alla zampa e deve essersi impigliata all’albero durante la fuga; la bestia ha girato intorno al tronco nel tentativo di liberarsi, finendo per rimanere legata ancor di più. Mi accorgo che non gli rimangono che un paio di metri di corda liberi, e quando carica di nuovo non chiudo gli occhi: sento lo schiocco secco della corda, vedo il corpo della bestia rinculare violentemente all’indietro, strattonato con forza: un volo a mezz’aria e la caduta a terra. Spalanca la bocca, ringhia. Le lunghe zanne laterali schiumano una saliva densa e bianca. Il maiale fa un altro giro attorno all’albero, riducendo ancor di più la sua libertà. Rimango seduto a terra, con gli occhi fissi su di lui, poi la stanchezza e lo choc hanno il sopravvento.
La luce del giorno ci trova entrambi nelle stesse posizioni.
Mi alzo, giro intorno al maiale, prendendola larga. La corda si è impigliata fra un leccio e il moncone di un altro albero che spunta per non più di cinquanta centimetri dal terreno, parallelamente al primo. Le cose devono essere andate proprio come ho pensato: il porco girando, ora in un senso ora nell’altro, ha aggrovigliato la fune in modo inestricabile. E adesso segue i miei movimenti a fauci spalancate. La corda gli stringe il piede destro, poco sopra lo zoccolo. Gli strattoni hanno lacerato la carne e il piede è ricoperto di sangue vivo. Sotto la coda, la borsa dei testicoli è nera di sangue rappreso con un taglio verticale, a dividere in due gli attributi, di colore vermiglio. Mi torna in mente quello che ha detto il direttore della comunità: «Qualcosa ci ha rimesso». C’ha rimesso che il veterinario deve essere riuscito a castrargli un testicolo prima che fuggisse.
Sarebbe un peccato che lo sforzo finisse così, penso. «No, non farò la spia» dico, guardando il porco. Non avvertirò nessuno, decido. Provo, invece, più volte, ad avvicinarmi cercando un modo per liberarlo dal groviglio, ma non appena entro nel raggio che gli lascia la corda, il maiale mi si avventa addosso, feroce.
«Non capisci?» urlo. «O forse non lo vuoi, il mio aiuto?»
Nonostante la sua reazione non mi arrendo, gli resto accanto e passo il giorno e poi la notte con lui, senza mai allontanarmi. In certi momenti mi sembra di sentire un fuoco atroce che mi parte dal piede, si ferma nei testicoli e riparte più virulento. Più di una volta arrivo a pochi centimetri dal leccio nel tentativo di sciogliere la corda, approfittando delle rare pause in cui sembra appisolarsi cerco di prenderlo alle spalle e liberarlo; ma sempre lui mi precede, svegliandosi e ringhiando, pronto ad attaccarmi.
In un’occasione credo di farcela, infliggendo alla fune un colpo potente con il coltello, ma la lama cozza contro qualcosa di metallico, l’anima della corda. Ecco perché non si è spezzata sotto i colpi del porco. L’unico modo per liberarlo resta sciogliere i nodi, ma l’impresa mi sembra ormai impossibile. Non posso avvicinarmi a lui senza che cerchi di azzannarmi.
Resiste per giorni, ruggendo e caricando senza mangiare e bere. E io con lui.
Poi crolla.
Mi sveglio, dopo aver dormito tra le foglie vicino a lui e lo trovo lungo, disteso a terra, con gli occhi chiusi. «Ti sei già arreso?» Salto in piedi e senza cautele gli vado vicino. Non si muove. «Abbandoni così?» gli grido tra i calci e gli insulti.
«Ce l’ho fatta io, non puoi mollare tu.»
Lui apre gli occhi e spalanca le fauci. La testa si solleva per un attimo, ricadendo di colpo. La mia speranza si riaccende.
Cerco la strada di casa, giro a vuoto per un paio d’ore prima d’incontrare una roccia che conosco e imboccare il sentiero giusto. Raggiungo il mio alloggio, prendo disinfettanti e bende, torno al leccio: il porco è ancora immobile. Gli ripulisco con l’alcol le incrostazioni di sangue sui testicoli, vi accosto la mano aperta. Uno si è notevolmente rimpicciolito, l’altro mi pulsa, vivo, dentro il palmo. Districo i nodi e sciolgo la corda. Libero la zampa e la disinfetto con cura. Mi siedo a guardarlo, immobile per ore.
Apro gli occhi col buio, accendo la pila e un calore mi sale immediato dallo stomaco, attraversa il torace e raggiunge la testa. Lui non c’è più. Lo chiamo, batto i piedi forte a terra, ma niente. C’è il silenzio del bosco che viene rotto dal vento fra i rami, si sente il crepitio delle foglie e poi, d’un tratto, una specie di ronzio, un bisbiglio di sussurri confusi e voci sottili. «È andato via, si è alzato ed è andato via…» mi sembra di sentire tra i tronchi e la terra.
Non è possibile, sono solo, nella notte. Ma il bosco si riempie di brusii: «Si è alzato, è andato via, ce l’hai fatta». Le parole si fanno distinte, nitide. Comincio a correre, ma la paura e le voci m’inseguono. Mi rifugio in casa, mi infilo nel letto e tiro il lenzuolo sopra la testa.
Mi alzo che il sole è già alto. Ho fame e sete: sono giorni che non mangio, non bevo, non mi lavo. Faccio le mie cose con calma, e solo dopo pranzo vado alla comunità. Sulla tavola ho trovato un biglietto che mi invita a farmi vivo con urgenza, l’avranno lasciato nei giorni che sono stato appresso al porco.
Al centro trovo una sorpresa, la comunità si sta smobilitando: ai dispensatori di quiete è arrivata una tempesta. Il direttore e alcuni membri della comunità sono stati arrestati per una storia di frodi agli aiuti comunitari per l’agricoltura. La maggior parte dei ragazzi in cura è già stata portata via. Anch’io devo andarmene, mi dicono.
Mi siedo in un angolo a riflettere, osservo l’attività frenetica che mi circonda. Sono abbastanza lucido per prendere una decisione senza pensarci troppo, o almeno così mi sembra. Vado al posto telefonico, chiamo i miei, risponde mamma, le spiego cosa accade. Le dico che non mi sento pronto per andar via, che voglio continuare in un percorso che ormai è diventato personale. Devo lottarci per mezz’ora, perché si convinca. Mi saluta fra una pioggia di raccomandazioni.
«Nì… sei sicuro?» Papà ha preso la cornetta, la sua voce è così vicina che potrei avercelo davanti.
«Fidati, pa’, forse è l’unica cosa giusta che faccio in vita mia.»
«Vengo lì, ne parliamo di persona?»
«Non c’è bisogno, i soldi che finora avete inviato al centro per la retta mensile, mandateli a mio nome, fermoposta. Non cambierà nulla… vi richiamo fra qualche giorno.
«In fondo, l’unico merito della comunità è stato quello di avermi abbandonato in mezzo al bosco, il resto l’abbiamo fatto la natura e io stesso. Posso andare avanti senza di loro» dico, e riattacco. Saluto la donna dai capelli rossi, che mi guarda con un misto di commiserazione e comprensione e torno nella mia casa fra gli alberi. Mi metto a letto senza mangiare, passo sotto le lenzuola il pomeriggio e la notte, mi alzo all’alba e mi dico che ce la faccio.
Comincio una sfida che è nuova, poggia solo su di me. A pensarci bene, la comunità rappresentava una bugia o era l’illusione di un aiuto che in realtà non c’è mai stato.
Di tanto in tanto salgo al villaggio a far provviste e telefonare a casa, il resto del tempo lo passo a girovagare fra i monti. L’estate finisce e l’autunno passa veloce. Arriva l’inverno, il freddo, la neve, vengono le feste e la solitudine mi pesa un po’, per consolarmi vado più spesso al borgo, a mangiarmi un panino, bere qualcosa e sentire la voce degli uomini.