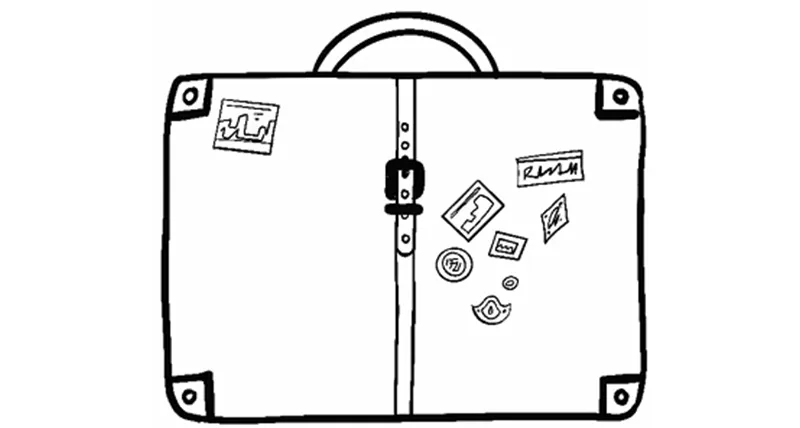![]()
![]()
Sono nato alle sei di mattina.
Appena uscito dalla pancia di mia madre, il ginecologo e l’ostetrica mi hanno guardato con uno sguardo un po’… sorpreso.
Io non sapevo cosa fosse uno sguardo sorpreso! Non sapevo cosa fosse uno sguardo. Non avevo la più pallida idea di cosa ci si potesse fare con quelle due biglie luccicanti che chiamiamo occhi. Non sapevo cosa fosse la sorpresa. Non conoscevo nessuna emozione.
Insomma, ero appena nato e tutto per me era… nuovo.
Andavo avanti con la mia vita, messa in moto da appena pochi secondi. E dormivo, con gli occhi chiusi. In quel momento era l’unica cosa che mi interessava. Avrei avuto tempo per aprire gli occhi ed esplorare il mondo.
No, non ho pianto, neanche un po’, neppure una lacrima. Sono nato pacioso. Che è una parola bellissima, secondo me. Perché significa che esprimo un sentimento di pace e di serenità.
Pacioso nel mio carattere, nella mia parte interiore. Ma bisogna fare i conti anche con la parte esteriore, con l’“aspetto fisico”. Questo l’ho imparato più avanti negli anni.
La parte esteriore non sembrava per niente paciosa. Anzi, a tanti trasmetteva un sentimento di allarme.
Ma torniamo allo sguardo sorpreso del ginecologo. Lui cercò di controllarsi. L’ostetrica, invece, per poco sveniva.
Non so che sguardo avessero i miei genitori appena mi hanno visto. Immagino che quello di mio padre sarà stato un po’ preoccupato. Ma non si sarà perso d’animo e avrà subito cercato di capire cosa bisognava fare. Lo sguardo di mia madre, invece, lo immagino carico di ammirazione e meraviglia. Mi aspettava con così tanta impazienza che qualunque cosa fosse venuta fuori dalla sua pancia l’avrebbe amata.
Però, in quel momento, si trovò di fronte a un grande, enorme, gigantesco, immenso paradosso. Difficile da accettare.
Avrebbe voluto tenermi tra le braccia.
Avrebbe voluto stare con me.
E invece non poteva.
Sono dovuto partire praticamente subito, poche ore dopo il parto.
Mi sa che non è un caso che le parole parto e partenza siano quasi uguali. Il parto è già di per sé una partenza. Io, però, sono subito ripartito.
E mentre succedeva tutto quel trambusto, tra medici allarmati e ostetriche svenute, io continuavo a dormire pacioso. Gli affanni del mondo, nel preciso e fantastico istante della mia nascita, non mi interessavano.
![]()
All’alba dell’8 gennaio 1984, il giorno dopo la mia rocambolesca nascita, siamo partiti in quattro: io, mio padre, mio zio Enrico e mia nonna Nellina.
Destinazione: Napoli.
A volte di qualcuno si dice che è nato con la camicia, il che vuol dire che è fortunato. Io invece, considerato che mi sono messo subito in viaggio, sono nato con la valigia. Il che mi fa pensare che sono stato ancora più fortunato. Magari nella valigia c’era anche una camicia!
Quel primissimo viaggio non è stato poi troppo lungo. Napoli dista solo poche ore di auto dalla città in cui sono nato.
E perché proprio la città sotto il Vesuvio?
Be’, tra le poche parole che il ginecologo era riuscito a dire c’era questa: «Esposito». Che era il nome di un medico molto bravo che operava al Policlinico di Napoli.
«Andate da lui. Io non so proprio cosa dirvi.»
Erano state queste le sue parole.
Che poi, cosa ci deve dire di così importante? Cos’è tutto questo allarmismo? Di bambini ne nascono tantissimi, ogni giorno. Cosa sta succedendo? Mi devo preoccupare?
Forse avrei fatto queste domande al medico, se avessi aperto bocca. Ma io dormivo e figuratevi se sapevo parlare dopo appena ventiquattro ore di vita.
Però facciamo un piccolo passo indietro. Ciò che posso affermare con assoluta certezza è questo: i nove mesi trascorsi nel pancione erano stati a dir poco perfetti. Superlativi. Non capisco proprio perché lì dentro ci si possa stare solo nove mesi. Ci sarei rimasto volentieri almeno qualche giorno in più!
Mia madre in quel periodo era stata molto riguardata, però non aveva rinunciato al suo lavoro di insegnante ed era andata a scuola fino all’ultimo mese. Le analisi avevano sempre detto che era tutto a posto.
Insomma, la pancia di mia madre era una casa perfetta!
Andava spesso a camminare in mezzo agli alberi e dal suo ombelico avevo avuto modo di intravedere l’azzurro del mare e sbirciare i tanti colori del mondo.
Infine, nonostante il pancione, mia madre continuava a fare sport. Correva. Era davvero una bravissima atleta. Il suo cantante preferito era (ed è ancora) Bruce Springsteen e la canzone che più ascoltava si intitola Born to Run, che non vuol dire nato con la valigia, bensì nato per correre.
Le immagini che apparivano sul monitor, a ogni ecografia, erano rassicuranti: il mio cuore batteva alla perfezione, la mia testa era bella grande e le ossa sembravano forti e ben formate. Però ciò che non si riusciva a vedere con l’ecografia era… la pelle.
Lì stava la particolarità.
È arrivato il momento di svelarlo: quando sono nato la mia pelle era per metà nera e per metà bianca. E non era una questione di etnia! Si trattava di tante macchie scure sulla mia pelle bianca.
Avete presente i cani dalmata? Ecco, una cosa del genere.
Come se qualcuno, prima che uscissi dalla pancia, avesse preso un pennello e avesse iniziato a schizzarmi con una tinta di colore scuro, indelebile. Le macchie non andavano mica via con un semplice bagnetto!
Ecco svelato il motivo di tutto quello stupore e quelle preoccupazioni.
Evidentemente, a quei tempi, la pelle bicolore non andava tanto di moda. E le macchie non erano viste di buon occhio.
E poi bisogna dare un nome alle cose. Anzi, per i medici poteva trattarsi di una malattia. Quindi non c’era molto da scherzare. Secondo l’opinione del ginecologo, a Napoli il dottor Esposito avrebbe capito di cosa si trattava.
E così mi trovai in una piccola auto a percorrere l’autostrada, mentre mia madre per precauzione doveva restare in clinica. Ci sarebbe rimasta una settimana. E per lei non fu affatto facile.
Ecco, dovete sapere che mia madre si era preparata al mio arrivo con qualche metodo alternativo. Aveva fatto yoga. Teneva vicino a sé, in ogni momento della giornata, un famoso libro di Frédérick Leboyer: Dalla luce, il bambino. Aveva imparato ad affrontare l’attesa, a trovarne il senso più profondo.
E poi? Quando è arrivato il momento della mia nascita… zap… sono subito partito e ha trascorso quei giorni lontana da me, nella stanza asettica di una clinica. Per una madre è qualcosa di terribile!
Tanti anni dopo mi confessò che per lei fu come un “vuoto di vita”. Non so esattamente cosa intendesse, però deve essere stato difficile.
Voleva raggiungermi a Napoli a tutti i costi, ma il ginecologo glielo proibiva. Doveva stare a riposo. Una tortura!
Alle sue ripetute richieste del tipo «Voglio uscire! Non ce la faccio più! Voglio vedere mio figlio!» una delle infermiere della clinica rispose: «Non c’è fretta! Avrete tempo».
Una frase bellissima, secondo me, fatta di semplicità e saggezza.
Aveva ragione! Di tempo insieme, poi, ne abbiamo trascorso tanto. E quella prima settimana di vita lontano da lei in fondo non mi pesa. Anzi, iniziavo a sentirmi autonomo. Con grande anticipo!
![]()
Ma tutto quello spavento dei medici per cosa?
Sì, va bene, c’era la mia pelle bicolore. Però c’era anche qualcos’altro.
I medici avevano notato un angioma pendulo proprio sulla testa.
Be’, non correte a indagare su internet o a comprarvi un costosissimo manuale di medicina! Non ce n’è bisogno. Con semplicità, vi racconto io di cosa si tratta.
L’angioma pendulo che avevo in testa sembrava un buffo cappellino. Avrebbero potuto scattarmi una foto e farlo passare per un gioco o uno scherzo. E invece no. L’hanno presa molto seriamente: mi hanno fasciato tutta la testa. Sembravo avvolto in un turbante e, se avessi conosciuto le differenze tra le tante culture del mondo, forse mi sarebbe venuto il dubbio di essere nato in India.
Ma niente di tutto ciò.
Dovevo essere operato senza indugi. Perché l’angioma pendulo poteva fare infezione: il buffo cappellino poteva trasformarsi in un bel guaio. Allora, con la mia piccola valigia, mi hanno spedito a Napoli.
Come vi ho già detto, il corriere è stato mio zio. Ha impacchettato me, mio padre e mia nonna in macchina e dopo quattro ore di viaggio siamo arrivati a Napoli.
Le parole del dottor Esposito furono perentorie: «Dobbiamo operarlo subito!».
E così il giorno della mia prima operazione fu fissato per martedì. Alla tenera età di tre giorni. Settantadue ore di vita!
Pensate che sia andato tutto liscio? Magari! O forse no, meglio gli imprevisti, altrimenti le storie finirebbero subito.
Martedì 10 gennaio 1984, improvvisamente, tutti gli infermieri di Napoli avevano indetto un grande sciopero. Braccia conserte! Tutto bloccato!
Avviso importante per germi, batteri, virus e ogni genere di malattia: deponete le armi, riposatevi per un giorno, la lotta è sospesa per ragioni sindacali. Avete capito?
Se scioperavano gli infermieri, dovevano farlo anche le febbri gialle, i mal di pancia e le slogature.
Quindi? Tutto rimandato a mercoledì.
Il mio quarto giorno di vita ed eccomi ancora addormentato, ma questa volta con l’anestesia.
Un’infermiera mi ha sfilato delicatamente il turbante e un bel bisturi mi ha tolto l’angioma pendulo.
Bye bye, cappellino buffo!
![]()
A Napoli mia nonna Nellina dormiva nel policlinico con me: io nella culla e lei in un letto.
Papà dormiva a casa dei suoi amici Gianni e Tina. Ho scoperto solo tanti anni dopo che erano stati gentili e affettuosi con i miei genitori in quelle giornate rocambolesche. E io che pensavo che fossero amici come tanti altri!
Mio zio Enrico, invece, era tornato a Cosenza e teneva informata mia madre. Per una settimana intera le ha urlato dalla strada, con le mani a megafono, le notizie che mi riguardavano.
Perché allora non esistevano cellulari e l’orario delle visite era ridottissimo. Quindi ci si arrangiava come si poteva. E scambiarsi le informazioni dalla finestra era tutto sommato qualcosa di normale. Per fortuna la stanza di mia madre era al secondo piano e non al quinto.
E così, grazie a questi antichi metodi di comunicazione, tutto il quartiere sapeva che era nato uno scherzo della Natura e che già dopo quattro giorni si stava facendo valere. Qualcuno di sicuro, dietro la tendina di una finestra, avrà sussurrato: «Quello crescerà con la scorza durissima».
“Quello” ero io.
![]()
Mio nonno paterno aveva un negozio di motociclette. Lo aveva aperto in città nel lontano 1946. E nel momento in cui nascevo io era il negozio di motociclette più importante di tutta la regione.
Aveva una passione così grande, mio nonno, che non chiudeva mai: la saracinesca era rimasta alzata persino il giorno in cui era nato mio padre.
Tutti lo chiamavano Don Miche’: si rivolgevano a lui con grande ammirazione e spesso lo si vedeva affaccendarsi per le vie della città in tuta da meccanico.
La sua passione per le due ruote era totale: amava anche le biciclette e gli piaceva organizzare gare.
Ho trascorso tante ore felici della mia infanzia nella sua officina, che era un luogo carico di odori e di rumori.
Ancora oggi, quando entro in una qualsiasi officina, l’odore di olio e di benzina mi fa tornare indietro nel tempo e mi sembra quasi di rivederlo, mio nonno Michele, sbucare da dietro i raggi di una ruota, con una chiave inglese ben stretta tra le mani.
Adorava il suo mestiere e scherzava sempre con gli altri meccanici, Giannino e Franco.
Franco era anche pompiere e un giorno aveva invitato me e mio padre alla stazione dei vigili del fuoco.
Avevo una grande ammirazione per lui, perché l’avevo visto lanciarsi dalla finestra di un palazzo e atterrare su un grande telone bianco. Ed era anche salito sulla lunga scala del camion fino a raggiungere il tetto di una casa.
Tornando a mio nonno, lui non chiudeva mai il negozio, ma il giorno della mia nascita, il 7 gennai...