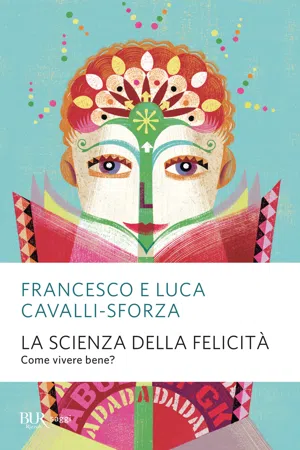Cosa ci rende felici? Ciascuno ha una visione strettamente personale della felicità. Alcuni dicono che la felicità non esiste, che è un termine ambiguo e illusorio, privo di contenuti identificabili. Altri la individuano in una vita gradevole, ricca di affetti e di soddisfazioni. C’è chi la trova nel successo, nella ricchezza o nel piacere. Qualcuno la sperimenta nella scoperta e nell’invenzione, o più in generale nel superare le sfide che lanciamo a noi stessi o che ci vengono poste nel corso della vita. Chi è provvisto di forte senso morale la troverà in un agire virtuoso. Una persona religiosa parlerà di una vita in armonia con la volontà di Dio. Qualcuno risponderà, più semplicemente, che è una risata e una tazza di tè.
Chi sta vivendo un momento intensamente felice ha difficoltà a spiegarsi a parole: si esprime piuttosto in un’attività gioiosa, come la danza, il canto, la musica, oppure nella semplice esplorazione del mondo, manifestando così il gusto di essere vivo. Il suo stato può rivelarsi contagioso, e beneficare chi gli è vicino. Questo contagio è un aspetto stupendo, cui possiamo subito affiancarne un altro: la felicità è possibile solo in condizioni di libertà interiore. È una conquista personale. Nessuno può venire obbligato a essere felice.
Se si considera la felicità un fenomeno interiore, allora la nostra volontà può riuscire a superare i fattori esterni che vi si oppongono. Naturalmente esistono limiti a quanto si può sopportare: lo stesso Giobbe ha dovuto farne esperienza. Esistono limiti anche a quanto si può essere felici?
La ricerca della felicità (la propria, certamente, ma molti di noi hanno a cuore anche la felicità altrui) è naturale negli esseri umani. È stata discussa e a più riprese teorizzata per migliaia di anni, ma è stata affermata in modo esplicito solo in epoca recente, nella Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America del 1776, che rivendica come diritti inalienabili degli esseri umani «la vita, la libertà e la ricerca della felicità».
«Sono felice» è una frase che si sente o si dice di rado, ma si vorrebbe poter pronunciare o ascoltare più spesso. Diverse ricerche sociologiche, in vari Paesi, hanno posto domande dirette sulla felicità individuale, anche se l’analisi consentita da questionari del genere è piuttosto superficiale.
I risultati sono stati piuttosto strani.1 La felicità media è risultata molto diversa in Europa, e decresce andando da nord a sud. I Paesi più «felici» includono quelli scandinavi, la Svizzera, l’Irlanda, l’Olanda, l’Inghilterra (e così pure gli Stati Uniti e il Canada), con grande distacco su quelli meno «felici»; i più bassi in classifica sono Portogallo e Grecia, mentre Francia, Italia e Spagna vanno un po’ meglio. Fra i Paesi ad alta felicità, tutti al Nord, e quelli a bassa felicità, quasi tutti al Sud, entrano con valori intermedi Belgio, Austria, Germania e Ungheria. La relazione tra felicità e latitudine è quasi perfetta, e questo lascia un po’ in dubbio sulla validità dell’osservazione, perché sembra strano che un clima peggiore predisponga alla felicità. Ma vi sono altre considerazioni importanti. Quasi tutti i Paesi del Nord Europa sono di origine germanica, e quelli del Sud in maggioranza di origine latina. Non si tratta probabilmente di differenze genetiche, quanto culturali. Un grande fattore di diversità è certamente introdotto dall’etica protestante, comune nei Paesi del Nord Europa, che a differenza dell’etica cattolica non permette di riconoscere l’insuccesso, e soprattutto di compiangere se stessi. Dirsi infelice è come confessare: «Sono un fallito».
Nei Paesi latini, invece, è facile riuscire a farsi commiserare dagli altri, almeno a parole. Di più, siamo abituati a parlare dei nostri guai quasi senza ritegno. La frase di saluto: «Come stai?», tra le più comuni in Inghilterra e in America, attende in quei Paesi una risposta che è per convenzione del tutto superficiale, mentre da noi può essere una domanda pericolosa, che riceve in risposta un elenco di tutti i guai più recenti dell’interlocutore: i problemi di salute, soprattutto, ma anche di affari, o le ultime vicissitudini sentimentali. Se è difficile che questo accada nei Paesi del Nord, dove le conversazioni iniziano parlando del tempo, è anche perché giocano differenze di costumi, e soprattutto di superstizioni. In Italia, dove è ancora forte la tradizione greca, soprattutto al Sud, si teme (più o meno inconsciamente) l’invidia degli dei, che colpiscono l’uomo felice,2 e si preferisce non proclamare ad alta voce la propria eventuale felicità.
Più simile tra i diversi Paesi è invece l’impatto economico, nella somma dei fattori che producono felicità. Si sa che la ricchezza non rende felici, ma la disponibilità di mezzi è ovunque una componente importante. Questo vale solo fino a un certo livello di reddito, però, che ricerche recenti hanno precisato tra i 60.000 e gli 80.000 euro l’anno. Al di sopra di questa cifra il denaro tende a diventare un problema, non contribuisce più a uno stato di benessere.3
Vi è un’altra differenza culturale che può avere importanza. Sta nel significato delle parole. L’italiano felice non sembra essere la traduzione esatta dell’inglese happy, del francese heureux, del tedesco glücklich e così via. Ognuno di questi termini ha un grandissimo numero di sinonimi, tra i quali se ne potrebbero trovare alcuni più simili tra le varie lingue, che sono però meno usati, oppure presentano una varietà di significati tale da rendere impossibile il confronto diretto. Tradurre è sempre un po’ tradire.
Cosa significa «felicità»? Il dizionario italiano4 la spiega come «uno stato di pieno appagamento»; in un secondo significato, come «opportunità» o «eccellente riuscita» (un’idea felice, per esempio); e ancora come sinonimo di gioia o di beatitudine. Fra i sinonimi e i termini a vario titolo affini troviamo contentezza, allegria, letizia, spensieratezza, gaiezza, piacere, soddisfazione, serenità, esaltazione, ebbrezza, giubilo, delizia, estasi, giocondità, buonumore, ilarità, godimento, gratificazione, pienezza, fortuna e altri ancora. Una bella serie di suggestioni.5
Il dizionario inglese Webster’s6 tenta una definizione approfondita di happiness: «Uno stato di benessere caratterizzato da una relativa permanenza, da emozioni prevalentemente piacevoli, che possono variare dalla semplice contentezza a una gioia di vivere intensa e profonda, e da un naturale desiderio che questo stato prosegua nel tempo».
L’italiano felicità deriva dal latino felicitas, formato a partire da felix, che significa «fertile, nutriente», con la stessa radice di fecundus, cioè «fecondo».7 In greco antico il termine equivalente era εὐδαιμονία (eudaimonìa), che indica, alla lettera, lo stato di chi è ispirato, posseduto da un buon demone, cioè da una divinità propizia; designa quindi felicità, fortuna, benessere. È interessante notare che in greco la felicità poteva essere designata anche da altri termini, fra cui uno più antico, εὐτυχία (eutychìa), che significa «buona sorte», e un altro diffuso almeno dall’età classica in poi, µακαριότης (makariòtes), che corrisponde al nostro «beatitudine», e si usava con esplicito riferimento alla divinità, nella convinzione che la felicità perfetta sia solo degli dei.8
La radice dell’inglese happiness è l’arcaico hap, nel senso di «buona sorte, colpo di fortuna». In francese, bonheur deriva dal latino imperiale bonum augurium (che le cose ti vadano bene!). In tedesco si ha glücklich (da Gluck, «fortuna»); in russo sčast’e (pronunciato «s-ciastie»), con un secondo significato di «buona sorte».
In sanscrito il concetto si esprime in una dozzina di termini diversi. Sukha designa piacere, agio, facilità, prosperità: è la felicità che deriva sia dal piacere della percezione (sentire il suono di una voce amica, ad esempio), sia dal suo superamento (chi non dipende più dalle percezioni giunge all’estinzione del dolore). Ānanda designa gioia e beatitudine. Ma vi sono molti altri vocaboli, con una gamma amplissima di significati, che vanno dal contentamento (la felicità che deriva dall’accontentarsi) alla soddisfazione per avere compiuto ciò che era da compiere, da rifugio e delizia a opulenza e successo. Vi sono anche parole per indicare la buona sorte che deriva da azioni virtuose compiute nelle vite passate, o l’eccellenza del corpo che si ottiene con la pratica dello yoga, o la felicità travolgente che deriva dall’incontro terrificante con la divinità.9
In protoindoeuropeo, l’antica lingua madre (ricostruita dai linguisti) da cui sono discese la maggior parte delle lingue parlate oggi in Europa, Persia, India, il termine equivalente era kob: «adattarsi bene, avvenire piacevolmente» (come un mozzo ben si adatta all’asse di una ruota).10
In queste lingue troviamo quindi più radici e un campo esteso di significati e di sfumature – che vanno dall’augurio di buona sorte a benessere, serenità, prosperità, fortuna – per indicare un concetto tutto sommato comune a più culture. Nella radice latina c’è anche l’idea che la felicità nutre la vita, la feconda e aiuta a stare meglio; è con questi significati che Dante Alighieri ha usato il termine felice: «pienamente appagato nei suoi desideri»; «che riesce bene in ciò che intraprende».11 In lingue come l’inglese e il francese vi è più il senso della fortuna, del caso favorevole. La differenza non è profonda, ma è chiaro che la parola «felicità» è insufficiente a definire un fenomeno assai complesso.
Il linguaggio ha una funzione eminentemente pratica. Basta sfogliare un dizionario per rendersi conto che la grande maggioranza delle parole designa oggetti concreti, e poi fenomeni, individui, attività, stati d’animo, e le rispettive caratteristiche. I termini astratti, come «amore», «ragione», «libertà», sono nel complesso pochi, e pochissimi rispetto alla totalità delle parole disponibili.
Un’attività come la navigazione genera migliaia di termini precisi e specializzati: solo per indicare tipi diversi di nodi sono disponibili decine di parole, e centinaia per nominare gli attrezzi di un’officina meccanica. Per l’amore, invece, in italiano c’è una parola sola, con alcuni sinonimi (come «affetto», «tenerezza», «trasporto») che però si aprono su campi di significato diversi, non designano più ciò che si intende specificamente con il termine «amore».12
Non vi è nulla di straordinario in questo. Il linguaggio serve prima di tutto per scambiarsi le informazioni necessarie a fare cose insieme ad altri. Lavorando in due, è difficile eseguire operazioni anche semplici senza scambiarsi qualche messaggio. Per amarsi, invece, che siano in gioco le emozioni o i sensi o entrambi, non c’è bisogno di molte parole per comunicare. Così, la libertà sarà oggetto di costituzioni e di leggi; si discuterà se una certa norma promuove o impedisce la libertà dei cittadini; potremo spiegare cosa ci fa sentire liberi o meno, ma non riusciremo a definire in assoluto cosa sia la libertà. I termini astratti non servono tanto a definire, a chiudere un campo di riferimento, quanto ad aprirlo.
Lo stesso vale per la felicità. È una parola che apre delle possibilità, non un contenitore chiuso. Altri vocaboli non potrebbero renderne ragione più di quanto non possano spiegare ciò che prova un corridore in corsa, un musicista in concerto, o due amanti nell’intimità. La felicità può solo essere scoperta, prima di incontrarla nessuno può sapere cosa sia. È una questione di esperienza, e ciascuno ne parlerà diversamente a seconda di quella che è la sua.
In che cosa consiste la felicità? Per uno psichiatra americano «è una condizione immaginaria, che in passato i vivi attribuivano ai morti, e che ora viene in genere attribuita dagli adulti ai bambini, e dai bambini agli adulti».13 La nostra esperienza è diversa. Abbiamo conosciuto persone che ci sembra giusto chiamare felici, sia adulti sia bambini. La questione non è tanto se sia possibile essere felici, quanto se sia possibile esserlo per lunghi periodi, per molti anni o anche per tutta la vita. Non è una domanda nuova: se la poneva già Aristotele, riflettendo sulla precarietà dell’esistenza, e se la sono posta molti altri prima e dopo di lui.
«L’uomo non è che incertezza. [...] prima che sia morto, bisogna aspettare e non chiamarlo felice, ma solo fortunato. [...] In ogni cosa bisogna considerare la fine, perché a molti uomini il cielo ha mostrato la felicità, per poi annichilirli.»14 Così si esprime Solone, legislatore ateniese del VI secolo a.C., spiegando al ricchissimo re di Lidia, Creso, perché non lo considera un uomo felice. Creso sul momento si indispettisce, ma ricorderà le parole di Solone dopo avere perso il suo impero ed essere stato incatenato al rogo dal vincitore, il re persiano Ciro.
Duecento anni più tardi, una considerazione analoga viene espressa da Qohèlet, l’«insegnante» del biblico Ecclesiaste: «Chi sa cosa è bene per l’uomo in questa vita, in tutti i giorni della sua vana vita che trascorre come un’ombra? Chi può dire a un uomo cosa sarà dopo di lui sotto il sole?».15
La morte è l’altra faccia della vita, e l’incertezza è una costante della condizione umana. Eppure nella storia si sono levate anche voci a negare che questi ostacoli siano insuperabili, o addirittura che siano da considerare ostacoli. In Cina, i taoisti lo affermavano già duemilacinquecento anni fa. «Dal momento che la vita e la morte sono compagne l’una dell’altra, perché preoccuparsene? Tutti gli esseri sono una cosa sola» dice Chuang Tzu.16 Buddha, contemporaneo di Solone, insegna che nascita, vita e morte sono fenomeni transitori; che l’idea stessa di un’esistenza individuale, separata da quella degli altri, è un’illusione, perché ogni singolo individuo è connesso all’intero universo in un...