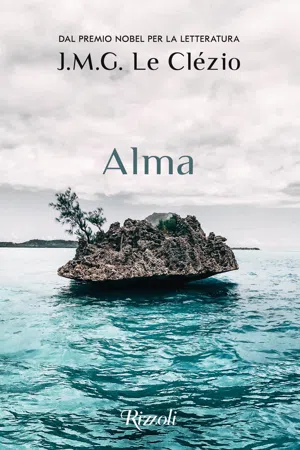Si chiama Emmeline Carcénac, ha novantaquattro anni, è l’ultima discendente di Sibylle, la figlia di Axel. Voglio incontrarla perché so che nella sua infanzia ha conosciuto mio padre, e la chiamo zia, benché nella storia della nostra famiglia sia lontana. Ha lasciato da tempo la tenuta di Alma per vivere in una casupola di legno, vicino al Mahatma Gandhi Institute. Nonostante l’età avanzata vive sola, salvo che ogni tanto divide la casa con un’altra anziana, pensionante a Bonne Terre, una certa Olga, a quanto si dice ex cantante d’opera, originaria di Pau, approdata qui dopo una vita di avventure. Dalla signora Pâtisson, la mia affittacamere a Blue Bay, ho avuto il suo indirizzo. Niente numero di telefono. Se si vuole raggiungerla bisogna chiamare la bottega cinese all’incrocio di Moka, e il signor Li manda un ragazzo in bicicletta che mezz’ora più tardi torna con la risposta. Emmeline non ha soldi, non ha conoscenze, ha rotto i ponti con tutti quelli che contano, gli Armando, i Robinet de Bosses, gli Escalier, quelli di Alma. In ogni caso, quelli della sua generazione sono tutti morti. La gente però ha la memoria lunga, si ricorda dei tempi che furono, quando Emmeline Carcénac era qualcuno. La leggenda è sopravvissuta.
Emmeline mi accoglie sulla soglia. Una vecchina in vestaglia, con lo chignon, i piedi nudi nelle ciabatte. Per la sua età sembra salda, non ha bisogno di bastone. Il viso avvizzito, cotto dal sole, sdentato, fa pensare a quello di un’indiana d’America, salvo che lei ha gli occhi di un verde torbido.
«Vieni qui, avvicinati!» Mi dà subito del tu, perché crede che apparteniamo alla stessa stirpe, o forse dà del tu a tutti, alla maniera creola. «Somiglierai a tuo padre, l’ho conosciuto bene, ti ha parlato di me?»
Non me ne ricordo. Mio padre non parlava mai del tempo di Alma. Ciò nonostante sorrido e la bacio, le mento: «Certo, zia, mi parlava spesso di voi». Le ho portato un regalo, il suo peccato veniale, mi ha confidato la signora Pâtisson, una bottiglia d’acqua di Colonia La reine des fleurs profumata di cumarina, Emmeline la respira chiudendo gli occhi. Un odore un po’ speziato, zuccherino, gli effluvi di un tempo passato.
Siamo seduti sotto il portico, più che altro una tettoia, coperta da lastre di plastica rappezzate, con dei pali di ferro dipinti di verde prato. La casa è un po’ discosta dalla strada per Moka, in un folto di tuie, dal portico si può seguire il transito di macchine e camion. Sono le undici del mattino, Emmeline va a preparare del tè al latte. Sento una forte voce d’uomo in cucina: «Chi è?».
Tornando, Emmeline commenta: «Olga, la mia pensionante, è un po’ pettegola». Si volta e grida: «Olga! Vieni che c’è mio nipote Jérémie!». Sono stupito che abbia registrato il mio nome. Forse si è informata sulla mia presenza sull’isola, questi vecchi sono come ragni, hanno tessuto la loro tela su tutto il territorio.
Olga non arriva. A quanto pare è indisposta. La signora Pâtisson mi aveva avvisato: «La sua cantante ha un caratteraccio. A volte la vecchia Emmeline e Olga restano giorni interi senza parlarsi, ciascuna a un’estremità della casa, e comunicano tramite dei bigliettini che si fanno scivolare sotto la porta».
Più affabile della sua padrona, un cagnolino grigio viene a salutarmi, e quando chiedo come si chiama Emmeline risponde: «Che ne so io, per me tutti i cani si chiamano Licien».a Potevo arrivarci!
Anche qui, su un piatto crepato, aspettano cinque napolitains rosa.
«Se ti ha parlato di me, tuo padre ti avrà senz’altro raccontato di come da bambini andassimo per i campi di canna per ore, dei veri selvaggi. Ho tre o quattro anni più di lui, sono io che lo trascinavo, andavamo a caccia di lucertole in cima alla collina, oppure dalle parti dello stagno.»
Non oso dirle che mio padre è morto da anni, anche se ha l’età in cui queste notizie non sorprendono più. Ricordo di aver guardato la cartina di Alma, pezzo per pezzo, rammento tutti i nomi dei dintorni, Circonstance, L’Avenir, Verdun, La Marre, Bar le Duc, la Dagotière. Non ho bisogno di enumerarli, Emmeline si abbandona al suo monologo. Ma al contrario di quello di Jeanne Tobie, questo è pieno d’estro e bei ricordi.
«Al tempo del taglio diventavamo matti, correvamo dappertutto, era l’odore della canna matura, ha un profumo che ai bambini fa girare la testa, allora i bambini erano ubriachi, andavano dappertutto, la fabbrica girava a pieno regime, i bambini raccoglievano le canne cadute dai camion, ogni tanto incontravamo le squadre di tagliatori, non ci degnavano nemmeno di uno sguardo, avanzavano in fila con i loro coltelli, vlan! vlan!, e noi sdraiati tra le canne come dei tènrec, avrebbero potuto tagliarci in due, ero io che davo il segnale, tiravo gli altri per la manica e ce la davamo a gambe! Fin giù al fiume, faceva così caldo che entravamo nell’acqua nera senza preoccuparci dei vestiti, anche se sapevamo che a casa ci avrebbero sgridato.»
Emmeline si dondola un po’ sulla sedia, non assaggia il tè, e io nemmeno, la sua voce è limpida e non trema, e io bevo le sue parole, perché è tutto quel che mio padre non mi ha mai raccontato, la memoria di un mondo scomparso.
«Il taglio non durava molto, in quel periodo gli operai invadevano Alma a centinaia, i camion ripartivano carichi, seminavano canne lungo le piste, i bambini le raccoglievano, e anche le vecchie del posto, facevano dei fasci che portavano sulla testa, e noi camminavamo succhiando le nostre, non ho mai mangiato niente di più buono, erano dolci e amare insieme, avevano il sapore della terra…»
Si dondola sulla sedia che scricchiola, la sua voce snocciola una litania, una preghiera. Nella cucina sento Olga rovistare, bofonchiare. Forse sta anche ascoltando, con orecchio distratto, deve aver sentito la storia cento volte, e al tempo stesso è un mondo che non può immaginare, nessuna avventura può uguagliarlo.
«Portavamo a casa le canne, le lasciavamo sulla porta della cucina, come se dovessero servire a qualcosa, credo che la domestica le desse in pasto alle mucche… Casa nostra era lontana dai campi, verso Circonstance, i cugini abitavano nei pressi della ferrovia, sulle alture, non era più Alma, era Leriche, vicino al canale, camminavamo sui binari ma il treno non circolava più da un pezzo, in alcuni punti le rotaie erano divelte… La vostra casa era più bella della nostra, tuo padre è nato lì, c’erano un sacco di fiori ovunque, rosai, e un viale di açaí, una piccola vasca, vi invidiavo, avrei voluto abitare lì, noi invece stavamo di fianco alla fabbrica, niente giardino, niente alberi, e quando iniziava il taglio la polvere dei camion cadeva dappertutto, la mamma si lamentava, incominciano, vivremo in quest’atmosfera come a Pompei, saremo sepolti dalla cenere.»
Si ferma, si asciuga gli occhi, penso che ha aspettato tutto questo tempo per parlare del passato e capisco che sta inventando, inventa la storia degli abitanti, i Carcénac, e soprattutto i Felsen, che pronuncia Fe’sen alla creola, e la storia di Alma, non per via della battaglia della guerra di Crimea, ma perché Alma era il nome della moglie di Axel, Alma Soliman, la prima donna che abbia mai abitato qui, allora andavano di moda i nomi italiani, e poi è della sua anima che parla, della sua alma mater, la sua madre nutrice. Chi altri potrebbe starla a sentire? Certamente non Olga che pensa solo a mangiare, e gli altri, gli altri non se ne curano, sono di un’epoca nuova, hanno conosciuto soltanto le strade intasate dal traffico, i centri commerciali, Carrefour, Darty, Coromandel, e adesso Maya che attira tutte queste macchine che passano davanti alla casupola di Emmeline Carcénac.
«Vedi, Jérémie, quando tuo padre è partito, ho avuto l’impressione che se ne andasse il mio fratellino. Ha promesso di scrivermi, ma arrivato in Francia ha dimenticato tutto, giusto una volta, quando mi sono sposata, mi ha spedito una cartolina, congratulation, neanche in francese, e la firma, nient’altro. Avevo il suo indirizzo, ma nemmeno io gli ho scritto. Ho pensato che fosse tutto finito. Ed è finito, dico bene? Non resta più niente di quel tempo. Mio marito è morto, ed eravamo rovinati, i miei figli sono andati a vivere altrove, uno in Francia, l’altro in Australia, tutti i miei nipoti sono altrove, in Svizzera, in Sudafrica. Studiano, vengono qui solo una volta all’anno e perlopiù vanno al mare, Moka non gli interessa, lo vedi dove sto? Telefonano al cinese, ma è solo per sapere se sono ancora viva. Per cui tu che vieni a trovarmi non hai idea, è la mia storia che riaffiora, Alma, i campi di canna, il ruscello, lo stagno, tutto quello che non esiste più, guarda cosa resta!»
Non mi fa vedere nessuna foto, niente ninnoli, la sua casa è vuota. Anche a lei ho una domanda da fare, ma non so come approcciarla. Emmeline è così anziana, così remota. Come una stella che continua a splendere anche se ha smesso di esistere. Parla di persone che non conosco, elenca dei nomi: «Sai qualcosa di Amélie Lejeune? E dei Weiss? Di Sedaine? E di Pierrette Pernoud, e delle mie zie Lejal, Cécile e Simone? Tuo padre ti parlava di queste persone? Ti parlava di me? È partito che era così giovane, un bel ragazzo, moro come te, con una barba curata e lunghi capelli romantici. Dopo ha sposato tua mamma, un’inglese di Londra, la notizia è arrivata fin qui, le ragazze erano gelose, per ripicca si sono sposate con il primo che capitava, quello che speravano in realtà era che qualcuno le portasse via da qui, da questo Paese di vipere, diceva mio padre, anch’io ero gelosa, non come loro, ma perché non mi ha mai detto niente dei suoi progetti, e l’ho scoperto dalla bocca di mia madre: sai, Alexandre, il tuo innamorato? Be’, si sposa con un’inglese, ti rendi conto?».
Ascolto le sue chiacchiere, Jeanne Tobie mi ci ha abituato, ma vorrei davvero farle la domanda, l’unica domanda che conti. Non so se ne ho il diritto, io che non sono di qui, che non conosco niente della vita sull’isola, io che vivo così lontano, al riparo delle mie certezze. Guardo il suo volto antico, la pelle incollata alle ossa del cranio, chiazzata di scuro dalla luce e dall’età.
«Ti ha raccontato di quando siamo andati al cinema insieme per la prima volta? Era appena prima che partisse, i tuoi nonni avevano lasciato Alma per trasferirsi a Rose Hill. Lui si era arruolato nell’esercito per sfuggire a questa storia, portava la sua uniforme kaki, il suo berrettino, aveva firmato l’ingaggio senza dirlo a nessuno, appena quindicenne, aveva falsificato i documenti per avere l’età legale. È entrato nel corpo coloniale, per le esercitazioni nella foresta. Abbiamo preso il treno a Curepipe, pioveva a dirotto, lui mi riparava con il suo pastrano militare. Siamo andati a vedere un film muto, Edipo re, non lo conosce più nessuno, dopo abbiamo mangiato un dolce alla pasticceria di fianco al Carnegie, poi lui mi ha riaccompagnata fino a Saint-Pierre. È stata l’ultima volta, non l’ho mai più rivisto.»
Penso che forse ho trovato un modo. Chinandomi un po’ in avanti, perché voglio che presti attenzione a quello che sto per dirle: «Zia, avete conosciuto Topsie?».
La mia domanda la sorprende, non risponde subito.
«Vuoi dire… Topsie, il vecchio Topsie che era ad Alma da sempre?»
Credo che abbia capito il senso della domanda.
«Io non me lo ricordo, mi sa che è morto prima che nascessi, ma ne parlavano tutti, quando è arrivato ad Alma e l’hanno sbarcato dalla carretta, e lui se l’è svignata tra gli alberi perché credeva che l’avrebbero mangiato.»
È un ricordo talmente antico che le contrae vagamente il viso, come se dovesse fare uno sforzo per strapparlo all’oblio.
«Sì, tutto questo me l’hanno raccontato, così come a tuo padre, e a te, Topsie appollaiato sul suo albero e la gente sotto che gli gridava: scendi, non ti mangia nessuno, niente paura, Topsie, vieni qui! Un vero e proprio acchiapparello. Ma lui era libero, era stato caricato su una nave che faceva la tratta ad Aden, e non sapendo che fare di lui l’avevano dato ai Fe’sen di Alma, è lì che ha vissuto, e quando è morto non so nemmeno dove l’abbiano seppellito, credo nel boschetto accanto alla Mare, aveva passato la vita a cacciare piccioni nella foresta, tutti parlavano di lui, faceva parte della famiglia.»
Riflette un momento e i rubinetti della memoria si aprono un altro po’: «C’erano molti neri, ad Alma, figurati che un tempo ce n’erano tanti quanti a Beau Vallon, cento o centocinquanta, ma non si chiamava ancora Alma, si chiamava Helvetia, o Saint-Pierre, non so più. Vicino a casa nostra c’era un campo, l’ho visitato con papà, un giorno mi ha fatto vedere quel che restava del vecchio campo dei neri, di fianco alla fabbrica. C’erano ancora alcune baracche, assai misere, ma adesso ci abitavano dei vecchi e delle vecchie. Risale a molto tempo fa, lo so. Non resta più niente, salvo i nomi, Camp Veleta, Camp Kafir, e le tracce nei campi, le pietre nere impilate a muraglia, le chiamano le piramidi creole, io direi piuttosto i monumenti ai martiri della piantagione».
Emmeline fa un gesto per scacciare i fantasmi.
«Noi ragazze sognavamo di andare in Europa, soprattutto a Parigi, ma rimaneva un sogno, a meno di sposare un ufficiale di marina o un borghese parigino, che però da queste parti non si vedevano spesso. Abitavamo ad Alma ma non avevamo niente a che fare con lo zuccherificio, con gli affari, papà non aveva ereditato niente, è andato tutto agli altri, a quelli di Circonstance, insomma sai già tutto, conosci i loro nomi, quanto a noi, abitavamo lì per carità, è quanto quel vecchio pirata di Armando aveva decretato, per carità, per non finire su una strada. Voi invece, il tuo papà e i tuoi nonni, abitavate in un bel posto, vicino al fiume, con tutti quei begli alberi da frutto, i manghi, i pompelmi, e la foresta di açaí, naturalmente tutto nelle mire degli Armando, i quali, quando la fabbrica è fallita, hanno sostenuto che voi non avevate alcun titolo, che la casa e gli alberi facevano parte della piantagione, e che avrebbero rilevato tutto per costruirci la casa degli amministratori, per la Lonrho, la Sugar Island, e così hanno fatto, e a quel punto a voi non è rimasto che andarvene, e perciò tuo padre si è arruolato nell’esercito, non perché fosse particolarmente patriottico, ma perché non voleva assistere allo sfascio… E vedi, anche noi ce ne siamo andati, la vita diventava impossibile, mettevano la bagassa a essiccare nel cortile, e i camion, il baccano dei camion, quando non era il taglio era l’aratura, oppure bruciavano i fusti delle canne sotto il vento e finivamo nella nebbia.»
Ci sono rimasto a lungo, da zia Emmeline. In casa sua non c’è niente, non un ricordo, non un oggetto famigliare. Mi piace, i ricordi così acquistano forza, perché diventano immaginari. Ha dato tutto alle sue nipoti, ai nipotini, ha tenuto soltanto il mobilio indispensabile, il tavolo che nessuno ha voluto, perché pesa una tonnellata, le sedie sfondate e gli utensili di cucina degli anni Quaranta, tegami senza manico, bicchieri a stelo sbreccati, piatti scompagnati. Se ne infischia: «Vedi, Jérémie, l’eredità si è compiuta, Alma non esiste più e tanto meglio così, quei castelli dei grands dimounes in fondo erano un po’ ridicoli!».
Sul cassettone, un libro rilegato in pelle nera, mangiato dal tempo e dalle termiti: L’imitazione di Gesù Cristo, nella traduzione dell’Abbé Lamennais. Mi ricordo di averlo visto anche sul comod...