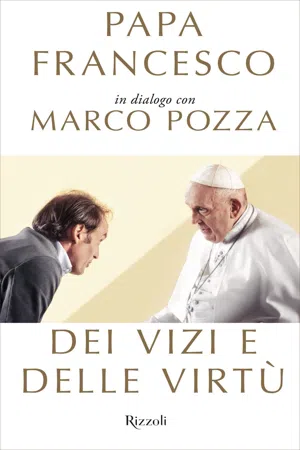La vita in comune, strutturata intorno a comunità organizzate, ha bisogno di regole di convivenza la cui libera violazione richiede una risposta adeguata. Tuttavia, viviamo in tempi nei quali, tanto da alcuni settori della politica come da parte di alcuni mezzi di comunicazione, si incita talvolta alla violenza e alla vendetta, pubblica e privata, non solo contro quanti sono responsabili di aver commesso delitti, ma anche contro coloro sui quali ricade il sospetto, fondato o meno, di aver infranto la legge.
In questo contesto, negli ultimi decenni si è diffusa la convinzione che attraverso la pena pubblica si possano risolvere i più disparati problemi sociali, come se per le più diverse malattie ci venisse raccomandata la medesima medicina. Non si tratta di fiducia in qualche funzione sociale tradizionalmente attribuita alla pena pubblica, quanto piuttosto della credenza che mediante tale pena si possano ottenere quei benefici che richiederebbero l’implementazione di un altro tipo di politica sociale, economica e di inclusione sociale.
Non si cercano soltanto capri espiatori che paghino con la loro libertà e con la loro vita per tutti i mali sociali, come era tipico nelle società primitive, ma oltre a ciò talvolta c’è la tendenza a costruire deliberatamente dei nemici: figure stereotipate, che concentrano in sé stesse tutte le caratteristiche che la società percepisce o interpreta come minacciose. I meccanismi di formazione di queste immagini sono i medesimi che, a suo tempo, permisero l’espansione delle idee razziste.
Stando così le cose, il sistema penale va oltre la sua funzione propriamente sanzionatoria e si pone sul terreno delle libertà e dei diritti delle persone, soprattutto di quelle più vulnerabili, in nome di una finalità preventiva la cui efficacia, fino ad ora, non si è potuto verificare, neppure per le pene più gravi, come la pena di morte. C’è il rischio di non conservare neppure la proporzionalità delle pene, che storicamente riflette la scala di valori tutelati dallo Stato. Si è affievolita la concezione del diritto penale come ultima ratio, come ultimo ricorso alla sanzione, limitato ai fatti più gravi contro gli interessi individuali e collettivi più degni di protezione. Si è anche affievolito il dibattito sulla sostituzione del carcere con altre sanzioni penali alternative.
In questo contesto, la missione dei giuristi non può essere altra che quella di limitare e di contenere tali tendenze. È un compito difficile, in tempi nei quali molti giudici e operatori del sistema penale devono svolgere la loro mansione sotto la pressione dei mezzi di comunicazione di massa, di alcuni politici senza scrupoli e delle pulsioni di vendetta che serpeggiano nella società. Coloro che hanno una così grande responsabilità sono chiamati a compiere il loro dovere, dal momento che il non farlo pone in pericolo vite umane, che hanno bisogno di essere curate con maggior impegno di quanto a volte non si faccia nell’espletamento delle proprie funzioni.
Crimini contro l’umanità: la schiavitù
Alcune forme di criminalità, perpetrate da privati, ledono gravemente la dignità delle persone e il bene comune. Molte di tali forme di criminalità non potrebbero mai essere commesse senza la complicità, attiva o omissiva, delle pubbliche autorità.
La schiavitù, inclusa la tratta delle persone, è riconosciuta come crimine contro l’umanità e come crimine di guerra, tanto dal diritto internazionale quanto da molte legislazioni nazionali. È un reato di lesa umanità. E, dal momento che non è possibile commettere un delitto tanto complesso come la tratta delle persone senza la complicità, con azione o omissione, degli Stati, è evidente che, quando gli sforzi per prevenire e combattere questo fenomeno non sono sufficienti, siamo di nuovo davanti a un crimine contro l’umanità. Più ancora, se accade che chi è preposto a proteggere le persone e garantire la loro libertà, invece, si rende complice di coloro che praticano il commercio di esseri umani, allora, in tali casi, gli Stati sono responsabili davanti ai loro cittadini e di fronte alla comunità internazionale.
Si può parlare di un miliardo di persone intrappolate nella povertà assoluta. Un miliardo e mezzo non hanno accesso ai servizi igienici, all’acqua potabile, all’elettricità, all’educazione elementare o al sistema sanitario e devono sopportare privazioni economiche incompatibili con una vita degna (2014 Human Development Report, UNDP). Anche se il numero totale di persone in questa situazione è diminuito in questi ultimi anni, si è incrementata la loro vulnerabilità, a causa delle accresciute difficoltà che devono affrontare per uscire da tale situazione. Ciò è dovuto alla sempre crescente quantità di persone che vivono in Paesi in conflitto. Quarantacinque milioni di persone sono state costrette a fuggire a causa di situazioni di violenza o persecuzione solo nel 2012; di queste, quindici milioni sono rifugiati, la cifra più alta in diciotto anni. Il settanta per cento di queste persone sono donne. Inoltre, si stima che nel mondo, sette su dieci tra coloro che muoiono di fame, sono donne e bambine (Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per le donne, UNIFEM).
Crimini contro l’umanità: la corruzione
La scandalosa concentrazione della ricchezza globale è possibile a causa della connivenza di responsabili della cosa pubblica con i poteri forti. La corruzione è essa stessa anche un processo di morte: quando la vita muore, c’è corruzione.
Ci sono poche cose più difficili che aprire una breccia in un cuore corrotto: «Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio» (Lc 12,21). Quando la situazione personale del corrotto diventa complicata, egli conosce tutte le scappatoie per sfuggirvi come fece l’amministratore disonesto del Vangelo (cfr. Lc 16,1-8).
Il corrotto attraversa la vita con le scorciatoie dell’opportunismo, con l’aria di chi dice: «Non sono stato io», arrivando a interiorizzare la sua maschera di uomo onesto. È un processo di interiorizzazione. Il corrotto non può accettare la critica, squalifica chi la fa, cerca di sminuire qualsiasi autorità morale che possa metterlo in discussione, non valorizza gli altri e attacca con l’insulto chiunque pensa in modo diverso. Se i rapporti di forza lo permettono, perseguita chiunque lo contraddica.
La corruzione si esprime in un’atmosfera di trionfalismo perché il corrotto si crede un vincitore. In quell’ambiente si pavoneggia per sminuire gli altri. Il corrotto non conosce la fraternità o l’amicizia, ma la complicità e l’inimicizia. Il corrotto non percepisce la sua corruzione. Accade un po’ quello che succede con l’alito cattivo: difficilmente chi lo ha se ne accorge; sono gli altri ad accorgersene e glielo devono dire. Per tale motivo difficilmente il corrotto potrà uscire dal suo stato per interno rimorso della coscienza.
La corruzione è un male più grande del peccato. Più che perdonato, questo male deve essere curato. La corruzione è diventata naturale, al punto da arrivare a costituire uno stato personale e sociale legato al costume, una pratica abituale nelle transazioni commerciali e finanziarie, negli appalti pubblici, in ogni negoziazione che coinvolga agenti dello Stato. È la vittoria delle apparenze sulla realtà e della sfacciataggine impudica sulla discrezione onorevole.
Tuttavia, il Signore non si stanca di bussare alle porte dei corrotti. La corruzione non può nulla contro la speranza.
Che cosa può fare il diritto penale contro la corruzione? Sono ormai molte le convenzioni e i trattati internazionali in materia e hanno proliferato le ipotesi di reato orientate a proteggere non tanto i cittadini, che in definitiva sono le vittime ultime – in particolare i più vulnerabili –, quanto a proteggere gli interessi degli operatori dei mercati economici e finanziari.
La sanzione penale è selettiva. È come una rete che cattura solo i pesci piccoli, mentre lascia i grandi liberi nel mare. Le forme di corruzione che bisogna perseguire con la maggior severità sono quelle che causano gravi danni sociali, sia in materia economica e sociale – come per esempio gravi frodi contro la pubblica amministrazione o l’esercizio sleale dell’amministrazione – come in qualsiasi sorta di ostacolo frapposto al funzionamento della giustizia, con l’intenzione di procurare l’impunità per le proprie malefatte o per quelle di terzi.
Appello alla responsabilità
Desidero rivolgere un invito a tutti gli studiosi del diritto penale, e a quanti, nei diversi ruoli, sono chiamati ad assolvere funzioni concernenti l’applicazione della legge penale. Tenendo presente che scopo fondamentale del diritto penale è tutelare i beni giuridici di maggiore importanza per la collettività, ogni compito e ogni incarico in questo ambito ha sempre una risonanza pubblica, un impatto sulla collettività. Questo richiede e implica al tempo stesso una più grave responsabilità per l’operatore di giustizia, in qualunque grado esso si trovi, dal giudice, al funzionario di cancelleria, all’agente della forza pubblica.
Ogni persona chiamata ad assolvere un compito in questo ambito dovrà tenere continuamente presente, da un lato, il rispetto della legge, le cui prescrizioni sono da osservare con un’attenzione e un dovere di coscienza adeguati alla gravità delle conseguenze. Dall’altro lato, occorre ricordare che la legge da sola non può mai realizzare gli scopi della funzione penale; occorre anche che la sua applicazione avvenga in vista del bene effettivo delle persone interessate. Questo adeguamento della legge alla concretezza dei casi e delle persone è un esercizio tanto essenziale quanto difficile. Affinché la funzione giudiziaria penale non diventi un meccanismo cinico e impersonale, occorrono persone equilibrate e preparate, ma soprattutto appassionate – appassionate! – della giustizia, consapevoli del grave dovere e della grande responsabilità che assolvono. Solo così la legge – ogni legge, non solo quella penale – non sarà fine a sé stessa, ma al servizio delle persone coinvolte, siano essi i responsabili dei reati o coloro che sono stati offesi. Al tempo stesso, operando come strumento di giustizia sostanziale e non solo formale, la legge penale potrà assolvere il compito di presidio reale ed efficace dei beni giuridici essenziali della collettività. E dobbiamo andare, certamente, verso una giustizia penale restaurativa.
In ogni delitto c’è una parte lesa e ci sono due legami danneggiati: quello del responsabile del fatto con la sua vittima e quello dello stesso con la società. Tra la pena e il delitto esiste una asimmetria e il compimento di un male non giustifica l’imposizione di un altro male come risposta. Si tratta di fare giustizia alla vittima, non di giustiziare l’aggressore.
Nella visione cristiana del mondo, il modello della giustizia trova perfetta incarnazione nella vita di Gesù, il quale, dopo essere stato trattato con disprezzo e addirittura con violenza che lo portò alla morte, in ultima istanza, nella sua risurrezione, porta un messaggio di pace, perdono e riconciliazione. Questi sono valori difficili da raggiungere ma necessari per la vita buona di tutti.
E per quanto riguarda la pena, bisogna pensare a fondo al modo di gestire le carceri, al modo di seminare speranza di reinserimento; e pensare se la pena è capace di portare lì questa persona; e anche l’accompagnamento a questo. E ripensare sul serio l’ergastolo, che è una pena di morte nascosta.
Le nostre società sono chiamate ad avanzare verso un modello di giustizia fondato sul dialogo, sull’incontro, perché là dove possibile siano restaurati i legami intaccati dal delitto e riparato il danno recato. Non credo che sia un’utopia, ma certo è una grande sfida. Una sfida che dobbiamo affrontare tutti se vogliamo trattare i problemi della nostra convivenza civile in modo razionale, pacifico e democratico.
La notte in galera ha orecchie potentissime. Il giorno, invece, ha occhi che sono di un’acutezza colorata: la notte porta consiglio, s’insegna ai bambini prima di una decisione da acciuffare. Magari, in carcere, la notte portasse consiglio: sta di fatto invece che al risveglio ti lascia addosso un sacco di domande. Domande agguerrite, letali, pungenti. Una sola persona, però, a cui chiedere risposta: «In Marocco, adesso, chissà cosa stanno facendo». L’uomo appollaiato alla finestra è beduino: i moreschi son gente tollerante, i beduini intransigenti. La sua terra è di quelle dove si mescolano favole e poesie, la accarezza il vento, le burrasche la attraversano come fossero coltelli: «Ogni città ha la sua medina,» dice quando si volta «ogni medina ha il suo bazar, ogni bazar ha la sua casa aperta per gli ospiti». Di notte, quand’era laggiù, amava attraversare il deserto in compagnia: «Ero giovanissimo, un ragazzo, mi affascinava il turismo: incontrare i turisti, fargli una proposta di viaggio, fargli assaporare la magia della mia terra è stato il mio lavoro per anni». Le dune di Merzouga, l’odore colorato delle pelli di Fes e Meknes, gli incantatori di serpenti nella piazza di Marrakech. Le oasi beduine, i cammelli, le notti sotto le stelle: «Quando partivano per tornarsene a casa, sentivo una forte nostalgia: iniziavo a piangere, mi accorgevo di essermi affezionato a loro».
Dall’oceano viene il vento, nel vento volano le cicogne, diceva suo nonno.
Era un beduino-viaggiatore anche lui.
Signore, apri le mie labbra.
E la mia bocca proclami la tua lode. (Invitatorio)
La peggior menzogna, qui dentro, è non esporsi, per il rischio d’incontrarsi.
Continua a guardare oltre le sbarre: anche qui le stelle suonano in cielo, la luna fa la birichina là in mezzo, l’autostrada sostituisce le rotte sulle sabbie. Le montagne, in lontananza, richiamano la catena dell’Atlante: i viaggi con il nonno, le peripezie di bambino. Le città che sono immensi laghi di luce. Qui, invece, la città è stretta, non ha vie d’uscita, è un paese lastricato di ferro e cemento, tutto chiuso ventiquattr’ore su ventiquattro: «Di notte, qui dentro, ritrovo in sogno mia figlia, la mia compagna». Fissa l’oscurità, come si fissa un qualcosa di accecante. «Non ci sono più, le ho ammazzate io.» La gelosia è figlia dell’orgoglio ma ama spargere in giro la voce di essere la sorella gemella dell’amore: ama afferrarti il collo, l’amore invece ti prende per mano. «Lei era una turista: le ho fatto da guida, mi sono innamorato follemente di lei e sono venuto qui in Italia. Con lei sono diventato padre, lei con me è diventata madre. Poi, un giorno, ho visto tuttobuio: le ho ammazzate io, tutte e due.» È l’inizio della notte, buia come il capo d’imputazione: sarà omicidio premeditato, aggravato dalla crudeltà. Mattanza di coltelli, coltellate. La galera, d’ora in avanti, non sarà più solo una condanna da espiare, ma una memoria impossibile da muovere: «Quando penso alle volte che ho poggiato la mano sul volto delle mie due donne, la vergogna sta di casa sulla mia brutta faccia». E il giovane beduino di Marrakech scopre d’essersi fatto assassino: qui la notte non porta consiglio, procura angoscia. Angoscia folle, assassina pure lei, sempre in stato di parto: «Il male è affascinante,» parla come se stesse ragionando tra sé «ma è distruttivo: il fatto è che non ti accorgi mentre lo stai vivendo. Il bene, invece, è suggestivo: te ne accorgi, però, quando sei già seduto in braccio al male». Il bene somiglia molto alle città marocchine: sono immensi laghi di luce. Per assaporarlo, però, pare necessario adocchiarlo dai laghi delle tenebre.
Qui dentro, di primo mattino, basta una scintilla di memoria a far scoppiare un incendio: «Quello che ho fatto è di un’ingiustizia folle: ho tolto la vita alla mia compagna» racconta per raccontarselo ancora una volta. «Non è bastato: l’ho tolta anche alla nostra bambina. A metterla al mondo e a cacciarla dal mondo è stato lo stesso uomo. Sono stato io.» Sono infiniti i modi di combattere, vincere: anche di seppellire, di seppellirsi. «Tante volte, da bambino, quando capitava di vedere delle preferenze dicevo: “Non è giusto”. Mi sentivo come derubato del mio diritto di essere rispettato. Poi, quel giorno, son diventato il volto dell’ingiustizia: ho ammazzato una doppia vita. Di giorno,» lo ammette non riuscendo a farne a meno «è come se arginassi questo pensiero, ma la notte me lo rigetta addosso ch’è da morire.» In carcere poche volte la notte ti dà ragione, il più delle volte la toglie: si prendono la rivincita cose che, di giorno, hai disprezzato silenziandole.
In Marocco chi non resiste si infila nel naso una foglia di menta fresca. ...