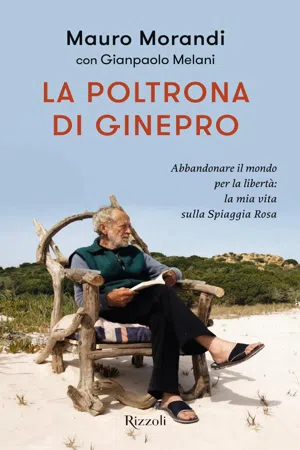1 luglio 2019
Verso la metà del pomeriggio, la canicola lascia il posto a una brezza fresca e piacevole. Al di là delle boe che delimitano Cala di Roto, il via vai delle barche è incessante. Arriva una nave che porta i turisti a fare il tour dell’arcipelago. Proviene da Palau o dalla Maddalena, ne passano una decina ogni giorno, praticamente una all’ora. Una guida sta raccontando all’altoparlante di Budelli e della spiaggia rosa. Sento la sua voce anche dalla mia veranda, talmente alto è il volume dell’impianto.
«La spiaggia rosa, immortalata dal grande regista Michelangelo Antonioni nel suo primo film a colori, Deserto rosso, con una giovanissima Monica Vitti…»
Li conosco a memoria, ormai, i loro racconti. Ogni tanto si ricordano anche di me. «Mauro Morandi, da trent’anni l’unico abitante dell’isola» gracchia ora l’altoparlante.
Mi sembra talmente lontano l’uomo che ero quando sono arrivato qui. A volte, quando ripenso al passato, ho la sensazione di avere di fronte a me un’altra persona. È tutto merito di Budelli. Essere su quest’isola vuol dire avere la possibilità di lavorare su se stessi ogni giorno, cercando di grattare via i condizionamenti che limitano la nostra percezione.
«Avrei una domanda un po’ personale» dice la donna seduta davanti a me. Stiamo parlando insieme da almeno mezz’ora. Ci siamo interrotti soltanto quando è passata la nave con l’altoparlante. Il marito è al suo fianco, ma non ha partecipato granché alla conversazione. È evidente che preferirebbe essere da un’altra parte. «Mi chiedevo se fossi credente» conclude la donna, alzando lo sguardo. Ha gli occhi verdi.
«Questa sì che è una domanda difficile» sbuffo io, appiattendomi sullo schienale della sedia di plastica. «Se la tua domanda è: “Credi nel Dio creatore della tradizione giudaico-cristiana?”, la mia risposta è no. Non posso credere nell’esistenza di un essere perfetto che permette tutte le nefandezze che accadono al mondo. Se le cose stessero come ci racconta la Chiesa, Dio dovrebbe sapere tutto quello che è e che sarà. Avrebbe quindi sempre saputo che l’uomo sarebbe arrivato a distruggere la natura, mettendo a repentaglio le basi stesse della creazione. E non capisco perché avrebbe permesso un errore del genere.»
La donna risponde come immaginavo. «La dottrina cristiana parla di libero arbitrio…»
«Al diavolo il libero arbitrio!» ribatto, un po’ ridendo e un po’ no. «Secondo me, alla base della religione cristiana c’è un errore fondamentale. Si parte dal presupposto che Dio abbia detto: “Uomo, ora puoi dominare la natura. Usala e fanne ciò che vuoi”. Si tratta di uno sbaglio madornale, a mio modo di vedere. Seguendo questo principio, l’uomo ha sfruttato la natura per i suoi scopi fino a distruggerla e arrivare al punto di non ritorno. Ecco perché non posso credere nell’esistenza di un Dio creatore: come avrebbe potuto permettere una deriva del genere?»
La donna riflette sulle mie parole. «Come dicevano i greci, l’uomo non ha il controllo sul cosmo. Ne fa parte e deve adeguarsi.»
«Sono d’accordo. Si tratta di una mentalità che è andata persa nel tempo e che, invece, dovremmo recuperare» convengo. «Sai in cosa credo? Nell’energia. Secondo la legge di Lavoisier, la somma delle masse dei reagenti è uguale alla somma delle masse dei prodotti. In altre parole, nulla si crea e nulla si distrugge. Vale anche per gli esseri umani. Siamo energia polarizzata e, quando moriremo, torneremo a partecipare all’energia universale. Diventeremo parte dell’energia del cosmo.»
L’uomo, il marito della mia interlocutrice, si alza in piedi, un po’ stizzito. Dice: «Non sono discorsi un po’ troppo da guru?».
«Sto solo rispondendo alle domande» ribatto, senza scompormi. «E detesto i guru.» La mia osservazione sembra tranquillizzare quell’uomo perché lo vedo tornare a sedersi. «Conoscete la storia di Jiddu Krishnamurti?»
Loro negano con un movimento del capo.
«Quando era adolescente, Jiddu Krishnamurti era considerato una sorta di nuovo Buddha, un “futuro maestro universale” dell’umanità. Era seguito da migliaia di discepoli, che pendevano dalle sue labbra. Eppure lui, a diciott’anni, ha detto: “Io non sono nessuno” e ha smesso di predicare. A partire da quel momento, se qualcuno andava da lui a chiedergli consigli, lui si limitava a imbastire una conversazione. Secondo il suo pensiero, è il dialogo che fa scaturire la verità. L’uomo, infatti, non deve cercare la risposta alle proprie domande tramite religioni, prediche o santoni, deve cercarla dentro se stesso. E se questa ricerca viene fatta in assenza di condizionamenti, può avere successo. Condivido le sue idee. Non esistono i guru, esistono solo gli esseri umani. Sono i condizionamenti e i pregiudizi che non ci fanno trovare le giuste risposte alle nostre domande.»
«Quindi dal tuo punto di vista tutto si riduce alla liberazione dai condizionamenti?» dice l’uomo, con un’espressione incredula disegnata sul volto.
Mi allungo sul tavolo, sopra la cerata arancione che ricopre il legno, e recupero un accendino. «E pensi sia poco? Io è da tutta la vita che cerco di liberarmi dai condizionamenti e ancora non ci sono riuscito fino in fondo. E dire che per farlo è da trent’anni che vivo su un’isola deserta…» Sorrido e accendo una sigaretta.
La nave con l’altoparlante scompare al di là degli scogli, pronta a raccontare altre curiosità dell’arcipelago a tutti quei turisti che si accontentano di un viaggio mordi-e-fuggi. Torno a pensare alla mia vita a Budelli, a quando, dopo la morte di Federico, sono rimasto veramente solo al cospetto della natura. Cercando, giorno dopo giorno, di predisporre la mente all’ascolto, senza preconcetti. Soltanto così si può aprire la porta alla bellezza del mondo. E a quella che c’è in ognuno di noi.
L’inverno dopo la morte di Federico scoprii davvero che cosa significava vivere da solo su un’isola deserta. Fino a quel momento, non l’avevo realmente percepito. Certo, capitava che io e lui non ci parlassimo né vedessimo per giorni interi, a volte settimane, soprattutto da quando aveva cominciato a passere le sue nottate sul monte Budello. Ma io sapevo che lui c’era. Era più che altro un meccanismo psicologico: se mi fosse accaduto qualcosa mentre Federico era rintanato sulla torretta non avrebbe potuto aiutarmi, così come non avrebbe potuto fare niente per me se avessi avuto un incidente in mare con il gommone. Eppure, bastava la sua presenza a non farmi sentire solo.
Me ne resi conto quando Silvana se andò, le giornate presero ad accorciarsi e io cominciai ad allestire la dispensa in vista delle burrasche invernali. Davanti alla mia collezione di scatolette mi domandai se, due anni e mezzo prima, avevo fatto la scelta giusta a restare a Budelli. Era la prima volta che lo facevo. Fino a quel momento non avevo mai messo in dubbio né la bontà della mia decisione né le mie capacità di adattamento. Scossi la testa e cercai di liberarmi da quei pensieri, ma ormai il tarlo si era insinuato nel mio cervello. Cominciò a farmi visita la sera, quando fissavo il camino scoppiettante, oppure la mattina, quando l’ululato del vento preannunciava l’ennesima giornata in cui non avrei potuto utilizzare il gommone. Con l’arrivo di dicembre e l’avvicinarsi del solstizio diventò un pensiero fisso.
Spesso ai timori per la solitudine e per la mia salute si univano i sensi di colpa per ciò che era successo a Federico. La sensazione che avrei potuto fare di più per aiutarlo mi tormentava e l’isolamento, che sempre porta con sé un sovrappiù di riflessione, ingigantiva questa idea. Se fossimo stati più intimi forse sarei stato in grado di riconoscere i sintomi della sua malattia, non li avrei considerati una semplice deriva della sua indole solitaria. Forse avrei dovuto insistere di più per farlo visitare in ospedale, forse avrei dovuto obbligarlo. Ma come potevo trascinare dal dottore contro la sua volontà un trentenne alto e aitante come lui? Eppure qualcosa dentro di me mi diceva che, se avessi davvero voluto, il modo lo avrei trovato… Erano pensieri che non conducevano da nessuna parte e che, soprattutto, non avrebbero più potuto aiutare Federico. Erano inutili e avevano come unica conseguenza quella di amplificare la mia sensazione di impotenza.
Compresi che la situazione rischiava di sfuggirmi di mano. Decisi allora, come sempre avevo fatto nei momenti decisivi della mia vita, di affidarmi ai libri. Ogni volta che sentivo l’angoscia stringermi il petto, con i pensieri che cominciavano a vorticare senza sosta, prendevo un volume dalla libreria. Fortunatamente in estate avevo fatto una buona scorta di titoli. A quel punto mi concentravo soltanto sulle parole, arrivando presto ad abbandonarmi alle storie e alle atmosfere, facendo scivolare in secondo piano tutto il resto. All’improvviso, i miei timori mi sembrarono vacui. Non si è mai davvero soli, quando si è in compagnia dei libri: come avevo potuto dimenticarmene? Ogni giorno facevo la conoscenza di un personaggio diverso e mi perdevo in avventure sempre nuove. Quando chiudevo il volume, con gli occhi stanchi dopo le ore passate davanti alle pagine, l’angoscia non tornava a farmi visita. Avevo la mente che vibrava, sollecitata da ciò che avevo letto, e io la lasciavo libera di esplorare, elaborare e reinterpretare i concetti che avevo assaporato durante la lettura, arrivando a farli miei.
Fu in quel periodo che lessi Jakob von Gunter. Un diario di Robert Walser, uno scrittore svizzero molto raffinato. Racconta la storia di un giovane di buona famiglia che se ne va di casa in contrasto con il padre e si iscrive a una scuola per maggiordomi, un luogo molto duro dove gli studenti imparano a servire e a dire sempre di sì. Vidi in quell’istituto in cui l’unico valore è l’obbedienza una perfetta metafora della nostra scuola e delle costrizioni della società: non conta ragionare con la propria testa, allenare il pensiero critico; quel che è importante è agire secondo le regole che ci hanno insegnato e nel modo che gli altri si aspettano da noi. Fu anche grazie a quel libro che ripensai alle motivazioni per cui avevo lasciato il mio lavoro, avevo acquistato il catamarano, me n’ero andato da Modena. Ed ero arrivato a Budelli. Mi trovavo esattamente nel posto in cui volevo stare, non dovevo più dimenticarlo.
Fu con spirito nuovo che mi approcciai al resto dell’inverno. Dedicai i mesi successivi alle mie passioni: oltre alla lettura, diedi molto spazio alla musica. Avevo regalato qualche tempo prima a un amico appassionato tutta la mia collezione di dischi, che non avrei avuto lo spazio di conservare a Budelli né avrei saputo come ascoltare, dal momento che in casa avevo solo una radiolina scalcagnata con il lettore cd. La resa audio era pessima, abituato all’impianto hi-fi della mia prima casa di Modena, ma era sufficiente per ascoltare il pugno di cd che avevo a disposizione.
Cominciai ad assaporare la musica in modo differente rispetto a quanto avessi fatto in precedenza, sostituendo all’ascolto quantitativo quello qualitativo. Mettevo su sempre le stesse opere, giorno dopo giorno, ora dopo ora, cercando di comprenderle in profondità, scardinando il messaggio segreto di cui le note erano portatrici. Capisaldi come Bach e Mozart, jazzisti come Coltrane, ma anche le opere moderne di Strindberg, che devono essere ascoltate più e più volte e con attenzione assoluta se si vuole dare un ordine all’apparente caos di sonorità che le regola.
Smisi così di utilizzare la parola “solitudine”, un termine negativo che sottintende la mancanza di qualcosa che non si ha, e cominciai a riferirmi alla mia condizione con “isolamento”, che invece ha un’accezione positiva ed è strettamente collegato alla condizione stessa di vivere su un’isola. Essere soli con se stessi e con i propri pensieri, scavare nelle proprie emozioni per arrivare a conoscere meglio il nostro percorso e la nostra personalità: questo per me significa “isolamento”.
Come era prevedibile, quell’inverno non successe niente di strano. Non riuscivo a capacitarmi di essermi lasciato andare allo sconforto, se non adducendo come causa lo shock provato per la scomparsa di Federico. Cullato dai miei libri, dai miei dischi e dal suono della legna che schioccava nel caminetto, arrivai alla fine di febbraio, quando le prime rondini comparvero nel cielo limpido, e mi ritrovai a pensare: “To’, già qui?”.
Mi ero riappacificato con l’inverno, ma l’inverno, incurante, portava sempre con sé qualche imprevisto. L’anno successivo, tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio, il mare fu in burrasca per quindici giorni consecutivi e la mia dispensa era sempre più vuota. Guardavo il mio piccolo e pressoché inutile frigorifero e mi dicevo che dovevo risolvere una volta per tutte il problema dell’elettricità. Era necessario installare nuovi pannelli fotovoltaici, comprare un generatore, avere più energia a disposizione in modo da poter utilizzare un frigorifero vero. Altrimenti ogni inverno sarei stato in balia del mare con il rischio di rimanere senza cibo. Il padrone dell’isola, ossia il mio datore di lavoro nonché proprietario della casa in cui vivevo, aveva già smesso di rispondere alle mie sollecitazioni e avevo il sospetto che era già molto se ancora mi arrivava lo stipendio. Ad ogni modo, quello era un altro discorso: quell’inverno dovevo arrangiarmi con il piccolo frigo che avevo a disposizione. E fare i conti con le scatolette che stavano per finire. Continuavo a guardare speranzoso l’orizzonte, invitando silenziosamente il vento a smettere di spirare.
Il sedicesimo giorno, quando mi svegliai, trovai finalmente il mare calmo. Lucido e immobile, brillava colpito dal pallido sole invernale. Non persi tempo. Corsi al telefono e chiamai il bottegaio della Maddalena. Non rispose nessuno. Guardai l’orologio: erano le sette e trenta, il negozio apriva ogni giorno alle otto, ma il proprietario arrivava quasi sempre in bottega mezz’ora prima per preparare l’inventario e sistemare la merce.
Ritentai un quarto d’ora più tardi e di nuovo non rispose nessuno. Che il bottegaio fosse malato? Strano però che in negozio non ci fosse un sostituto. Sentii l’apprensione crescere, ma mi imposi di restare calmo: il negoziante aveva sicuramente avuto un contrattempo e sarebbe arrivato a breve, non c’era bisogno di preoccuparsi.
Quando non rispose nessuno nemmeno alle otto, capii che qualcosa non andava. «Dove cacchio sei finito?» dissi al muro davanti a me. E in quel momento lo sguardo mi cadde sul calendario che era affisso su quel muro. Era il 6 di gennaio. Un maledetto festivo. Il bottegaio non rispondeva semplicemente perché il negozio era chiuso. E sarebbe stato chiuso per tutto il giorno. Mi lasciai cadere sulla sedia, continuando a fissare sconsolato il calendario. Ma non mi feci prendere dallo sconforto: il mare poteva essere calmo anche l’indomani.
Invece no. Il giorno seguente tornò la burrasca. Vento a trenta nodi. E così andò anche il giorno dopo e quello dopo e quello dopo ancora. Passai in rassegna i volti delle poche persone che conoscevo alla Maddalena e mi resi conto allarmato che non avevo il numero di telefono di nessuno, fino a quel momento avevo stretto con loro soltanto sporadici rapporti superficiali. Cominciai a centellinare le poche scatolette avanzate e andai in perlustrazione dell’isola alla ricerca di ortiche con le quali preparare delle minestre. Ogni mattina mi svegliavo di soprassalto, ansioso di uscire di casa per controllare le condizioni del mare. Era sempre mosso. A volte pensavo che la burrasca sarebbe durata per sempre, che io sarei morto di fame, tra atroci sofferenze, e che nessuno avrebbe mai trovato il mio cadavere perché nessun essere umano sarebbe mai più sbarcato a Budelli. Poi tornavo lucido e ridevo delle mie fantasie, con lo stomaco che brontolava per la fame.
Quando un mattino mi svegliai e trovai il mare calmo, mi sembrò un miraggio. Mi trascinai al telefono e chiamai il bottegaio. Lui mi rispose con voce neutra e mi disse che mi avrebbe preparato la spesa con piacere. Quando misi giù la cornetta, mi scoprii a tremare. Guardai di nuovo il mare: era ancora calmo, non soffiava un alito di vento. Allora la mia non era stata un’allucinazione, era tutto vero. Tirai un sospiro di sollievo e misi in acqua il gommone.
Erano passati venticinque giorni e in dispensa era rimasta soltanto mezza mela.
L’isolamento è una scelta di vita. L’abbracciai in maniera consapevole e consapevolmente dovevo godere dei lati positivi e subire quelli problematici. L’importante era non lasciarsi mai andare alla paura, non farla diventare terrore. Da questo punto di vista ero fortunato, forse perché alcune paure ataviche, come quella del buio o della solitudine, le avevo già esorcizzate quando ero un bambino, e ora non tornavano più a farmi visita.
Di infortuni fisici ne ebbi molti, nel corso degli anni, perché sull’isola è semplice inciampare, mettere male un piede e cadere per terra. Il mio passato di atleta mi aveva però lasciato in dote un’inaspettata abilità che mi faceva sempre mettere le mani nel modo giusto. Grazie all’istinto, evitai rotture o fratture, limitandomi a ferite di lieve entità per cui bastava un disinfettante e un cerotto.
Ciò nonostante, mi comportai spesso in modo potenzialmente pericoloso. Ma non c’era un modo diverso di vivere a Budelli, soprattutto in quei primi anni, quando non esistevano i cellulari. Me ne andavo in giro sempre da solo, in gommone o a spasso per l’isola. Mi piaceva esplorare e non pensavo mai che potesse accadermi qualcosa. R...