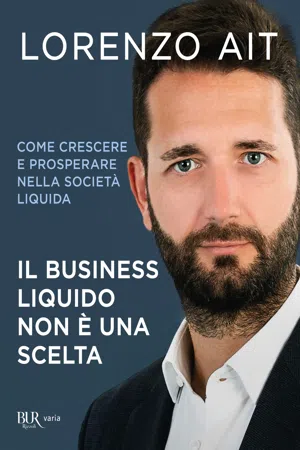Prendi il tuo telefono. Ora guardalo e dimmi cos’è.
Un telefonino?
Sbagliato, è uno smartphone. Conosci la differenza?
Ne abbiamo tutti una vaga idea, tuttavia sono pronto a scommettere che, senza cercare su Google, nessuno di noi sarebbe in grado di spiegare perché il telefono diventa smartphone. Quando è avvenuto? Proviamo a fare delle ipotesi. È stato quando si è iniziato a connettere il proprio portatile a Internet? O quando il costo della connessione è diventato sostenibile per l’uso quotidiano? Oppure quando hanno sviluppato abbastanza app da renderne frequente l’uso? Sarà stato il primo BlackBerry oppure il primo iPhone a definire questo passaggio? Te lo dico io: è stato quando Ibm ha progettato Simon. Lo so perché l’ho appena cercato su Google. Ho barato. Ho barato due volte, perché in realtà non ci serve conoscere questa informazione,1 era un pretesto per dimostrare il mio punto: e cioè che nessuno di noi ha un’idea precisa di cosa renda smart un telefono, però tutti ne possediamo uno.
Abbiamo acquistato uno smartphone, rottamando il vecchio modello. Qualcuno ha rimandato il più possibile l’investimento, altri hanno colto la palla al balzo, ma la verità è che non abbiamo mai davvero deciso di passare da un telefono cellulare a uno smartphone. La nostra scelta è stata semmai di decidere quale comportamento adottare in quanto consumatori: se comportarci da innovatori e anticipare il cambiamento, oppure subirlo. La maggior parte delle persone si trova al centro fra queste due sponde: vive il cambiamento senza anticiparlo ma lasciandosi trasportare dalla massa, dividendosi tra maggioranza precoce e maggioranza tardiva.2 Ai due estremi della curva, troviamo da una parte chi anticipa e corre dei rischi, compreso il rischio di partire prima degli altri e avvantaggiarsi; dall’altra, chi resiste fino all’ultimo, ignorando mode e masse, fino a quando si ritrova costretto a inseguire il gruppo. Il punto è che i cambiamenti della società liquida non si scelgono: puoi scegliere solo di restarne tagliato fuori per un po’, prima di adattarti. Ma ti adatterai, questo è sicuro. Del resto, abbiamo tutti un telefonino, no?
No, te l’ho detto prima: abbiamo uno smartphone. Non stai ascoltando. Ma non è grave: viviamo nella società liquida e registriamo solo le informazioni che pensiamo di poter usare.
ANORESSIA DELLA CURIOSITÀ
Se non sai che la società in cui viviamo si definisce liquida, non è una mancanza. Lo sarebbe se non vivessimo nella società liquida, ma ci viviamo, e questo significa che possiamo permetterci di ignorare le informazioni che non ci servono, finché non dobbiamo farci qualcosa. Sembra banale, ma siamo i primi esseri umani nella storia a poter godere di questo privilegio: ogni informazione è accessibile a chiunque nel tempo di una ricerca su Google. E non hai più bisogno, come in passato, di raggiungere un luogo deputato alle ricerche, per esempio una biblioteca: ti basta infilare la mano in tasca e tirar fuori lo smartphone. Questa possibilità, questo lusso, ci è stato regalato da un algoritmo, cioè da una tecnologia. Non è meraviglioso?
Quando l’industriale Henry Ford fu accusato da alcuni giornalisti di essere ignorante, li sfidò a sottoporgli qualsiasi domanda venisse loro in mente dicendo che sarebbe stato in grado di rispondere in pochi minuti. I giornalisti stilarono una lista e la consegnarono. A quel punto, Ford consultò i propri consulenti al telefono e riuscì a ottenere tutte le risposte. In seguito spiegò che la sua conoscenza derivava proprio da quelle persone: non solo il suo impero economico era fondato sulle competenze altrui, ma sfruttava anche l’effetto leva del denaro per accedere ad ancora più conoscenza. Oggi tutti godiamo degli stessi privilegi di Ford, anche senza avere i mezzi di un industriale milionario. Paradossalmente, però, il livellamento alla barriera di accesso alle informazioni ha portato a un abbassamento della soglia di cultura generale. Come mai?
Si tratta di autodifesa cognitiva: tendiamo a conoscere solo lo stretto necessario alla sopravvivenza e al piacere. In un’epoca satura di informazioni in cui, da quando ci alziamo al mattino a quando andiamo a dormire la sera, il nostro cervello è bombardato di stimoli, selezionarne l’ingresso è divenuto necessario per non impazzire. Il meccanismo è lo stesso con cui si avvia il processo di deframmentazione dell’hard disk per risparmiare spazio: noi deframmentiamo continuamente. Non abbiamo più il piacere della scoperta: questa anoressia di curiosità è una forma di difesa dalla bulimia informativa alla quale siamo esposti. Se prima dovevamo estrarre le informazioni dai libri e tirarle a fatica verso di noi (pull), ora sono loro che spingono verso il nostro cervello (push); il buttafuori all’ingresso è un filtro chiamato utilità. Abbiamo davvero bisogno di sapere cosa sia la società liquida e come ci siamo arrivati? No. Affatto. Più di ogni altra cosa, invece, abbiamo necessità di rispondere alla domanda sulla quale, da oggi fino almeno alla prossima era, si baserà tutta l’evoluzione del pensiero umano, e cioè: come la uso quest’informazione?
SAREBBERO CINQUE, MA I QUINTI NON LEGGONO
L’espressione società liquida è stata coniata dal filosofo Zygmunt Bauman per descrivere la società nella quale stiamo vivendo e che ha delle caratteristiche precise. Queste caratteristiche le conosci già, ne fai quotidianamente esperienza diretta, solo che non ti sei mai fermato a pensarle tutte insieme – non hai ancora mai provato a unire i puntini, come direbbe qualcuno.3 Ecco quello che fanno i filosofi come Bauman: uniscono i puntini meglio di altri. E siccome lo ha già fatto lui, ora a noi riesce facile. Quindi voglio fare un esperimento: facciamo qualcosa di diverso e proviamo a invertire il punto di vista. Partiamo dalle nostre esperienze e vediamo come siamo arrivati a vivere in una società liquida. Cosa ha reso e cosa tutt’ora rende liquida la nostra società? Per capirlo, forse è utile ricordarci di tutte quelle abitudini che la maggior parte di noi ha perso:
- fare chiamate brevi, perché un’interurbana costa di più;
- consultare lo stradario per sapere che strada percorrere;
- cercare una notizia sul giornale;
- aprire un dizionario;
- chiedersi che fine hanno fatto i vecchi compagni di scuola e restare nel dubbio;
- scoprire di nascosto «tutto quello che avresti voluto sapere sul sesso…» (e che oggi può scoprire senza fatica con il tuo smartphone);
- aspettare lo sviluppo delle foto per rivedere i bei momenti della vacanza;
- spedire una cartolina.
La risposta dei lettori di fronte a questo elenco è variabile: c’è chi aggiunge alla lista i ricordi delle sue abitudini perdute, chi non tollera più questo «mood nostalgia», chi lo trova banale o anacronistico e vuole sbrigarsi ad arrivare al punto e infine chi non ha dimestichezza con la maggior parte dei punti dell’elenco. Quattro umori diversi nel lettore di riferimento. Quattro macromentalità. (Tra qualche tempo si aggiungerà un ulteriore umore, o macromentalità, ma non mi illudo che il quinto gruppo legga questo libro.) Credetemi, si tratta di un unicum: per la prima volta nella storia convivono fra loro, si parlano e interagiscono quattro generazioni contemporaneamente:
- Traditional;
- Boomer;
- Generazione X;4
- Millennials.
E dobbiamo convivere tutti assieme. Questo libro parla anzitutto di come questa convivenza abbia influenzato la vita – nonché il modo di concepire il lavoro – di tutti e quattro i gruppi, e di come abbia mescolato la sfera pubblica e quella privata, trasformandole da spazi reali a rappresentazioni del reale. Siamo avatar in un gioco di simulazione. Uno, nessuno e centomila è il nostro manuale.
Okay, quest’ultima metafora era decisamente forzata, ma se avessi preso a riferimento uno scrittore più mass market, per esempio l’Orwell di 1984, l’avresti, a seconda del tuo gruppo di appartenenza, trovato banale oppure condiviso su Facebook con i tuoi amici. Entrambe reazioni che volevo evitare. Ma, soprattutto, volevo a tutti i costi trovare il modo di introdurre nel discorso l’espressione «l’avresti condiviso su Facebook», perché, quando utilizziamo questa frase, presupponiamo almeno tre cose contemporaneamente:
- oggi sappiamo tutti cosa significa;
- tre delle quattro generazioni di cui sopra sono cresciute in un mondo che non lo sapeva, un mondo in cui quella la frase non avrebbe avuto senso. Ha iniziato ad averlo da un certo punto in poi;
- per la quarta generazione la frase non ha più senso, mentre la quinta non la usa più: Facebook è ormai una roba da vecchi.
IPERSOSTITUZIONE
Potremmo stilare una classifica delle tecnologie che hanno radicalmente mutato le nostre abitudini negli ultimi dieci anni, salutate come rivoluzioni culturali e poi scomparse: in testa andrebbero probabilmente alcuni social network di prima generazione come MySpace o Friendster (il social un tempo più diffuso al mondo, con 6.529.963 utenti attivi, prima di essere sorpassato da Orkut nel 2005), seguiti dalle PlayStation (intese come tipologia e non come console specifica) e dal dvd.
E so che hai ancora il profilo Facebook e usi la PlayStation come lettore dvd, ma non significa nulla: stai usando qualcosa che hai salutato come futuro e ora conservi come vintage. Non importa se sei lento ad accorgertene: il processo di sostituzione è accelerato a ritmi vertiginosi. Così come siamo passati da Homo sapiens a Homo sapiens sapiens, per stare dietro a questo processo dobbiamo diventare Homo dolor dolor: comprare e gettare via, senza perdere tempo a usare e capire.
Non ridere. Non sto scherzando.
Potremmo facilmente proseguire, pronosticando il podio dei prossimi dieci anni: io punto tutto su blockchain, machine learning, intelligenza artificiale, computer quantistici e qualche fonte insospettata di energia alternativa.
Se penso a Bauman non posso che trovare questo modo di sintetizzare la società liquida attraverso bullet point semplicemente agghiacciante, a dir poco semplicistico e del tutto arbitrario. Trovo anche sia il modo migliore per spiegarne le peculiarità a chi ne fa parte: raccontando cioè le tecnologie che abbiamo usato, consumato e poi sostituito, per renderla possibile. Non c’è bisogno di spiegare oltre, quando si parla di tecnologie contemporanee, perché sono immediatamente fruibili senza doverle studiare. Nella società liquida, infatti, la tecnologia non è più qualcosa da ricordare con il misto di stupore e timore dei primi indigeni convertiti al Cargo cult.5 Conoscerne il funzionamento non è più necessario per padroneggiarne l’uso: ha impatto nella nostra vita, crea esperienze e questo ci basta. Ognuno conosce le proprie tecnologie e sa esattamente cosa gli portano nel concreto. Ci rapportiamo alle innovazioni in un modo inedito, e abbiamo un rapporto con la conoscenza superficiale, individuale ed egoriferito. Ma caspita se funziona! Vuoi che te lo dimostri?
Dieci anni fa dovevo sbrigarmi a parlare se chiamavo Milano da Roma, perché le telefonate interurbane costavano di più; ora videochiamo e chatto gratis tra Roma, Singapore e Sydney splittando lo schermo e condividendo file. Prima pagavo per un’esperienza scadente, ora posso scegliere tra mille alternative disponibili che mi offrono un’esperienza decisamente più appagante. Ciò che oggi uso tutti i giorni con indifferenza è una tecnologia, perlopiù gratuita, alla quale neppure l’uomo più ricco del mondo poteva avere accesso appena dieci anni fa. Le possibilità di oggi sono quasi infinite, stanno aumentando vertiginosamente e sono sempre meno costose. Come le usi tu farà tutta la differenza del mondo.
Meglio di qualsiasi lezione, nevvero? Ed è efficace, proprio perché te l’ho spiegata in termini di vantaggio/beneficio. In pratica, non ti ho spiegato la società liquida: te l’ho appena venduta.
LA MIA REALTÀ È L’UNICA CHE SPERIMENTO
Se mi chiedessero di nominare un’altra caratteristica principale della società liquida, direi che è disintermediata. Tra prodotto e consumatore non c’è più il negoziante: le merci vengono acquistate direttamente su Amazon e il cliente compila l’ordine in autonomia, senza uscire di casa. Direttamente dalla mia poltrona ordino il cibo senza farmelo consigliare dal cameriere, o consulto le recensioni sul sito senza passare dal parere del critico. L’unica realtà della quale ho esperienza è la mia realtà. In un quadro del genere aumenta, secondo le statistiche, il tasso di analfabetismo funzionale.
Un analfabeta funzionale traduce il mondo esclusivamente sulla base delle esperienze dirette e non è capace di un’analisi generale.6
Verrebbe quasi da concluderne che l’analfabetismo funzionale dipenda strettamente dalla società liquida e dal suo essere esperienziale e disintermediata. Ma se pensiamo al fatto che, solo dieci anni fa, si denunciava il pericol...