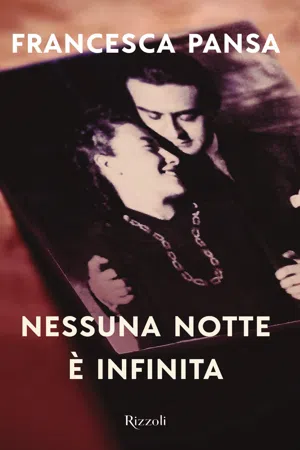![]()
![]()
A Gioconda, Rosina, Delizia, Enrichetta, Mariarosa,
Adelaide, Nice, Laura, Angelina, Nicolina, Mila,
Rina, Muzi, Cesarina, Giulia, Tiziana, Maria, Flora,
Amelia, Vittoria, Gemma, Sabella, Ornella, Teresa, Carmela,
Giovanna, Elsa, Licia, Antonia, Kiyo, Giuseppina,
Giuliana, Marianna, Gabriella, Alice, Marisa, Maddalena,
Emma, Alice, Yuki, Erina, Saida Fatima, Adriana, Emilia, Ada,
Emilia, Anna, Donata, Libera,
mamme carissime sempre accanto a noi.
![]()
Figlia di principe,
intorno a te irradi amore.
Meravigliose sono le tue carezze,
quando parli è dolcezza di miele.
![]()
Non c’era bisogno di molte parole. Mamma era stata lapidaria. In casa di zio Italino, dovete stare con due piedi in una scarpa. Mi raccomando, bambine, in una sola scarpa.
Quelle parole le sento ancora dentro di me. Quante volte, poi, sono stata costretta nella stessa condizione. Imbarazzo, rispetto, timore; o tutto insieme, mescolato in qualcosa di nuovo da conoscere e valutare.
Ma avevo quattro anni. E quella frase era suonata proprio oscura, quasi minacciosa. Che cosa aveva voluto dire mamma? Mi guardai le scarpette, di cui ero molto fiera. Un regalo di Natale di nonna. Le avevo messe solo una volta, a una festicciola di bambini, il compleanno di Francuccio, mio fratello.
Modello cartoon, ultima moda, di quelle che cominciavano a girare in quegli anni con la sorridente figurina Disney stampata al posto dei lacci.
Mia madre voleva acrobazie, che mi tenessi in equilibrio? Feci la prova. Barcollai, per poco non cadevo. Il sorriso del papero stampato sulla tela era sempre benevolo, ma mi parve con un filo di ironia in più. Come se ora ridesse anche per la mia goffaggine e ignoranza.
Due piedi in una scarpa. Papà mi spiegò che non bisognava prendere alla lettera quel consiglio così perentorio e insieme allusivo. Era un modo di dire. Affermare qualcosa, proporne qualche altra. Le scarpe non c’entravano per nulla. Era necessario stare silenziose e buone a casa di questo zio che non conoscevamo e vedevamo per la prima volta.
Tutti a Castrovillari parlavano di lui, con grande rispetto e magari con un po’ di invidia, come di un giovane del paese che si era fatto da solo. Senza chiedere nulla alla famiglia e con grandi risultati che s’ingigantivano passando di bocca in bocca. D’altronde capita spesso in simili situazioni.
Si era laureato a Roma in giurisprudenza, come gli altri fratelli maschi. Era diventato un avvocato assai conosciuto, introdotto nel mondo politico e finanziario. Qualche volta per un processo o una questione che riguardava la città e la sua amministrazione, il suo nome appariva anche sui giornali. Erano momenti di gloria per l’intera famiglia. «Guarda zio Italino» ci diceva mia madre mostrando l’ultimo foglio che parlava di lui.
Questo zio era il pupillo dei nonni di Castrovillari, nonno Ulrico e nonna Enrichetta. Ultimo di una grande famiglia, che era l’esito di due matrimoni.
Nonno Ulrico era rimasto presto vedovo con tre figli. Aveva incontrato Enrichetta Milano, maestra molto stimata a Castrovillari. Dal carattere forte, animata da una grande passione, dotata di una creatività inusuale, di idee e di energia. Tra le prime montessoriane per formazione, era approdata all’insegnamento con l’entusiasmo dei suoi vent’anni e con una (rara per l’epoca) macchina fotografica. La fotografia le piaceva moltissimo.
Una vera piccola leggenda per la tenacia, la dedizione, il modo di insegnare. Girava con un calessino per le campagne alla ricerca dei bambini che non potevano frequentare le classi elementari. Era assai difficile vincere la resistenza di quei contadini che contavano sulle piccole braccia per lavorare i campi e cercavano di fare in modo che i figli non adempiessero all’obbligo scolastico. Quanto alle femmine, non se ne parlava proprio. Dovevano restare in casa per svolgere le tre “sacre” funzioni muliebri: lavare, stirare, cucinare.
Per loro questo era l’unico futuro possibile. Lo studio era solo un ostacolo, l’impossibile traguardo.
Ma nonna non si scoraggiava, trottava per campi e vigne alla ricerca dei piccoli allievi assenti alla chiamata. Aveva imparato a conoscere ogni famiglia. I bambini non potevano raggiungere il paese, le famiglie disertavano la scuola? Ci pensava lei, andava a domicilio una volta la settimana, nella giornata di festa o di riposo. Improvvisava le sue lezioni all’aria aperta e teneva anche un diario in cui raccontava le esperienze e descriveva le sue osservazioni sul campo.
Ne ho scoperte qualche anno fa poche pagine sopravvissute a traslochi e trasferimenti vari. Sfogliandole se ne colgono in pieno la freschezza e l’originalità. La maestra comprende l’importanza di questo lavoro e mette in evidenza qual è il suo metodo pedagogico.
Di quel periodo lei conservava anche oggetti, appunti, qualche quaderno di esercizi, gli spartiti musicali e soprattutto la vecchissima macchina fotografica con cui erano stati immortalati i bambini, gli adulti, i luoghi, alcune delle sue imprese didattiche. Come le lezioni nei campi tra un casolare di campagna e un altro, tra gli ulivi e le galline che sbucavano qua e là. E tutti poi si mettevano in bella posa. Una fotografia è sempre una fotografia, non bisogna lasciarsi cogliere di sorpresa: i bambini senza grembiuli con i pantaloncini e le gonne un po’ lise. I genitori che hanno appena sospeso il lavoro nei campi, qualcuno con la zappa in mano, qualche bella nonna vecchiettina e un nonno pensieroso tutto rughe, sopra un trattore, il nume tutelare dell’intera comunità.
![]()
Nonno Ulrico veniva da una famiglia davvero illustre, di origine nobile, quelle famiglie di notabili che hanno fatto la storia del Sud. Tutti avvocati di grido, stimati in Calabria e fuori. E talora anche impegnati in politica, con una particolare sensibilità verso i diritti e le libertà civili. Uno di loro, Alfredo Attilio, era tanto amato dai suoi concittadini che gli avevano intitolato una piazza, quella del tribunale. Non solo perché era stato un “principe del foro”, come dicevano le cronache dei giornali, nei molti casi giudiziari di cui era stato protagonista. Ma anche perché era stato uno dei principali intellettuali che avevano sostenuto nei primi del Novecento la nascita e lo sviluppo del socialismo in Italia.
Con un certo orgoglio, ci capitava di passare in quella piazza centrale del paese. Sentivamo come un senso di appartenenza, un legame sottile con la storia di Castrovillari di cui anche Alfredo Attilio, amico di Bissolati, Pertini e Nenni, faceva parte, con il suo doppio nome scolpito su un marmo un po’ scolorito.
I nomi di strade e piazze hanno sempre la proprietà di far riaffiorare ricordi, impressioni, talora un senso di stupore e di estraneità, quando non conosciamo chi sia stata l’illustre persona cui sono dedicate. Ricordo con gioia quando capitai per caso in piazza Ennio Flaiano a Roma, uno scrittore che molto ho amato e che non mi è capitato di conoscere, anche se poi ho scoperto che abitava a pochi passi da casa mia, a Monte Sacro.
In quella piazza poi confluivano anche due altre strade, via Cesare Zavattini e via Gino Cervi. E io per un po’ mi sono sentita protetta da quel terzetto di fuoriclasse che il caso aveva messo uno accanto all’altro. Per un po’ mi ha accompagnato lo sguardo malinconico e saggio di Flaiano, quello eccentrico e divertito di Zavattini, quello assorto e investigativo di Cervi nei panni di Maigret, il commissario di Simenon che ebbe tanto successo in televisione.
Ricordo che piaceva molto a nonno Ulrico. Lo rivedo davanti alla tv, dove si aggirava Cervi-Maigret, con la sua immancabile pipa in bocca, il pastrano grigio, il cappello a quadri scozzesi, la sciarpa per proteggersi dall’umidità dell’inverno parigino. Nonno ricordava che Cervi la prima volta l’aveva visto al teatro: aveva portato a Cosenza, al teatro Rendano, il suo Otello, e gli aveva messo l’autografo sul programma di sala, quando nonno era andato a trovarlo nel camerino.
Nonno Ulrico era già un po’ malandato, usciva poco da casa. Gli era piaciuta soprattutto l’ultima serie di Maigret, quella in cui il commissario ormai in pensione era costretto a tornare momentaneamente a Parigi per tirare fuori dai guai il nipote poliziotto, accusato di omicidio.
«Si può sempre essere utili agli altri a ogni età» commentava l’episodio conclusivo della serie, dove Maigret, ancora sul campo a investigare, dopo aver brillantemente risolto anche l’ultima imprevista inchiesta, si godeva la nuova vita da pensionato nella sua casa di campagna stappando una bottiglia di vino di sua produzione. Forse s’identificava un po’ in quella storia, lui che aveva sempre aiutato parenti e amici e soprattutto i “bambini”, i tanti bambini che avevano fatto parte della sua vita, i suoi piccoli studenti.
Il giovane Ulrico non aveva seguito la strada legale della tradizione di famiglia. Era diventato prima maestro elementare, poi giovanissimo direttore didattico, il più giovane, si diceva, di tutta la Calabria. A scuola si fece più frequente il rapporto con la maestra Milano. Si erano subito intesi e sposati. Nonna aveva accolto con grande affetto i figli di lui. Presto la loro casa, situata sul corso del paese, si riempì di nuovi nati. In tutto cinque figli, tre maschi e due femmine.
Nonno Ulrico anche lui ha lasciato un piccolo diario in cui ha descritto le condizioni dei tanti bambini che gli è capitato di conoscere negli anni in cui è stato nella scuola. Erano gli appunti che aveva preparato quando una troupe era capitata in Calabria e a Castrovillari aveva scelto proprio lui per raccontare l’esistenza della comunità prima dell’avvento della televisione.
Ho cercato nelle teche Rai il programma, ma non c’è traccia della registrazione. Certo è che mio nonno ne parlava e gli appunti sono restati. Era stato molto preciso nel descrivere la vita tra casa e scuola. Le classi erano formate molto spesso da bambini con età diversa e con un solo maestro. Nonno Ulrico come direttore coordinava più scuole, distribuite nel territorio. Le classi erano molto numerose. Non c’erano classi miste: erano o maschili o femminili. I maestri e le maestre erano molto severi, avevano una bacchetta di legno che usavano per battere sulla cattedra e richiamare l’attenzione o il silenzio.
![]()
Ricordo i pomeriggi assolati nella grande casa dei nonni, sul corso del paese.
Da uno dei balconi, m’incanto a guardare il monte Pollino. Nonno mi dice che si chiama così perché è il monte dei giovani animali che a fine primavera vengono portati a pascolare sui prati già verdi. E pullus, mi dice ancora, in latino significa “giovane animale”, ma io non capisco bene cosa vuol dire e cosa c’entra il latino, che non so proprio cosa sia. Eppure mi piace immaginare quei prati pieni di piccole mucche, piccoli maiali, piccoli muli, quelli che ho visto nel verde della Sila, e magari anche qualche rana che zampetta nei fossati pieni di acqua stagnante.
Tra le nebbie che spesso si addensano sulla cima del monte e un po’ più giù, spuntano i pini, che quando perdono la corteccia assomigliano a esseri umani a riposo. Forse così nascono molte storie e molte favole del Pollino, spiega il nonno. Nella foschia quegli alberi assomigliano a esseri umani che si riposano, parlano, si agitano, vivono la loro vita appunto come se fossero uomini.
Un po’ più su, quel luccichio bianco che appena si vede dal mio osservatorio è un nevaio, uno dei molti nevai del monte, e in certi anni una sua piccola striscia gelata si conserva anche quando fa più caldo, il caldo che scioglie tutto.
Nonno ama raccontare una fiaba tra le altre che conosce sul Pollino. La protagonista è una bellissima Principessa delle Nevi che però è sempre stanca e affaticata e, per un sortilegio, la sua forza e ogni sua energia la deve ricavare proprio guardando, e quasi specchiandosi, nella piccola pozza bianca del suo nevaio, quello che in estate rischia di estinguersi.
Di qui tutti gli espedienti per non far spegnere la fonte preziosa che, pur essendo gelida, riesce a dare vita nuova alla principessa, la quale altrimenti rischia di addormentarsi. Di qui le tante avventure, le prove, le ricerche che ruotano intorno a lei, avventure in cui compaiono un tovagliolo magico, un bastone che si anima a comando o una fanciulla che non ride mai. Tutte ambientate tra i sentieri, i boschi, le sorgenti del Pollino, la cui cima non a caso si chiama Serra Dolcedorme e Fiore della Principessa.
Nonna non vuole che giochiamo nel cortile. Senza il nonno che ci racconta le sue favole, il tempo passa troppo lentamente. Nella casa in Sila è diverso, siamo liberi, possiamo giocare nel giardino con i cuginetti. Però anche a Castrovillari ci sono altri parenti che vengono qualche volta a trovarci. Le visite di zia Giulia sono vivacissime, parla molto, scherza con tutti. L’accompagna il figlio più piccolo, Elio, un ragazzino bellissimo e molto timido. In certi giorni questo cuginetto, che abbassa gli occhi quando parla, è una vera ancora di salvezza. Lo aspetto ogni giorno sul balcone affacciato sul Pollino. Conto i minuti, so che deve arrivare nel primo pomeriggio. Scruto la strada gettando lo sguardo dalle ampie inferriate perché non supero la ringhiera, sono piccola. E intanto, in attesa della festa, anticipo anche le delizie previste. Dallo studio di zio Pierino, chiamo il bar di fronte, proprio dove il corso si allarga un po’, con i tavolini fuori nella bella stagione, la gente che si ferma, si siede per chiacchierare con più gusto.
Io mi faccio forte e, nel nome e per conto di zio Pierino, faccio le mie ordinazioni. Voglio gelati alla crema, cioccolato, lampone, che sono la specialità della ditta. E poi, una volta la settimana, c’è una delizia davvero impagabile, il gelato al gelsomino. Sento ancora il suo profumo e il suo inconfondibile sapore che si scioglie in bocca.
Filpo, il proprietario, ha imparato a farlo perché per un certo periodo ha avuto nel bar un ragazzo di Palermo, suo...