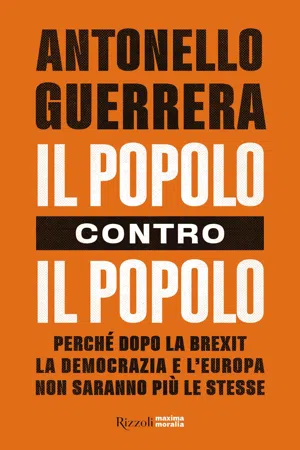C’è del marcio in Danimarca
Certo che gli articoli di Boris Johnson hanno avuto un’influenza. Johnson scrisse che se i danesi avessero votato di sì al referendum su Maastricht, avrebbero avuto molta più Europa a casa loro, molta più integrazione e così via. Quando dissi che erano tutte idiozie, mi chiamarono “maledetto bugiardo”.
Ulle Ellemann-Jensen1
David Cameron è il principale responsabile del referendum del 2016 vinto dalla Brexit. È noto: l’ex premier conservatore lo ha avallato per sedare – una volta per tutte – l’atavica e indomabile ribellione euroscettica nel suo partito conservatore, come vedremo, contando di vincere piuttosto facilmente come in quello sulla Cee nel 1975. Invece, Cameron ha clamorosamente perso e in una sola notte: da araldo dell’europeismo riformato si è tramutato nel buttafuori sdraiato dell’ultima, definitiva deriva sovranista del suo Paese.
C’è uno studio, pubblicato dall’Economist e dall’istituto di sondaggi Ipsos Mori2, che descrive come pochi altri il devastante azzardo di Cameron. Perché dimostra come, nonostante le inarrestabili gazzarre nella politica britannica e specialmente nel partito conservatore sul rapporto dei Regno Unito con l’Europa, quest’ultimo, in una serie di sondaggi effettuati dal 2006 al 2015, era considerato un serio problema per meno del 10 per cento dei britannici. Una miseria.
Quando però poi Cameron, nel giugno 2015, slega ufficialmente il rabbioso referendum sulla permanenza in Ue (con l’approvazione di tutti i partiti a parte i nazionalisti scozzesi Snp3), scatta una feroce propaganda tra i due fronti. Da quel momento, improvvisamente, per il 40 per cento dei britannici l’Europa diventa una questione urgentissima, sfondando quota 50 per cento l’anno successivo.
Uscite le sue attesissime memorie For The Record4 («Per la cronaca») nel settembre 2019, Cameron si è cosparso pubblicamente il capo di cenere in numerose interviste, attaccando però anche i suoi due più grandi «traditori»: Michael Gove, già pluriministro e oggi responsabile governativo della preparazione al No Deal, e, guarda caso, proprio Boris Johnson. Perché fu proprio il loro carismatico salto nelle tenebre della Brexit (Gove il primo temerario dei due) a rivelarsi un fattore decisivo nella vittoria degli euroscettici.
Cameron cova ancora un astio raro per Gove e per Johnson, anche perché sono tra i responsabili della morte della sua carriera, fino a quel momento stellare. Ma se riavvolgiamo il nastro di qualche anno, se torniamo alle radici di questo terremoto che ha scosso l’Occidente, forse il principale teorico e responsabile della Brexit è proprio Boris Johnson.
Boris, il biondo masaniello anti-Bruxelles, il nobile arruffapopoli isolazionista, il bizzarro sobillatore dell’euroscetticismo contemporaneo.
Per via di quell’aria guascona e scherzosa, negli anni in molti lo hanno sottovalutato o drammaticamente sminuito. Poi se ne sono pentiti. Come i colleghi giornalisti a Bruxelles che lui sfruttava copiando o edulcorando le loro notizie millantando incapacità o falsa modestia («Io premier? È più probabile che Elvis venga ritrovato su Marte o che io mi reincarni in una pianta di ulivo»5). O come Ken Livingston il «rosso», l’ex sindaco laburista di Londra, che nel 2008, contro Boris, è riuscito a perdere le elezioni della capitale nonostante un vantaggio iniziale di 17 punti nelle intenzioni di voto.
Il curioso paradosso è che, come vedremo, l’euroscetticismo sagomato da Boris Johnson, quando era un giovanissimo e ruspante corrispondente da Bruxelles per il Daily Telegraph (1989-1994), ha dilagato non solo nel Regno Unito. Le sue scorie sono infatti arrivate in altri Paesi europei, con conseguenze considerevoli.
C’è un eccezionale esempio a sostegno di questa tesi. È avvenuto in Danimarca.
Tutto nasce da uno dei tanti irriverenti, allarmisti e sensazionalistici articoli di Johnson, che ad attaccare e umiliare l’Europa nel suo cuore (Bruxelles) ci prende gusto, giorno dopo giorno. Le sue frizzanti critiche, esagerazioni, mezze bufale conquistano costantemente la prima pagina del suo giornale. In patria diventa presto il cavaliere dell’antieuropeismo e il cocco della «lady di ferro» Margaret Thatcher e del partito conservatore.
In una placida domenica del maggio 1992, il Telegraph pubblica un incendiario articolo di Boris. Titolo: “Così Delors vuole governare l’Europa”.
Citando fonti molto probabilmente fantasiose e speculando su un incontro dei ministri degli Esteri europei a Guimarães, in Portogallo, Boris «rivela» che l’allora presidente della Commissione Ue Jacques Delors, uno dei padri dell’Unione Europea, si sta preparando a sferrare «la sua offensiva federalista che metterebbe a repentaglio le sovranità di tutti gli stati membri, risucchiando molte libertà».
L’articolo emerge in un momento delicatissimo. Sono i mesi della firma del trattato di Maastricht, pietra miliare dell’Ue di oggi, e alcuni Paesi organizzano dei referendum popolari per decidere se approvare questo nuovo passo verso un’Europa ancora più unita.
Nonostante all’epoca non ci fossero ancora Twitter, Facebook e tutti i portali virali di Internet, l’articolo di Johnson arriva a Copenaghen.6 Diventa, sorprendentemente, il vessillo di sovranisti ed euroscettici danesi dell’epoca, che addirittura ne stampano estratti su migliaia di volantini.
«Ecco che cosa dice la stampa inglese di questo accordo di Maastricht, leggete, leggete», «Così l’Europa vuole conquistarci», «Cambierà per sempre la nostra storia» eccetera.
A Copenaghen si diffonde il panico, come ricorda Charles Grant nel suo Delors: Inside the House that Jacques Built.7 Nel Paese nordico, l’atmosfera è così tesa che, dopo l’articolo di Boris, addirittura il governo danese chiede ufficialmente spiegazioni a Delors. Minaccia di mettere il veto a un suo nuovo mandato alla presidenza della Commissione europea a meno che non faccia marcia indietro sulle «preoccupanti» idee federaliste citate da Johnson nel suo articolo. Delors, racconta Grant, «era così pallido in volto che sembrava aver appena ricevuto un elettroshock».8
Ovviamente non c’è controprova, ma, in base a queste premesse, l’allarmismo di Johnson ha avuto un impatto molto probabilmente decisivo sul referendum del 2 giugno 1992, perché quel giorno in Danimarca il No a Maastricht vince con il 50,7 per cento.
In Francia la spunta invece il Sì, ma solo con il 50,8 per cento. Qui, per la vastità del territorio ancora disconnesso dal web, si diffondono in maniera minore gli strali di Johnson.
Cavoli di Bruxelles
Pompare ogni giorno ansia eurofobica, ma con sorriso e humour di classe. Così Johnson è diventato un giornalista celebrato dai capi e odiatissimo dai colleghi a Bruxelles, costretti dai superiori a inseguire le sue mezze bufale sull’Europa pubblicate dal Telegraph e condannati a prendere sempre «buchi» da Boris, sia quando Johnson pubblicava con scaltrezza notizie vere sia quando, più spesso, le spacciava per tali.
Dalla curvatura delle banane imposta dall’Ue alla «guerra dell’Europa» a divinità alimentari del Regno Unito come le patatine al gusto prawn cocktail. L’euroscetticismo in Regno Unito ha una storia lunghissima, eterogenea e a tratti anche sorprendente, come vedremo in seguito. La Brexit tuttavia è stata forgiata negli ultimi decenni, giorno dopo giorno, anche da un uomo, dal suo architetto più influente, sconclusionato e divertente, Boris Johnson. Che, come diceva Oscar Wilde, «tratta molto seriamente tutte le cose frivole e con sincera e studiata frivolezza tutte le cose serie della vita».
Ma Boris voleva davvero diventare il paladino dell’euroscetticismo continentale? Oppure era solo un gioco che, come spesso accaduto nella sua vita, gli è sfuggito di mano, diventando un moloch incontrollabile? Il personaggio in cerca d’autore si è impossessato dell’autore?
17 luglio 2019. Durante un comizio itinerante (in gergo «hustings») delle «primarie» del partito conservatore i cui iscritti (lo 0,4 per cento della popolazione) lo hanno poi eletto a capo del partito e soprattutto premier britannico, Boris Johnson ne combina un’altra delle sue.
Dal palco, in una delle sceneggiate adorate dai suoi fan, sventola un’aringa affumicata e confezionata. Urla alla folla: «Ecco, questa aringa secondo i burocrati di Bruxelles deve essere incartata con una borsa del ghiaccio. Che cosa costosa, inquinante e inutile! Ecco la follia dell’Unione Europea!».9
Peccato che la legge citata da Johnson non fosse dell’odiata Ue, ma britannica.
Una gaffe colossale. Ma non importa. Perché la fortuna di Johnson è sorta proprio dalle sue, spesso volontarie, gaffe a danno dell’Europa.
Molti anni prima, per esempio, sempre da corrispondente da Bruxelles, aveva scritto che l’Ue voleva impedire a Londra di riciclare le bustine di tè usate. Ovviamente non era vero.
Boris Johnson, dopo una breve e scomoda parentesi nella finanza della City, costruisce la sua carriera, prima giornalistica e poi politica, fabbricando bufale o esagerazioni contro l’Europa e Bruxelles, dopo un vergognoso licenziamento dal Times per una fake news su una fantomatica relazione gay di Edoardo II. Nella circostanza – è il 1988 – si inventa10 persino le dichiarazioni del suo padrino accademico e storico a Oxford, Colin Lucas, che si lamenterà con il suo direttore, scatenandone la furia.
Dopo quel vergognoso flop, nel ligio Regno Unito la carriera di chiunque altro sarebbe fallita sul nascere. Ma Boris ha un padre influente, e soprattutto all’Università è riuscito a diventare presidente della gloriosa Oxford Union («il bastione occidentale della libertà di parola», autodefinizione), germogliando molti e influenti contatti. Così telefona all’allora direttore del Telegraph, Max Hastings, uno dei suoi primi invitati a parlare alla Union: «Max, vorrei lavorare per te… se potessi darmi una mano…». Hastings lo «adotta» e poi, nel 1989, lo invia a Bruxelles come corrispondente, a soli 25 anni.
Se in quegli anni lo adorerà per l’incremento delle vendite e la visibilità regalata dagli avventurosi sensazionalismi di Boris, oggi Hastings detesta Boris. Nel tempo, è rimasto profondamente deluso dal suo «arrivismo», dalla «cialtroneria», dalla sua «inadeguatezza». Regolarmente Hastings pubblica articoli sulla stampa britannica in cui dilania l’immagine e la reputazione di Johnson, secondo lui «infimo» e «moralmente corrotto», che farebbe «qualsiasi cosa pur di ottenere i suoi egoistici obiettivi», uno che «pensa di somigliare a Churchill e invece è un comico di second’ordine». «Sarebbe stato meglio per tutti» aggiunge Hastings in una delle sue tante sciabolate di veleno, «che i Johnson si fossero dedicati allo spettacolo, come i fratelli Marx».11
Allo stesso modo, Boris Johnson odia, probabilmente ancora oggi, Bruxelles, dove suo padre Stanley negli anni Settanta trapianta la famiglia prima da diplomatico britannico e poi da parlamentare Ue. Il piccolo Johnson non la sopporta, a maggior ragione quando la madre Charlotte va in depressione, prima del divorzio da Stanley.
Ma qui inizia a scalpitare la leggenda di Boris: inizia a farsi chiamare solo col nome di battesimo («Uhm… Boris, please») e tutti accettano. Fatto singolare nella politica della formalissima Inghilterra.
La corrispondenza assegnatagli dal Telegraph è in un posto teoricamente «noioso». Ma il suo brio, la scrittura mai banale e la sua affamata fantasia capovolgono ogni convenzione. Bruxelles diventa improvvisamente frizzante come l’amato champagne, che però beve con molta parsimonia.
In questo Boris è molto diverso dal padre, come racconta Sonia Purnell nella sua straordinaria biografia Just Boris12, densa di preziosissimi dettagli. Boris non esagera con l’alcol, anzi ne è spesso rifuggito, anche all’università. Non gli piace ubriacarsi o andare al pub come la stragrande maggioranza degli inglesi. In fin dei conti, non gli piace la convivialità. Non gli piacciono gli amici, anche se frequentemente si rivolge al pubblico con «my friends», come suggeriva di fare Abraham Lincoln. Nonostante l’apparenza puerile e buontempona, Johnson è sempre stato un personaggio decisamente...