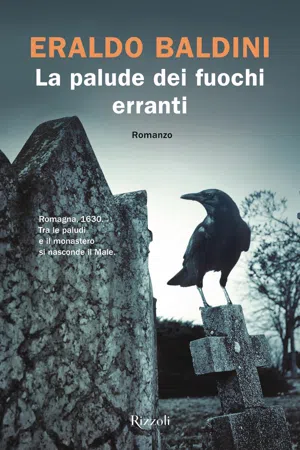Rodolfo Diotallevi si alzò presto e, senza indugio, si fece accompagnare dal suo aiutante Antonio e da tre soldati della sua scorta sulle linee dei cordoni sanitari. Erano lo scopo per cui era stato inviato a Lancimago e non poteva mettere tale compito in secondo piano, anche se gli eventi di quei giorni avevano aperto inaspettati scenari da incubo e sollevato problemi di non poco conto.
Camminò sulle sponde del Primaro, percorse le carraia che delimitava il lato settentrionale delle paludi, salutò con rapidi cenni i militi posti sui margini che dividevano, almeno per il momento, il mondo divorato dalla pestilenza da quello ancora non violato.
Nel punto in cui l’argine faceva una larga curva, si fermò a riposarsi e a parlare con un ufficiale delle guardie.
«Come procede qui?» gli chiese.
«Abbastanza bene» gli rispose l’armato. «Ma non ci si può distrarre un attimo: c’è sempre chi tenta di passare, e non solo in entrata.»
«Cioè?»
«C’è anche chi vuole attraversare i posti di blocco in uscita. Contadini dell’abbazia o del conte, abitanti di Lancimago e di altri piccoli borghi della zona.»
«Volete dirmi che esiste qualcuno che vorrebbe abbandonare un territorio sano per avventurarsi in quello in cui c’è la peste?»
«Sì, qualcuno che ha parenti dall’altra parte lo fa. A quanto pare hanno paura di quanto sta succedendo alle loro spalle più di ciò che potrebbero trovare oltre il fiume.»
«Non fateli andare: il cordone è invalicabile in ogni direzione.»
«Ma il conte ci ha detto, ieri sera, che chi vuole deve essere libero di partire…»
«Non è lui ad avere la responsabilità di questi confini: sono io, e voi dovete ubbidire e rispondere solo a me!»
Quante altre volte avrebbe dovuto ribadire la propria autorità? In troppe occasioni veniva ignorata, aggirata, messa in discussione, e la misura era colma.
Antonio provò a riflettere: «Be’, chi fugge da queste zone sane non rappresenta un pericolo, se non per se stesso. Diciamo che si va a cercare guai, e dovrà sopportarne le eventuali conseguenze».
«Chi parte lascia qui la propria casa, qualche familiare e tutto ciò che ha, per poco che sia. Quindi non lo fa come scelta definitiva, ma temporanea, in attesa di tornare. Di tornare dopo essere stato laddove il morbo dilaga. Questo non può e non deve accadere.»
Detto ciò, il monsignore si avviò verso l’abbazia a passo così svelto che Antonio faticò a tenergli dietro.
Trovò frate Orso fuori, vicino alla fossa, ora ricoperta, in cui qualche giorno prima erano stati rinvenuti gli scheletri senza storia e senza nome. Stava sistemando il terreno di riporto sferrando colpi di pala rapidi e nervosi, come per sfogare una rabbia repressa.
Diotallevi lo invitò a sé e gli disse: «Fratello, dobbiamo parlare».
«Lo so» rispose il monaco asciugandosi il sudore della fronte e infiggendo la pala nel suolo.
«Cos’è che sapete?»
«Che prima o poi mi avreste chiamato a un confronto. Se non lo aveste fatto, vi avrei cercato io.»
«Bene, eccoci. Qui non c’è anima viva, per adesso, ma preferisco che non ci scorgano a colloquio. Dove possiamo andare per sfuggire alla vista?»
Il monaco si guardò intorno. Le vicine strade del villaggio erano deserte, nell’abbazia era ora di pranzo e tutti dovevano essere nel refettorio. Fece cenno di seguirlo e si incamminò verso un macchione di alberi in cui, sul lato di un crocicchio fra viottoli, confluivano le siepi bordanti il terreno scuro e arato di fresco di un podere. Raggiunse un tronco caduto e vi si sedette. Diotallevi lo imitò.
Il monsignore, in quel luogo raccolto e celato, una sorta di rifugio accogliente come la tana invernale di un riccio o come un ventre materno, separato e difeso da tutto ciò che c’era al di fuori, tirò un respiro profondo e avvertì quasi il bisogno di accoccolarsi nel cantuccio più nascosto e quieto, abbandonandosi per un po’ al silenzio ovattato di quella nicchia, rotto solo dal richiamo di qualche merlo tra i rami. Da giorni non assaporava la solitudine di cui spesso aveva invece bisogno, non godeva del senso di familiarità e di riservatezza che gli dava la sua camera nel vescovado di Sarsina, dalle cui finestre vedeva solo il fianco scuro di un monte, eretto a fortezza capace di tenere lontano ogni intrusione e persino ogni ambascia.
Orso, strappandolo a quel momento inaspettato di pace, sospirò, fece girare lo sguardo in ogni direzione e disse con un sorriso storto: «Qui non ci vede e non ci sente nessuno, a meno che non ci siano davvero diavoli e maghi capaci di trasformarsi in mosche, in passeri o in un soffio di vento».
Diotallevi si scosse e, come sempre faceva, cercò di chiudere in fretta ogni spiraglio capace di mostrare a se stesso e agli altri qualche segno di debolezza e di nostalgia. Con un’espressione tornata dura fissò il monaco negli occhi e disse: «Pare che non ci crediate molto, a questa eventualità».
«No, non ci credo. Di accusati di stregoneria ne ho avuti sotto le mani parecchi, nella mia vita precedente, e non ne ho mai visti che fossero capaci di sfuggirmi mettendo le ali o scomparendo per incanto.»
«Fra questi c’era anche Luigia di Zambrino?»
L’uomo abbassò la testa e rispose: «Sì. È stata l’ultima: dopo il suo processo ho lasciato quel lavoro e mi sono fatto monaco, chiedendo di essere destinato a questa abbazia».
«Perché proprio a questa?»
«Perché qui vicino era nata mia madre e continuava a viverci la sua sorella maggiore, una donna che, quand’ero piccolo, per alcuni anni mi aveva accudito e cresciuto, dato che la mia povera mamma era sempre malata e aveva altri sei figli.»
«Vive ancora a Lancimago, questa signora generosa?»
«Non vive più. Da ieri.»
Diotallevi ebbe un fremito di sorpresa. «Volete forse dire che Luigia di Zambrino era vostra zia?»
«Esattamente.»
«E voi, quando fu incriminata, l’avete dovuta torturare?»
«Non la vedevo da decenni e non avrei potuto riconoscerla. Mentre lei invece sapeva bene chi ero, perché aveva sempre cercato di avere notizie di me. A cose finite mi svelò tutto. Disse di non avermi informato prima per non crearmi problemi: aveva temuto che, se le avessi portato un qualche riguardo, avrei perso il mio incarico o corso rischi ancora più grandi. Ci pensate? Si preoccupava per me, mentre io le infliggevo supplizi che… che non potete nemmeno immaginare.»
«Posso immaginarli benissimo, perché vi ho assistito più di una volta. D’altronde il braccio della giustizia e del Signore devono essere forti e severi, quando è necessario.»
Frate Orso scosse la testa.
«Non siete d’accordo?» incalzò Diotallevi.
«Non importa cosa penso, io non sono altro che un povero monaco con la coscienza gravata da pesi enormi. Importa invece che, quando seppi chi era la donna a cui avevo tormentato la carne e di cui avevo versato il sangue, lo stesso sangue che scorre nelle mie vene, feci la scelta di cominciare a vivere in un modo diverso. Perché il Signore, e questo lo sapete meglio di me, si può servire in molti modi.»
«Dopo che siete tornato a Lancimago, dove Luigia viveva, avete mai avuto modo di incontrarla e di parlarle?»
«Poche volte, e di nascosto. La zia non voleva che ci vedessero insieme, temeva che questo potesse nuocermi, anche se la sua colpa, se mai colpa c’era stata, l’aveva espiata.»
«Lei mi ha confidato, poche ore prima di morire, di sapere cose… cose che riguardano questo posto e gli oscuri fatti che vi stanno accadendo. Di avere notizie anche sugli scheletri trovati nella fossa vicino all’abbazia.»
«Più di un monaco le conosce, quelle notizie, così come il conte e la sua famiglia; e pure il parroco del villaggio, credo.»
«Vi riferite a ciò che mi ha rivelato fra Pandolfo?»
«Non so cosa vi abbia detto, quello.»
«Mi ha mostrato la pagina di un regesto da cui risulterebbe che, a essere sepolti a poche decine di metri da qui, sono i membri di un gruppo di eretici in fuga. Una fuga finita qui più di tre secoli fa.»
«Non è così, e Pandolfo lo sa bene. Anzi, lui lo sa meglio di tutti, essendo il custode dei documenti e delle memorie di Santa Maria in Lancimago.»
«Cosa volete dire?»
«Che quelle spoglie non appartengono a forestieri passati di qui per caso, eretici o meno che fossero, ma a contadini e abitanti di questo luogo. Che la loro morte, anzi la loro uccisione, ha avuto luogo più di recente, agli inizi del secolo scorso.»
«Per mano di chi?»
«Di chi allora comandava qui, cioè degli stessi che comandano ancora oggi: i conti Cappelli e anche i reggenti dell’abbazia, probabilmente.»
«Ma perché avrebbero compiuto un tale massacro?»
Orso sospirò, si guardò di nuovo intorno, tormentò con le mani un rametto raccolto da terra e rispose: «Più o meno per gli stessi motivi per cui, adesso, stanno accadendo le cose strane che avete visto qui: motivi di interesse, intendo».
«Ne siete certo?»
«Sì. E ora che hanno ucciso mia zia, perché sono sicuro che non l’ha fatto da sé, voglio, e soprattutto devo, raccontarvi tutto quel che so.»
«Da dove viene la vostra convinzione che non si sia suicidata?»
«Ma l’avete vista? Avete osservato la scena? Anche se la trave del soppalco era abbastanza in basso, lei, che ormai faticava persino a camminare, non l’avrebbe mai potuta raggiungere per passarvi il cappio. Inoltre i suoi polsi erano lividi: qualcuno li ha stretti per tenerla, non c’è dubbio. E, al di là di tutto questo, so che non si sarebbe mai tolta la vita.»
«Avete detto che volete darmi informazioni e svelarmi segreti che non conosco: ebbene, vi ascolto» mormorò il monsignore facendosi il segno della croce, come se stesse per confessare un peccatore.
Aveva attraversato il fiume all’alba con il carro tirato da quattro buoni cavalli e vuoto, tranne che per alcuni grandi teli e coperte ripiegati sul fondo. Essendo il traghetto sorvegliato dalle guardie del conte, non aveva avuto alcun problema e non c’era stato bisogno di esibire la patente di sanità e il lasciapassare, completi di sigilli, che suo cugino gli aveva fatto preparare: documenti senza valore, essendo ogni transito interdetto senza condizioni e senza eccezioni, ma che avrebbero potuto, alla bisogna, ingannare i più sprovveduti.
Superato l’argine dall’altra parte, non aveva potuto non sentirsi inquieto e aveva acuito i sensi e l’attenzione.
I due soldati che l’accompagnavano, le armi nascoste sotto abiti borghesi, tacevano e si guardavano di continuo intorno; avrebbero rinunciato volentieri a quel viaggio ma avevano avuto l’ordine di farlo, oltre a una discreta ricompensa, quindi avevano ubbidito anche se, constatò Ferdinando Zecchini, si leggeva nei loro occhi che la cosa li preoccupava parecchio e che non vedevano l’ora di tornare a Lancimago, o magari di svignarsela alla prima occasione.
Trovarsi nelle terre colpite dalla peste, in cui ogni cosa poteva celare l’insidia del morbo, innervosiva anche lui, ma aveva necessità di procurarsi sostanze minerali, tubi e giunti che avrebbe potuto reperire solo a Bologna. O perlomeno in quella città sapeva dove cercarli e a chi chiederli, senza che dei suoi acquisti girasse voce quando invece dovevano rimanere segreti.
Erano cose che gli servivano assolutamente e subito, perché la situazione era matura e non si doveva perdere l’attimo. Certi amici fidati e contatti importanti che conservava con Venezia, e lo stesso governo della Serenissima – che credeva, come sempre aveva fatto, nel suo lavoro e nel suo ingegno – gli garantivano il denaro necessario, e inoltre pensava di avere trovato ciò che cercava da tempo: alcune sacche sotterranee, grandi e piene, che come polmoni gonfi trattenevano il gas in attesa di restituirlo, vigoroso e impagabile, a chi avrebbe saputo dargli uno sfogo.
Quei giacimenti, che immaginava preziosi quanto filoni d’oro, avevano aspettato anche troppo di essere compresi, scoperti e sfruttati. Sarebbe partito da un piccolo impianto di prova nelle terre di suo cugino il conte, in attesa di poter attingere ai depositi più ricchi, quelli che stavano nella palude e intorno a essa. Era da lì che al momento opportuno sarebbe scaturito, forte e impaziente come un nume o un demone finalmente liberato da una lunga prigionia nelle viscere della terra, un soffio denso, il respiro di ciò che è morto e quindi non può più morire, ma solo produrre nuova energia e nuova vita.
Tornò con la mente al viaggio che era costretto a fare per approvvigionarsi del necessario e con gli occhi a ciò ...