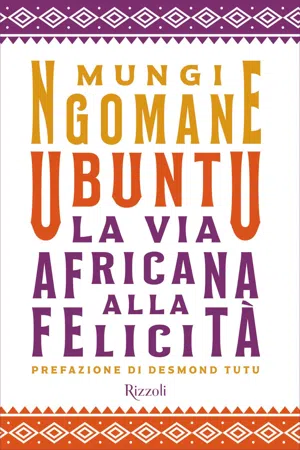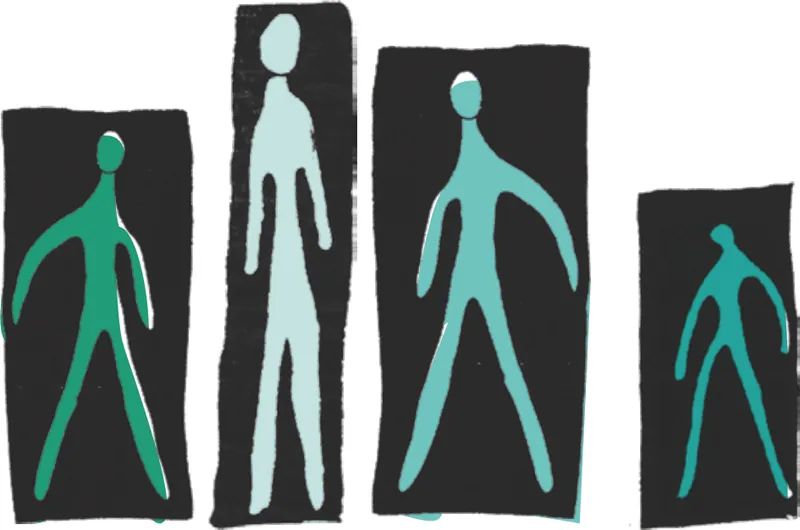Se riusciamo a vedere noi stessi negli altri, la nostra esperienza nel mondo sarà inevitabilmente più ricca, gentile e solidale. Se guardando le altre persone vediamo il riflesso di noi stessi, non potremo fare a meno di trattarle meglio.
Questo è l’ubuntu.
Non va però confuso con la gentilezza. Quest’ultima è una qualità che dovremmo provare a mettere in pratica più spesso, ma l’ubuntu va molto più a fondo. Riconosce il valore interiore di ogni essere umano, cominciando da noi stessi.
È stata questa filosofia a ispirare la lotta contro l’apartheid, il violento sistema istituzionalizzato di segregazione razziale che vigeva in Sudafrica fino al 1994, a causa del quale bianchi e neri erano costretti a condurre vite totalmente separate. Il movimento antiapartheid non è mai stato una crociata contro i bianchi, bensì una battaglia a favore di tutti i sudafricani, affinché fossero visti e trattati come pari. Imparando ad affrontare le avversità e l’oppressione aggrappandoci all’ubuntu e mettendolo in pratica nella vita di tutti i giorni, possiamo sperimentare il metodo più efficace per superare le divisioni. Questo è il regalo del Sudafrica al mondo intero.
Sono grata di essere cresciuta tra molte persone sagge. Mia madre, Nontombi Naomi Tutu, è un’attivista per la pace e una femminista, tiene discorsi in pubblico e di recente è stata ordinata sacerdotessa. I miei nonni sono stati in prima linea nel movimento antiapartheid e, nel 1984, mio nonno vinse il Nobel per la pace per la sua lotta non violenta contro il sistema. Assorbire le parole, le esperienze, le risate e le convinzioni della mia famiglia mi ha aiutata lungo il mio percorso di vita. Il modo in cui i miei familiari vivono incarna lo spirito dell’ubuntu, che considera prioritario il servizio agli altri.
Condividete il viaggio
La lotta antiapartheid in Sudafrica è stata una risposta alla colonizzazione e all’oppressione dei sudafricani neri, meticci e asiatici. Migliaia di persone hanno perso la vita e la violenza ha dilaniato il Paese, che ha impiegato anni per riprendersi. L’apartheid è finito nel 1994 con le prime elezioni democratiche della nazione, ma ancora oggi il Sudafrica combatte per lasciarsi alle spalle i suoi effetti.
Nel dicembre 1984 mio nonno andò in Norvegia per ritirare il premio Nobel. Essendo un uomo di Chiesa, si adoperava per ottenere giustizia con mezzi non violenti, mostrando contemporaneamente al mondo il dolore e l’iniquità dell’apartheid. Voleva che l’opinione pubblica conoscesse bene le conseguenze che la segregazione aveva su tutti i sudafricani.
Il comitato del Nobel aveva detto ai vincitori che avrebbero potuto invitare chiunque volessero alla cerimonia in programma all’Università di Oslo, e il nonno non esitò ad approfittare dell’offerta. Estese l’invito alla famiglia e a molti altri ospiti, compilando una lista di almeno cinquanta persone. Questi amici arrivavano da tutto il mondo: dal Sudafrica agli Usa, dal Lesotho al Regno Unito. Erano persone che mio nonno aveva conosciuto nel corso della vita e con cui aveva condiviso il suo viaggio.
Quella sera l’aula dell’università fu temporaneamente evacuata per un allarme bomba. In seguito, quando fu possibile rientrare nell’edificio in sicurezza, mio nonno salì sul palco per ritirare il suo premio. Poi fece una pausa, e osservò la folla in silenzio. In quel momento fu colpito da un pensiero profondo: la sua candidatura era stata resa possibile grazie a tutte quelle persone presenti nel salone. Quell’istante cristallizzò la consapevolezza che tutti gli obiettivi raggiunti nella sua vita erano stati possibili grazie agli altri e al loro aiuto.
In seguito arrivò il momento di festeggiare, e anche se tutti – compreso il re di Norvegia – erano tornati nell’edificio, i musicisti erano andati via. Così gli ospiti sudafricani del nonno iniziarono a cantare, facendo apprezzare ancora di più la loro presenza.
L’ubuntu ci dice che siamo chi siamo solo grazie ad altre persone. Naturalmente dobbiamo riconoscere ai nostri genitori il merito di averci messi al mondo ma, al di là di questo, lungo il nostro cammino intessiamo centinaia se non migliaia di relazioni, e tutte – grandi o piccole che siano – ci rivelano qualcosa sulla vita e su come viverla bene. I nostri genitori o tutori ci insegnano a camminare e parlare. I maestri, a scuola, ci insegnano a leggere e scrivere. Un mentore potrebbe aiutarci a trovare un lavoro gratificante. Il partner potrebbe darci degli insegnamenti emotivi, siano essi buoni o cattivi. Impariamo da tutte le esperienze. Ogni interazione ha contribuito a condurci dove siamo oggi.
Nel mondo occidentale, tuttavia, veniamo educati a credere che «farsi da sé» sia motivo di vanto. Proviamo ammirazione per coloro che hanno ottenuto fama e successo solo grazie ai loro sforzi, o così crediamo, dimenticandoci del fatto che nessun obiettivo può essere raggiunto in un vuoto di relazioni. Impariamo inoltre che la strada per il progresso e la realizzazione di sé passa per la competizione, e poco importa che competere con gli altri conduca spesso a raffronti impietosi e alla lacerante sensazione di non essere abbastanza bravi.
Quante volte avete paragonato la vostra vita con quella di qualcun altro e vi siete sentiti inferiori? Quante volte vi siete trovati a desiderare di più, anche se avete già molto? Una casa più grande. Più denaro. Più lavoro o più tempo libero.
L’ascesa dei social media è stata cruciale nell’alimentare il fuoco dell’insoddisfazione. Ogni volta che accediamo a Facebook o Instagram, osserviamo le vite altrui da vetrine ben allestite, piene di immagini spesso ritoccate e modificate per apparire più accattivanti. Famiglie felici e sorridenti in stanze impeccabili, tanti festeggiamenti, gli annunci di un nuovo lavoro, di un buon acquisto, dell’inizio di una nuova relazione.
È magnifico partecipare alle gioie dei nostri amici, ma molti di noi seguono anche centinaia – a volte migliaia – di sconosciuti che sembrano avere una vita più ricca, più divertente e più brillante della nostra. Sono individui che non conosciamo personalmente, eppure influenzano i nostri acquisti, le nostre emozioni e aspirazioni. Il messaggio implicito è che un influencer è migliore di una persona qualunque.
L’ubuntu ci insegna l’esatto contrario, affermando che su questa terra tutti hanno pari valore, perché la cosa più importante è la nostra umanità. Invece di paragonarci agli altri, dovremmo apprezzare il loro contributo alla nostra vita di tutti i giorni. Tuttavia ci sono influencer che possono avere un effetto positivo su di noi. Non uso più i social e non m’interesso granché a questi personaggi, ma i pochi che seguo – attraverso i podcast – sono più interessati a fornire utili contenuti che non a fare soldi. Condividono messaggi, interviste e consigli sugli argomenti più disparati, come il benessere e la salute mentale, le relazioni e il lavoro.
Pensate a chi vi ha resi la persona che siete oggi. Considerate per un momento tutte le persone che vi aiutano nella vita. I vostri genitori e amici, certo, ma provate ad allargare la cerchia: forse scoprirete che la lista è più lunga di quanto credete. C’è il meccanico che vi ripara l’automobile cosicché possiate partire per il weekend. C’è il barista che chiude un occhio quando vi manca qualche spicciolo per pagare il caffè. C’è il passeggero del treno che vi lascia scendere per primi vedendo che siete di fretta. Tutte queste interazioni apparentemente insignificanti vi semplificano la vita. Le azioni di queste persone possono fare la differenza nella vostra giornata, come le vostre possono farla nella loro.
Pensate alle persone che aiutate. Fate una seconda lista. L’amico che vi chiede un consiglio. Il collega cui date una mano in ufficio. Il bambino che allevate accudendolo ogni giorno e cucinandogli i pasti. La persona cara cui offrite una spalla su cui piangere quando ne ha bisogno.
Osservate come la vita sia un dare e ricevere. Preferite dare che ricevere? Quale delle azioni che avete compiuto per qualcun altro vi ha fatto stare bene con voi stessi? Cosa potete fare oggi, o domani?
Voi siete abbastanza
Con gli occhi pieni di ubuntu vediamo il mondo attraverso la lente dell’uguaglianza e della gratitudine. Da un lato aspiriamo a non farci influenzare troppo dagli altri, nei nostri pensieri e sentimenti, ma dall’altro siamo riconoscenti a tutti coloro che ci hanno aiutati a diventare chi siamo. I genitori che ci lasciano spazio e libertà per fare nuove esperienze di vita, gli insegnanti e i mentori che mettono a disposizione la loro saggezza per permetterci di affrontare il viaggio, gli amici che ci incoraggiano o i familiari che magari ci hanno concesso un prestito. Siamo grati di ciò che siamo, qui e ora, perché l’ubuntu ci insegna che siamo abbastanza. Non c’è bisogno di paragonare la nostra vita a quella degli altri, ciò che abbiamo a ciò che gli altri hanno o non hanno. Possiamo invece essere riconoscenti per i contributi di altre persone alla nostra esistenza.
Con l’ubuntu nella nostra vita possiamo scegliere di vedere gli altri come nostri pari, di considerarli come vorremmo che considerassero noi. Fin troppo spesso ci concentriamo soltanto sul ruolo che le persone svolgono nel mondo, senza considerare gli altri aspetti. L’ubuntu ci dice che non siamo migliori o peggiori di nessun altro. Tutti meritano di essere trattati con umanità.
Quando per strada incrociamo lo sguardo di un mendicante, possiamo provare empatia anziché biasimo. Quando incontriamo una donna delle pulizie, possiamo mostrarle gratitudine anziché guardarla dall’alto in basso per il lavoro che fa.
L’ubuntu si oppone alla convinzione che una persona «si faccia da sé», perché siamo tutti interconnessi. Non dobbiamo lasciarci ingannare dal mito del self-made man, perché nessuno vive in completo isolamento. Come ha detto il poeta John Donne, «nessun uomo è un’isola».
L’antitesi dell’ubuntu è la convinzione che l’avidità, l’egoismo e l’individualismo forniscano tutti gli strumenti necessari per avere successo nella vita. Spesso sentiamo dire che per raggiungere i nostri obiettivi occorre calpestare gli altri. Nel mondo del lavoro, in particolare, la vita può essere spietata e per molte persone l’idea darwiniana della sopravvivenza del più forte è ancora una regola pratica.
Come ho sentito spesso affermare dagli anziani, chi fa del male agli altri è convinto di non subire le ripercussioni negative delle proprie azioni, ma a un esame più attento le conseguenze sono ben visibili.
Durante l’apartheid, per esempio, la segregazione sembrava assicurare una vita privilegiata ai sudafricani bianchi. Vivevano separatamente, in comunità ben organizzate. Avevano accesso a un’istruzione e a un’assistenza sanitaria migliori di quelle dei neri. Ma il prezzo di questi privilegi era molto caro, in termini di libertà. Educati ad aver paura dei neri, hanno rinunciato a molti diritti per il privilegio del potere. Hanno costruito alti muri intorno alle loro case e si sono rinchiusi in comunità blindate, terrorizzati all’idea di uscire. Si sono trovati rinchiusi in una prigione che loro stessi avevano creato.
Domandatevi: «Come posso vedere me stesso negli altri?»
Fornire una traduzione chiara e sintetica del concetto di ubuntu è un’impresa spinosa. Nelson Mandela, durante un’intervista televisiva con il giornalista sudafricano Tim Modise, nel 2006, ha provato a spiegare l’essenza di questa filosofia raccontando in termini semplici che cosa significava per lui:
Nei tempi passati, quando eravamo giovani, se un viandante si fermava in un villaggio non aveva bisogno di chiedere cibo e acqua. Arrivato lì, le persone gli offrivano cibo e lo servivano.
Questo è solo un aspetto dell’ubuntu, ma ce ne sono altri. Ubuntu non vuol dire che le persone non debbano impegnarsi. La domanda è dunque la seguente: cosa avete intenzione di fare per attivare la comunità intorno a voi e permetterle di migliorare? Sono queste le cose importanti nella vita. Se si riesce ad agire in questo modo, si sarà fatto qualcosa di davvero importante.1
Tutti vogliamo sentirci parte di qualcosa. È nella natura umana appartenere a una tribù (amici, persone care, colleghi, compagni di sport…), ma più che mai dobbiamo imparare anche a vivere e lavorare con tutti, anche con gli estranei. Uscire dai nostri confini può darci ciò che ci serve per sentirci pienamente realizzati. Vedere gli altri uomini e donne come alleati (dal latino alligare, «legare») è proficuo per tutti. Vedere noi stessi nelle altre persone è una potente forza positiva.
Scegliete di stabilire un contatto con gli sconosciuti. Tutti possiamo essere distratti, assorti e avere l’impressione di non avere mai abbastanza tempo per fare ciò che vorremmo o di cui sentiamo il bisogno. Forse non riteniamo necessario dire un grazie sincero al negoziante che ci ha appena serviti oppure guardiamo il telefono mentre il controllore ci convalida il biglietto ferroviario. Forse non ce ne accorgiamo quando qualcuno ci tiene aperta una porta o si sposta per farci passare. Provate a guardare negli occhi tutte le persone che incrociate. Stabilite un contatto con loro. Sorridete. Ringraziate con entusiasmo. Noterete un miglioramento nel vostro stato d’animo e nelle vostre interazioni con gli altri.
Siate consapevoli dei vostri giudizi e lasciateli andare silenziosamente. Tutti noi e...