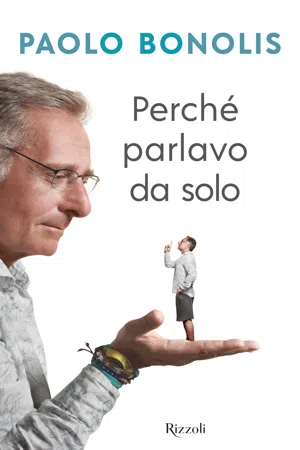29 ottobre 2016
Appunti per una lezione universitaria
Per creare un prodotto televisivo, viene spesso chiesto: «Cos’è che la gente vuole vedere?». Io, invece, credo che si debba partire dalla domanda: «Cosa ho io da raccontare?».
C’è una profonda differenza.
Si dice che in televisione non ci sono idee, eppure le proposte televisive sono tantissime. In realtà sono quasi tutti sottoprodotti modificati di idee originali (format). Poche idee originali e un numero immenso di derivati.
Questo in parte perché il mercato richiede molto materiale e non importa quanto sia nuovo o quanto sia similare all’originale. E in parte perché l’originalità di un prodotto televisivo comporta un impegno maggiore per chi lo elabora e più rischi per chi lo produce finanziandolo.
Ecco quindi che ci sono due tipi di autori televisivi: quelli che inventano e quelli che adattano. In parole povere, senza offesa ma solo per semplificare: da una parte le menti, dall’altra le braccia.
Bisogna scegliere dove stare. Io personalmente mi occupo di menti, di quelli che inventano. Le menti sono anche braccia, mentre le braccia sono solo braccia.
Tutti possono essere menti? Secondo me sì, ma non è un processo facile.
Tutti possono essere braccia? Sì, e non è così complesso.
Per provare a essere una mente televisiva occorrono tre elementi fondamentali: coraggio, analisi e tecnica.
Per essere braccia occorre solamente la tecnica. Ma mentre quest’ultima è un elemento che si può apprendere esercitandosi, il coraggio e l’analisi richiedono una natura e un esercizio personale che non tutti riescono a fare, anche perché potrebbe risultare molto deludente.
Secondo me, però, la delusione che ne potrebbe derivare è solo indirettamente proporzionale al coraggio investito, elemento primo del nostro percorso.
Il coraggio richiesto per questo lavoro riguarda le capacità di non temere di esprimere ciò che pensiamo e ciò che siamo, poiché questa è l’unica via sicura per essere originali. Ognuno di noi, per vissuto e per natura personale, è un individuo unico e irripetibile. Quindi, ogni sua espressione non condizionata, ogni fantasia realmente propria, sarà originale e priva di antenati: prima di voi, nessuno mai è stato voi.
Ma, per cogliere cosa realmente siete e pensate, non dovete temere il giudizio o il rifiuto, lo scherno o l’incomprensione. In un mondo omologante e che vuole subito il successo acquisito, questo è un passo che richiede molto coraggio.
Già, direte voi. Ma che cosa ho da dire di così nuovo che non sia stato già detto?
L’originalità, in televisione come nella vita, non risiede tanto in ciò che si fa, ma in come lo si realizza. È quello che ho tentato di trasmettere ai ragazzi dell’università a cui ho fatto il discorso riportato all’inizio di questo capitolo: mi piace parlare ai giovani, trarre nuova linfa dal loro entusiasmo e, magari, anche spiazzarli un po’ con le mie domande.
Del resto, quello che spiego loro l’ho provato, l’ho sperimentato sulla pelle fin dall’inizio della mia carriera. Io, questo mestiere, l’ho cominciato per caso: non avevo mai avuto velleità artistiche, anzi mi sarebbe piaciuto intraprendere la strada diplomatica. Frequentavo la facoltà di Scienze politiche e un giorno un mio caro amico, Massimo Russo, che faceva l’attore, mi ha chiesto di accompagnarlo a fare un provino in via Teulada, alla Rai: cercavano un conduttore per un nuovo programma per ragazzi. C’era una bolgia di aspiranti presentatori, tutti con qualche rudimento di canto o ballo o recitazione; poi c’ero io, un pesce fuor d’acqua, capitato per caso e preso totalmente alla sprovvista quando un signore gentilissimo, Leone Mancini, vedendomi mi chiese: «E tu? Fai anche tu il provino, dai!».
Non lo sapevo allora: era il regista del programma, una persona molto distinta ma dall’aria nel complesso piuttosto buffa. Era come se sul volto avesse tutto quello che ci deve essere – naso, occhi e bocca –, però non esattamente al posto giusto: sembrava che su di lui avessero preso male le misure. Un Picasso! Comunque, mi convinse e raccontai un paio di barzellette.
Il risultato fu che il mio amico venne scartato, mentre io fui preso. Avrei dovuto condurre un programma per ragazzi insieme a Sandro Fedele e Marina Morra, si chiamava «3, 2, 1… contatto!»a e, per farlo, mi offrivano un milione di lire al mese, dodici in un anno. Ora, nonostante non avessi mai visto tutti quei soldi, onestamente a me di fare la tv non importava un fico secco perché volevo continuare serenamente la carriera universitaria. Fu mio padre a intervenire, con il suo savoir-faire: «Sappi che si nun ce vai, te pijo a carci in culo a due a due finché nun diventeno dispari».
Ecco un’argomentazione a cui non avrei saputo controbattere. Accettai. E vissi quell’esperienza con una leggerezza assoluta, senza prenderla troppo sul serio. Per un insieme di circostanze, lasciammo la Rai e finimmo sulla Quinta Rete, che poi venne assorbita dalla Fininvest e diventò Italia 1. Imparai un’altra lezione: nella vita devi essere bravo, devi impegnarti, non devi avere paura, ma ogni tanto ci vuole pure un po’ di culo. E io devo ammettere che sono stato una persona estremamente fortunata: anche quando c’era un attimo di bonaccia, a me arrivava sempre di poppa.
Infatti, il programma per ragazzi che conducevo passò nelle mani del capostruttura Fininvest Alessandra Valeri Manera, che tenne solo me come conduttore e mi affidò «Bim Bum Bam»b insieme a Licia Colò e a un pupazzo rosa, Uan (perché la rete era Italia 1). Fu un passaggio importantissimo nel mio modo di fare televisione: anzitutto perché incontrai il regista, Stefano Vicario, a cui sono rimasto legato tutta la vita e con cui ho confezionato programmi importanti, e poi perché cominciai a esprimere la mia unicità di conduttore, nel bene o nel male, assumendomi tutti i rischi del caso.
I testi di «Bim Bum Bam» erano di Lidia Ravera, bravissima scrittrice, autrice e giornalista, che però utilizzava un linguaggio sdolcinato per parlare ai bambini e a me proprio non si confaceva. Presi coraggio e, insieme a Giancarlo Muratori, voce di Uan, attore e uomo formidabile, andammo a chiedere alla signora Valeri Manera di poterci scrivere da soli le nostre interazioni. Il programma non stava andando benissimo, quindi non trovammo grosse resistenze; lei ci disse di provare per una decina di giorni.
Ho sempre pensato che ai bambini si debba parlare con termini adeguati alla loro età, ma in una maniera normale, senza troppi birignao. Anzi, aggiungendo pure quella dose di cattiveria che ai piccoli piace. Almeno, a me piaceva da ragazzino quando, guardando i cartoni animati della Warner tipo Willy il coyote, Tom e Jerry, Yoghi e Bubu, c’era sempre quello che cadeva o il fesso che rovinava tutto, il cattivo che faceva sgambetti e trabocchetti.
Fra l’altro, questo permette al pubblico più giovane di leggere facilmente, mentre si diverte, una realtà manichea: da una parte c’è il buono e dall’altra c’è il cattivo, esistono la generosità come l’avidità, il coraggio ma anche la pavidità. Il piccolo spettatore comincia a rendersi conto che queste figure gli somigliano, ma le vede lì trasformate in maniera buffa e si diverte.
Insomma, ho cominciato a fare cose che nessun conduttore prima si era azzardato a inscenare, tipo schiacciare i puffi, che mi sono sempre stati antipatici, e gli ascolti intanto schizzavano alle stelle.
Da allora in poi ho sempre cercato di fare a modo mio, non per presunzione ma perché mi viene più facile e spontaneo essere autore di me stesso. Mi è capitato di cambiare diverse cose, perché il vestito che stavo indossando in quel momento, cioè la trasmissione, doveva appartenermi, doveva “cascare” bene. Un abito che non fosse della mia taglia mi renderebbe goffo, così come diventerebbe goffo tutto il racconto che ne seguirebbe.
Certo, ora è più facile per me gestire tutto questo, perché posso scegliere i programmi da fare, anzi li posso ideare direttamente io, in modo che mi appartengano fino in fondo e rispecchino ciò che desidero raccontare. Ma anche quando non avevo tutta questa “libertà”, a dire il vero me la sono presa lo stesso, con le possibili conseguenze che avrebbe eventualmente comportato questo atteggiamento.
Il programma «Beato tra le donne»c ne è un esempio piuttosto evidente. Il format (ovvero l’idea, la struttura) era tedesco ed era stato venduto alla Rai da una casa di produzione australiana, la Groundy, con l’accordo che la conduzione sarebbe stata affidata a Renato Zero. Il giorno in cui il capo di questa casa di produzione arrivò da Sydney, atterrò con due ore di anticipo e venne quindi portato a fare un giro per gli studi. Io ero in diretta con «I cervelloni»d e ricordo di aver notato un omone, accanto alla camera 2, che mi osservava con attenzione a braccia conserte. Andò a finire che l’australiano disse: «Se facciamo la trasmissione, la deve condurre quel ragazzo lì».
Visto? Aereo in anticipo… e fortuna. Decisamente fortuna.
Regista e autore di «Beato tra le donne» era Pier Francesco Pingitore: rigoroso e serio, mi aveva scritto un copione di puntata più alto del Talmud, dove c’era tutto, dal buonasera iniziale all’arrivederci finale. Imparai solo le battute che dovevo rivolgere agli altri attori del cast, mentre per il resto feci di testa mia.
Alla fine della puntata, bussarono al mio camerino. Era Pingitore. Restando sulla soglia e fissandomi negli occhi, mi disse: «Lei non ha detto una sola parola di quello che ho scritto io». «Non sono capace di ripetere tutto a memoria, ho fatto di testa mia, le chiedo scusa.» La sua risposta: «È stato molto meglio così. Ci vediamo dopodomani». E siamo diventati amici.
La ragione di quella che può sembrare una sconfinata fiducia nei propri mezzi è in realtà una chiara idea dei limiti e, soprattutto, la dimostrazione che non occorre essere dotati di una personalità spiccatamente eccentrica: basta non aver paura della propria. Credo valga per qualsiasi mestiere: non bisogna temere di essere un paria, perché ognuno di noi è unico e irripetibile. Per questo mi dà molto fastidio l’“accademismo”: l’ortodossia e insieme l’ipocrisia dell’atteggiamento. Lo rifiuto in generale e soprattutto nel mio lavoro.
In fondo, i personaggi televisivi che rimarranno nella memoria hanno espresso ognuno la propria personalità, anche se in modo più castigato e sobrio di quanto si tenda a mostrare oggi. Baudo è sempre stato Baudo quando faceva le sue trasmissioni: non si vestiva da conduttore televisivo. Arbore è Arbore e non ha mai fatto trasmissioni che non gli corrispondessero. Corrado era Corrado. È facile accorgersene.
Allo stesso modo, ricordo un attore famoso come Alberto Lupo a condurre una «Canzonissima» che non mi piacque, perché Lupo non era un conduttore, era un attore che stava interpretando il ruolo del conduttore: si trattava di un’interpretazione elegante, certo. Garbata. Ma non era se stesso. E la televisione non richiede che tu reciti.
Il primo quiz che ho condotto fu «Doppio Slalom».e Ero reduce da «Bim Bum Bam» e, a dire la verità, avevo chiesto direttamente a Berlusconi, durante una sua visita in azienda, se potesse prevedere qualcosa di diverso per me dopo anni di programma per ragazzini. Mi rispose: «Mi ricorderò. Lei mi piace, mio figlio PierSilvio la guarda». Fu di parola.
Anche a «Doppio Slalom» ho sovvertito un po’ le regole del gioco. O meglio: ho cominciato a giocare veramente, perché quando da spettatore guardavo i quiz avvertivo sempre un “freno tirato”. C’erano un’ortodossia e un’educazione che, a fronte di determinate situazioni, mi sembravano assurde. Ricordo, ad esempio, un concorrente che scelse le lettere M e D; la definizione da indovinare era «Celebre quadro del Goya». Mi rispose: «La mona desnuda». Come avrei potuto soltanto dire: «No, è sbagliato, passo alla domanda dopo»? Ma se mi dai una risposta così, io voglio capire chi sei, da dove vieni, come ti è venuta in mente “la mona desnuda” invece di La Maja desnuda… te si veneto?
Ho cominciato a divertirmi e a divertire attraverso queste incespicature culturali. Me n’è rimasta impressa una in particolare, successa durante la trasmissione «Urka». Domanda di cultura generale: «Lo incontrò Mosè sul monte Sinai». Risposta: Saronni.
Erano appena finiti gli anni del dualismo tra Moser e Saronni, per cui il concorrente deve aver capito Moser e credo che abbia immaginato il monte Sinai come una delle tappe di montagna del Giro d’Italia. Nella mia testa si configurò l’immagine di Charlton Heston, così come appariva nel film I dieci comandamenti, coi capelli elettrizzati bianchi e neri, fulminati, con questa parrucca che lo faceva sembrare Don King, che scende portando con sé le tavole della Legge. Poi, mentre guarda verso il basso la folla del popolo ebraico con gli occhi puntati su di lui, scorge passare in mezzo ’sta maglia ciclamino de Saronni, che si guarda intorno un po’ perso ed esclama: «Ma ’ndo’ so’ annato? Mi sa che ho sbagliato strada…».
Ecco. È su queste cose che ovviamente si gioca.
Come quella volta in cui ricevetti la telefonata di una signora che, avendo ascoltato un inno nazionale, doveva indovinare che era quello dell’Australia. Era oggettivamente una domanda difficile. «Signora, ha capito di quale Paese fosse l’inno?» «No.» «Guardi, la aiuto. È l’inno del Paese dove vive l’animale con la borsa… che animale è?» Silenzio. Poi prova: «Leono?». «No, signora. Non ce lo vedo il re della foresta con la borsetta. Riprovi!» E così è partita con una serie di animali («eliofanto», «zepra» e simili) che, ovviamente, non c’entravano nulla. Dopo una decina di minuti, abbiamo raggiunto una specie di compromesso, arrivando a formulare la parola «canghr», che sembrava un po’ il codice fiscale della bes...