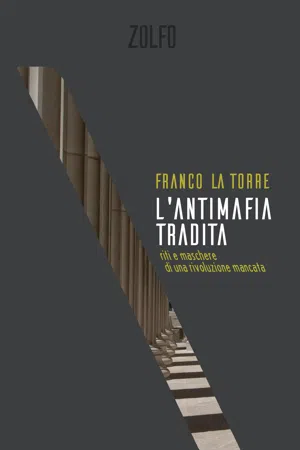
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Ha venticinque anni quando suo padre, Pio La Torre, viene ucciso da Cosa nostra, il 30 aprile 1982. Franco La Torre a metà degli anni Novanta raccoglie il testimone dalla madre e si assume, come impegno quotidiano, di continuare la battaglia contro il sistema di potere politico-mafioso.
In questo libro ci sono l'antimafia storica e quella contemporanea. Passata con il tempo l'emozione per gli omicidi eccellenti in Sicilia e le stragi dell'estate 1992, oggi l'antimafia ha smarrito la sua natura, fatica a riconoscere il nemico che ha cambiato pelle e non si manifesta più all'esterno con la violenza delle armi. Da qui il racconto di come la mafia – grazie al silenzio di uomini politici, giornalisti, imprenditori, magistrati, associazioni – si sia persino mascherata da antimafia.
Tra queste pagine c'è anche l'atto di accusa contro un'antimafia che ha tradito il mandato originario, che si è chiusa in se stessa, sempre più consociativa e addomesticata. Eppure, in fondo a questa inquietante vicenda, Franco La Torre intravede una luce e un futuro per un'antimafia che non sia narrazione di singoli eroi ma parte della più generale battaglia per la difesa della democrazia in Italia.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a L'antimafia tradita di Franco La Torre in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Biografie nell'ambito delle scienze sociali. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Capitolo terzo
L’attesa della sentenza della Corte di Cassazione per il maxiprocesso si conclude il 30 gennaio 1992 ed è segnata da una tragica serie di omicidi. Nel gennaio 1988 viene ucciso Giuseppe Insalaco, l’ex sindaco democristiano che per la prima volta fece affiggere a Palermo manifesti del Comune con la parola mafia. Nello stesso mese, l’agente della Polizia di Stato Natale Mondo, collaboratore di Ninni Cassarà, un abile investigatore, infiltrato nelle cosche mafiose. A settembre l’assassinio di due magistrati: Alberto Giacomelli, presidente della sezione delle misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, che aveva fatto confiscare i beni del fratello di Totò Riina, che ne ordinò l’eliminazione, e Antonino Saetta. Il giudice Saetta, già impegnato alla fine degli anni Settanta a Genova in importanti processi contro le Brigate rosse, era presidente della Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta nel processo per la strage in cui morì il giudice Rocco Chinnici – dove vennero comminate condanne più pesanti di quelle del primo grado ai mafiosi, tra cui i Greco, semplici incensurati ai vertici di Cosa nostra – e, successivamente, presidente della Corte d’Assise d’Appello di Palermo di quello sull’uccisione del capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, imputati alcuni boss del calibro di Armando Bonanno, Giuseppe Madonia e Vincenzo Puccio. Antonino Saetta fu ucciso, trascorsi pochi giorni dal deposito della sentenza di ergastolo degli imputati, insieme al figlio Stefano. Era la prima volta che la mafia uccideva magistrati giudicanti, uno di seguito all’altro.
Il giorno successivo, il 26 settembre, Mauro Rostagno, leader del movimento studentesco del Sessantotto e di Lotta Continua. Nel 1981 aveva fondato a Lenzi, in provincia di Trapani, la comunità terapeutica Saman. A metà anni Ottanta, giornalista e conduttore dell’emittente televisiva locale Rtc, realizza inchieste sul sistema di potere mafioso, intervista Paolo Borsellino e Leonardo Sciascia, e, mentre segue il processo sull’omicidio di Vito Lipari, sindaco democristiano di Castelvetrano, imputati i boss Nitto Santapaola e Mariano Agate, quest’ultimo gli manda a dire di dire meno minchiate su di lui. Rostagno, seguendo il suo fiuto, animato da una forte passione, si spinge oltre, si affaccia sul baratro dell’invisibile e intravede tracce di massoneria, servizi deviati, traffici d’armi, sino all’ignoto, l’innominabile Gladio. I vertici di Cosa nostra ordinano la sua eliminazione.
Il pubblico ministero Gaetano Paci, durante l’ultimo processo, che condannò all’ergastolo i boss trapanesi Vincenzo Virga e Vito Mazzara, aveva denunciato forti anomalie nelle indagini: «Le prime indagini sull’omicidio di Mauro Rostagno condotte dai carabinieri del Reparto Operativo di Trapani furono scandite da troppe anomalie. In quest’aula abbiamo dovuto inevitabilmente processare certi atteggiamenti delle forze dell’ordine, ma anche di questo palazzo di giustizia, e in generale della città di Trapani. Perché troppe sono state le insufficienze investigative, le omissioni, le sottovalutazioni. Ma anche orientamenti di pensiero di taluni rappresentanti istituzionali dell’epoca naturalmente adesivi verso la presenza della mafia».
Come per Pippo Fava, come per Peppino Impastato, ci furono tentativi di depistaggi e depistaggi consumati e, come successe a Catania, Trapani non reagì.
Nebbie e misteri.
Nino Agostino, agente di polizia e probabilmente collaboratore dei servizi segreti, ucciso con la moglie Ida Castelluccio, indagava sul fallito attentato dell’Addaura contro il giudice Giovanni Falcone che, ai suoi funerali, disse che Agostino gli aveva salvato la vita. Vincenzo Agostino, il padre di Nino, ha smesso di tagliarsi la barba dal 5 agosto 1989, un segno in attesa che giustizia venisse fatta. Ancora oggi è lunga e incolta ma, finalmente, Vincenzo Agostino ha accolto con soddisfazione la richiesta di rinvio a giudizio della Procura generale di Palermo dei boss Antonino Madonia e Gaetano Scotto, accusati di essere gli autori materiali del duplice omicidio.
Arriviamo al 1990.
L’agente di polizia e collaboratore dei servizi segreti Emanuele Piazza, specializzato nella cattura dei latitanti, che fece arrestare il boss Giovanni Sammarco e scomparve da casa il 16 marzo. Per leggere la notizia della sua scomparsa si dovette attendere, dopo sei mesi, l’articolo di Francesco Viviano di «Repubblica». Secondo la ricostruzione dei fatti, Emanuele Piazza era stato ucciso e, successivamente, sciolto nell’acido, perché faceva bene il suo mestiere.
Il dirigente della Regione Siciliana Giovanni Bonsignore aveva ostacolato la creazione del consorzio agroalimentare, un affare da svariati miliardi delle vecchie lire e aveva condotto l’inchiesta amministrativa sul finanziamento irregolare alla cooperativa Il Gattopardo, sospettata di legami con la mafia, il cui vicepresidente era il suo collega Antonio Velio Sprio, condannato per truffa, che ordinò il suo omicidio. Era il 9 maggio.
Rosario Livatino, uomo colto e responsabile, magistrato ad Agrigento, conduce le indagini sugli interessi economici della mafia e sull’intreccio mafia e affari, individuando il sistema della corruzione, la cosiddetta Tangentopoli siciliana. Sino al 21 settembre, quando fu ucciso. Era senza scorta per scelta, non voleva che altri rischiassero la vita insieme a lui. La sentenza di condanna degli esecutori e dei mandanti del suo omicidio indica che è stato ucciso perché «perseguiva le cosche mafiose impedendone l’attività criminale, laddove si sarebbe preteso un trattamento lassista, cioè una gestione giudiziaria se non compiacente, almeno, pur inconsapevolmente, debole, che è poi quella non rara che ha consentito la proliferazione, il rafforzamento e l’espansione della mafia».Il 21 dicembre 2020, Papa Francesco ha promulgato il decreto che lo dichiara beato martire.
Nel 1991 viene ucciso a Palermo l’imprenditore Libero Grassi. Si era ribellato al racket e, contro l’omertà di tutti gli esponenti di Confindustria palermitana, aveva denunciato i suoi aguzzini.
«Caro estortore – scrisse in una lettera pubblicata dal “Giornale di Sicilia” –, volevo avvertire il nostro ignoto estortore di risparmiare le telefonate dal tono minaccioso e le spese per l’acquisto di micce, bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia. Ho costruito questa fabbrica con le mie mani, lavoro da una vita e non intendo chiudere… Se paghiamo i 50 milioni, torneranno poi alla carica chiedendoci altri soldi, una retta mensile, saremo destinati a chiudere bottega in poco tempo. Per questo abbiamo detto no al “Geometra Anzalone” e diremo no a tutti quelli come lui».
Gli imprenditori di Palermo Libero Grassi lo isolano. Gli dicono: «I panni sporchi si lavano in casa», «c’è chi ha voglia di protagonismo», «se paghiamo tutti paghiamo di meno». Libero Grassi viene ucciso il 29 agosto e qualche mese dopo il governo vara il decreto-legge n. 419, convertito in legge n. 172/92, che istituisce il Fondo di solidarietà in favore delle vittime di richieste estorsive e di usura. Un morto, un provvedimento di legge. Il suo sacrificio non è vano. Più avanti nascerà Addiopizzo, e, secondo Eurispes, nella società italiana si fa strada una nuova consapevolezza circa lo stretto rapporto tra mafia e disimpegno: il 29 agosto del 1991, secondo l’istituto di ricerca, nasce l’eroe normale, il cui rigore morale individuale diviene, nella latitanza di personaggi pubblici carismatici, punto di riferimento sostanziale a cui affidare la difesa del bene comune, in ragione di una crisi istituzionale, politica e criminale, cominciata negli anni del riflusso e che, agli inizi degli anni Novanta, diventa emergente.
Il paradosso dell’antimafia è che si è nutrita della violenza della mafia per svilupparsi. La mafia dei Corleonesi, che spara, ammazza, mette bombe e fa stragi. Allo stesso tempo, non ha saputo guardare oltre, si è fermata a Totò Riina e alla sua strategia stragista. Le sono mancati gli strumenti per capire che la mafia e il sistema di potere di cui è parte, sbattuti in carcere i boss di Corleone, stavano cambiando. La mafia è un fenomeno, che non ha mai smesso di evolversi, per adeguarsi alla realtà e trarre profitti, sempre maggiori, in grado di condizionare politica, economia e mercato. Il periodo dei Corleonesi è una breve parentesi nella lunga storia della mafia. La mafia preferisce invisibilità, silenzio e chi sa non ha alcun interesse a parlare, ne andrebbero di mezzo gli affari e gli interessi politici, che legano tutto e tutti. Anche all’estero è così e funziona benissimo. Così accadde il 15 agosto 2007 a Duisburg, per fare un esempio, dove sei vittime della faida di San Luca svelano la presenza della ’ndrangheta in Germania: dopo lo sdegno e la condanna, la ’ndrangheta s’inabissa e si torna agli affari come al solito.
Le stragi producono un effetto collaterale inconcepibile, paradossalmente risvegliano le coscienze. Sono molti a ricordarsi dove fossero, cosa facessero i giorni delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Arriva a maturazione un processo iniziato anni prima, che canalizza le energie e la forza delle mille associazioni antimafia sparse per la penisola. Come in una morsa a tenaglia, il movimento affianca l’attacco dello Stato contro Cosa nostra. Questa volta la reazione dello Stato non è stata effimera. Non si è esaurita in una iniziativa legislativa o in una fiammata di arresti, ma è proseguita negli anni.
Il 15 gennaio 1993 viene arrestato il «capo dei capi» Totò Riina. Proprio quel giorno Gian Carlo Caselli si insedia al vertice della Procura di Palermo. L’arresto di Totò Riina non sarà l’unico successo del gruppo guidato da Caselli che, come ha raccontato il magistrato Alfonso Sabella nel suo libro Cacciatore di mafiosi, preparerà una lista di latitanti con i nomi che, con una sorta di rito, vengono cancellati al momento dell’arresto con un tratto di stilografica dall’inchiostro verde. E quando il giudice Caselli se ne andrà da Palermo, con molti nomi cancellati dalla lista, la caccia ai latitanti continuerà senza sosta, tanto che si può parlare di un periodo che inanella successi dal gennaio 1993 fino all’11 aprile del 2006, con la cattura di Bernardo Provenzano.
In questo ampio lasso di tempo, forse mai troppo raccontato nei dettagli, si assiste anche al consolidamento dell’antimafia civile. Il segnale evidente della nuova forza del movimento è l’istituzione della ricorrenza del 21 marzo, cui ho già fatto cenno nelle pagine precedenti, la giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Il primo giorno di primavera le si ricorda tutte, nome per nome e tutti insieme si rinnova e si rilancia l’impegno antimafia. Così, la memoria di quelle vittime diventa un fatto nazionale. Ogni anno, infatti, una città diversa ospita la manifestazione dove viene recitato il lungo elenco di nomi. «Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai» è scritto sul sito di Libera, che ha ideato, promosso e organizzato la giornata della memoria e scelto il 21 marzo come data.
Il 21 marzo 1996 viene celebrata la prima giornata della memoria nella piazza del Campidoglio a Roma, alla presenza del presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Bisognerà aspettare fino al primo marzo 2017 per vedere la Camera dei deputati approvare la proposta di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo quale «Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie». Originariamente, la proposta definiva le vittime innocenti, aggettivo scomparso dalla formulazione finale. Sul termine «innocente» il percorso di approvazione si era incagliato e rischiava di mandare tutto all’aria. Di cosa parliamo? Il solito balletto, la solita fumisteria della politica? Quelli addentro alle segrete cose raccontano che la questione era sorta quando era stato fatto notare che alcune vittime uccise dalla mafia, pur non facendone parte, avevano avuto con questa rapporti, difficilmente definibili innocenti o inconsapevoli. Così si preferì eliminare il termine, per non far torto a qualcuno. Una giornata importante dal punto di vista simbolico, nel quale confluisce una lunga attività di promozione, che traccia il percorso verso il 21 marzo, coinvolgendo altre associazioni, scuole e organizzazioni. Questo lavoro rafforza i legami, fa conoscere le persone, sprigiona altre energie.
La prima iniziativa nazionale di Libera è la raccolta di firme a sostegno della legge d’iniziativa popolare per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia. Un segno inequivocabile, che aprirà la strada a un nuovo tipo d’impegno, la gestione di questi beni come strumento di affrancazione dal potere mafioso e la promozione del lavoro dignitoso e di aziende socialmente responsabili. Un insulto alla mafia, che esibiva quei beni a conferma del suo potere e ne faceva strumento di oppressione, manipolazione e violazione dei diritti al lavoro e a fare impresa. Un nuovo tipo d’impegno che ha permesso a tante associazioni e cooperative d’intraprendere il percorso e rafforzare il movimento. Quando, alla fine degli anni Duemila, Libera promosse l’assemblea nazionale dei soggetti che gestivano beni confiscati, furono circa 500 le associazioni, le cooperative e altri enti pubblici e privati che intervennero e, probabilmente, ne mancavano altri. Un patrimonio diffuso di saperi e conoscenze, perché prendere in gestione un bene confiscato non è una passeggiata.
Esemplare è la vicenda della più grande azienda agricola confiscata alla mafia. Non si trova in Sicilia ma in Toscana. Se ci fosse ancora bisogno di una conferma del radicamento delle mafie fuori dai territori ritenuti tradizionalmente mafiosi, eccone la prova. Se poi fossimo interessati ai dati generali e non al singolo caso, leggiamo quelli relativi all’anno 2020, secondo i quali ci sono più aziende controllate dalla mafia in Emilia-Romagna che in Sicilia. L’azienda è quella di Suvignano, una tenuta di 713 ettari tra i comuni di Monteroni d’Arbia e Murlo, in provincia di Siena, che dal 2018 è stata restituita alla comunità. Il sequestro risale al 1983 e la confisca definitiva al 2007. La tenuta era stata sequestrata all’imprenditore palermitano Vincenzo Piazza, sospettato di aver rapporti con Cosa nostra, che ne rientrò successivamente in possesso sino a quando, tra il 1994 e il 1996, arrivò il secondo sequestro, assieme a un patrimonio di ben duemila miliardi di vecchie lire, affidato alla gestione di un amministratore giudiziario. Per anni quel bene galleggiò nel dissidio amministrativo tra chi dovesse gestirlo. Nel settembre 2013, ho dato il mio piccolo contributo, su invito dell’Arci, partecipando alla manifestazione a Suvignano per rilanciare l’attività dell’azienda e sollecitare gli enti pubblici coinvolti a fare la loro parte. La tenuta ha rischiato di essere venduta tutta o a pezzi fino a quando non è intervenuta la Regione Toscana, affidandone la gestione all’Ente Terre, eleggendola a simbolo dei beni mafiosi restituiti alla collettività. Simbolo che nella notte del 16 agosto 2020 è andato a fuoco, un capannone agricolo è stato incendiato, distruggendo 250 quintali di seme d’erba medica e trifoglio e 700 rotoballe, stimati ottocentomila euro di danni. Questo della gestione dei beni confiscati, in particolare delle aziende, è un aspetto dell’azione antimafia non risolto nel modo adeguato. L’argomento meriterebbe un libro a parte. Mi limito ai fatti essenziali. La magistratura applica un’efficace strumentazione giuridica, che permette la confisca preventiva, anche senza sentenza, per togliere ai mafiosi la gestione del bene. Poi arriva la fase di gestione. L’Agenzia che si occupa dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è stata creata nel 2010.
«La gestione e la destinazione dei beni oggetto di misure ablatorie, nell’ambito del sistema di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, e il ruolo svolto dall’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla mafia, Anbsc, [...]evidenziano problemi e difficoltà [...] Le prime riflessioni critiche vanno rivolte al quadro legislativo in materia di misure di prevenzione e di contrasto alla criminalità di stampo mafioso, caratterizzato dalla produzione, talora...
Indice dei contenuti
- Franco La Torre
- Introduzione
- Capitolo primo
- Capitolo secondo
- Capitolo terzo
- Capitolo quarto
- Capitolo quinto
- Appendice
- Le storie