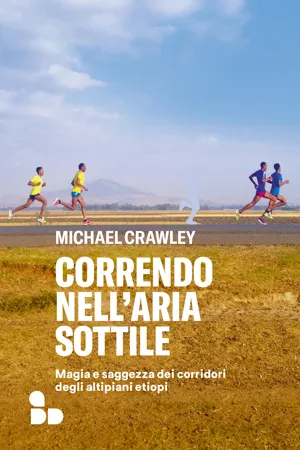
eBook - ePub
Correndo nell'aria sottile
Magia e saggezza dei corridori degli altipiani etiopi
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Correndo nell'aria sottile
Magia e saggezza dei corridori degli altipiani etiopi
Informazioni su questo libro
Per quindici mesi, Michael Crawley si è allenato in Etiopia correndo a fianco di atleti di tutti i livelli, da guardiani notturni speranzosi di cambiare le proprie vite a maratoneti di caratura mondiale, mosso da un'unica voglia: capire quale sia la forza, antica e potente, che la corsa alimenta in quella regione dell'Africa. Perché per i corridori etiopi ha senso alzarsi alle 4 del mattino e allenarsi a 3000 metri di altezza? Perché pur di farlo corrono su un terreno ripido, roccioso e infestato dalle iene? E qual è il modo migliore di correre in una foresta?
Correndo nell'aria sottile unisce sport e antropologia nel racconto di un mondo fatto di visioni, miti e leggende, fra allenamenti e sfide, destini e grandi imprese. Con la speranza di essere chiamati a una gara internazionale e di chiuderla con un tempo memorabile che permetta di entrare nel numero di "quelli che ce l'hanno fatta".
Il resto è fatica, piacere, respiro.
È passione che muove le vite.
Questo libro tocca il cuore e l'anima della corsa in Etiopia. – Haile Gebrselassie
Pieno di meravigliose intuizioni e di cose da imparare da un mondo in cui la capacità di correre è qualcosa di magico e misterioso. – Adharanand Finn
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Correndo nell'aria sottile di Michael Crawley, Paolo Falcone in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Editore
ADD EditoreAnno
2022Print ISBN
9788867833511eBook ISBN
9788867833757SAREI POTUTO DIVENTARE UN SUONATORE DI MESINKO
Arrivo in Etiopia alle due del mattino del 14 settembre 2015, e dal punto in cui mi trovo – accanto al nastro trasportatore bagagli dell’aeroporto – vedo un paio di cartelloni pubblicitari con Haile Gebrselassie, il corridore più famoso d’Etiopia e probabilmente il più celebre etiope al di fuori del suo Paese, che reclamizza due tipi diversi di “lubrificanti”, uno per la Total e l’altro per Johnnie Walker. Gli slogan: «Fai del tuo motore un atleta della strada» e «Va’ avanti. Continua a camminare». Dato che sono venuto in Africa per studiare i collegamenti tra la corsa sulla lunga distanza e le idee sul progresso, sul movimento propulsivo e sullo “sviluppo”, i due cartelloni mi appaiono entrambi calzanti. L’addetta ai visti d’ingresso è mezza addormentata, ma si rianima quando uso una delle poche frasi in amarico che ho imparato da poco per dirle che sono un runner.
Dopo aver recuperato la borsa – contenente per lo più un mucchio di taccuini e scarpe da corsa alla rinfusa – apro lo screenshot con le istruzioni per raggiungere l’abitazione del dottor Benoit Gaudin, un professore dell’università di Addis Abeba che ho conosciuto qualche mese fa a una sua conferenza, intitolata East African Running: The Social Science Perspective. Benoit si è offerto di ospitarmi per qualche settimana in attesa che mi ambienti. Gli ultimi giorni sono stati un po’ frenetici in quanto io e la mia compagna – Roslyn, anche lei antropologa, trascorrerà un anno nel Somerset per studiare i benefici dell’ippoterapia sui bambini affetti da autismo – abbiamo liberato i nostri appartamenti a Edimburgo prima di dedicarci alle rispettive ricerche. Entrambi svolgeremo gran parte del nostro lavoro sul campo. Non ho avuto il tempo di studiare la mail di Benoit, e adesso, mentre la leggo uscendo dall’aeroporto per cercare un taxi in piena notte, sono pentito di non averlo fatto.
La mail dice: «Di’ al tassista di portarti all’ambasciata tedesca, poi di girare a destra e di imboccare la salita. Quando la strada asfaltata finisce, digli di svoltare a sinistra sul selciato. Probabilmente dovrai insistere, perché non vorrà portarti lassù. Poi girate a destra, a sinistra e quindi di nuovo a destra fino a che non vi trovate davanti a un cancello giallo. Prima di scendere dall’auto aspetta che arrivi la guardia di sicurezza, di notte qui intorno ci sono le iene». C’è pochissimo traffico a quest’ora, così procediamo rapidi su strade fiancheggiate da negozi di lamiera ondulata dai colori vivaci e qualche bar illuminato da luci al neon. Di tanto in tanto ci imbattiamo, con mia sorpresa, in alcuni runner che corrono in fila indiana in gruppi di due o tre. Appaiono per un istante sotto il bagliore dei fari e poi svaniscono, e mi chiedo cosa li spinga ad allenarsi a quest’ora della notte.
Una ventina di minuti dopo il tassista mi comunica che abbiamo raggiunto l’ambasciata tedesca e così gli indico la salita. Ho imparato a dire “gira a sinistra” e “gira a destra” in amarico – wada gra e wada ken –, e spero che il tipo non abbia bisogno di istruzioni più dettagliate. Non sembra entusiasta del selciato – scoprirò presto che neppure i runner lo sono – ma almeno procede abbastanza lentamente da permettermi di distinguere il colore dei cancelli nell’oscurità, e quando arriviamo davanti a quello giallo indicatomi da Benoit gli dico di fermarsi. Lui suona il clacson, un suono sorprendentemente forte nella quiete della notte, e trenta secondi dopo una guardia munita di torcia apre il cancello e mi accompagna al mio alloggio – una capanna esterna occupata in passato da un’altra guardia – mentre respinge le attenzioni del suo cane.
Benoit esce sul balcone per darmi il benvenuto prima di tornare a letto, e poco dopo mi infilo nel sacco a pelo e attendo di addormentarmi. Comincio già ad avvertire gli effetti dell’altitudine, ogni due minuti il corpo sembra percepirla e così faccio un respiro profondo. Il sonno è irregolare e leggero, disturbato dall’aria rarefatta e dalle improvvise esplosioni di latrati dei cani del vicinato che fiutano l’odore delle iene le quali, furtive, scivolano verso la città. La capanna ha solo una finestra minuscola ed è immersa nel buio; mi sveglio un paio di volte chiedendomi dove mi trovo.
Essere un antropologo vuol dire cercare di narrare in maniera convincente le storie altrui, e per fare ciò è necessario un impegno a lungo termine verso il luogo e le persone che si vogliono raccontare. Nel mio caso questo significherà, nei limiti del possibile, stare a stretto contatto con gli atleti di cui voglio capire la vita, impegnarmi a mangiare e a rilassarmi con loro dopo aver corso e soprattutto a soffrire al loro fianco durante gli allenamenti. L’etnografia è il metodo di ricerca su cui si definisce l’antropologia: deriva dai termini latini “cultura” e “scrittura”, e probabilmente la sua traduzione migliore è “descrizione del popolo”. Per riuscire nel mio intento dovrò ricorrere alla cosiddetta “osservazione partecipante” (o “profonda frequentazione”, come l’ha brillantemente definita l’antropologo James Clifford), un metodo che consiste soprattutto nel passare molto tempo con le persone, osservandole, parlando con loro e costruendo rapporti di fiducia reciproci.
Loïc Wacquant, il sociologo francese che per anni ha scritto sulla boxe praticata nel ghetto di Chicago, osserva che per svolgere bene questo tipo di ricerca in un contesto sportivo dovremmo pensare più in termini di “partecipazione osservante” che di “osservazione partecipante”. In altre parole, c’è molto più da imparare sul quadrato che a bordo ring. All’atto pratico, però, sono consapevole che non sarà affatto facile. Come riflette l’antropologo Michael Jackson, osservare e nello stesso tempo partecipare equivale a stare in un fiume guardandolo contemporaneamente dalla riva o, nel mio caso, correre con il gruppo e studiarlo dal pullman della squadra. Inoltre, al momento non sono neanche lontanamente veloce come gli atleti con cui mi allenerò. Il mio miglior tempo in una mezza maratona è di 66 minuti, quello degli altri è inferiore di quattro-otto minuti.
Tim Ingold, che all’inizio della sua carriera ha condotto uno studio sulle tecniche di inseguimento e caccia presso gli skolt – una popolazione sami del nord della Finlandia – sostiene invece che la distinzione tra osservazione e partecipazione non sussiste. «Osservare», scrive, «significa guardare quello che accade intorno a noi, e ovviamente anche ascoltare e percepire; partecipare significa farlo immersi nel flusso di attività quotidiane condotte accanto e insieme alle persone e alle cose che attirano la nostra attenzione».1 All’indomani del mio arrivo in Etiopia spero di trovare qualcuno con cui correre: voglio essere travolto dal “flusso di attività” prima possibile.
La foresta si trova da qualche parte in cima alla salita, così alle sei del mattino esco di casa e mi incammino sul selciato. Chi è sulla mia stessa strada, con testi scolastici sottobraccio o valigette strette in una mano, sembra andare nella direzione opposta con una certa fretta. I pochi che stanno risalendo si muovono con lentezza; quasi tutti indossano uno shamma bianco e sono diretti in chiesa, ma un paio sono in tuta da ginnastica come me. Almeno so che sto andando nella direzione giusta.
In prossimità della chiesa superiamo, e in alcuni casi quasi inciampiamo su uomini in diverse posizioni di preghiera: a causa di vari tabù alimentari e sessuali solo una piccola parte dei cristiani ortodossi etiopi si considera abbastanza pura da entrare in una chiesa, e così molti restano fuori con la fronte rivolta verso gli alberi nel sagrato o si tengono alle inferriate che circondano la struttura. Come i fedeli, anche i runner vengono quassù per sfuggire al caos e alla frenesia della vita di città. Mi sovviene un frammento di un’intervista che Haile Gebrselassie rilasciò proprio in questa foresta: «Quassù mi alleno duramente», disse al giornalista, «ma è nulla in confronto a ciò che alcune persone più a valle devono sopportare». Sono in Etiopia per capire come vivono coloro che alle difficoltà della vita quotidiana in città preferiscono una diversa forma di fatica sulle colline e nelle foreste.
La strada acciottolata termina davanti alla chiesa, dove cede il posto a una distesa di erba corta e ispida e all’inizio del bosco di eucalipti che si estende per diversi chilometri verso nord, ma la salita continua a perdita d’occhio tra gli alberi. Faccio una pausa per riprendere fiato e mi sento il polso con le dita: quasi cento battiti, e per ora ho solo camminato. Comincio a correre su un sentiero indistinto e, nell’aria rarefatta, il mio respiro si fa quasi subito irregolare, ma non voglio fermarmi, così mi volto di lato e proseguo perpendicolare alla salita. Un paio di minuti dopo vedo i due runner in tuta che avevo notato prima procedere in fila indiana insieme ad altri cinque o sei atleti. Il corridore in testa, in una sgargiante calzamaglia viola e un giacchetto rosso, indica la fila alle sue spalle quando mi passa davanti. «Andiamo!» urla nella mia lingua.
Avevo immaginato di metterci un po’ a trovare qualcuno con cui correre, e sono piacevolmente sorpreso dal fatto che ci sono invece voluti cinque minuti. Mi accodo al gruppo, alle spalle di un ragazzo con una logora tuta Adidas, e dopo un po’ mi scopro a mettere i piedi dove li mette lui per cercare di evitare i ciuffi di erba più folti. Mi adatto senza problemi al ritmo del gruppo, la cui andatura per fortuna non è troppo veloce. Risaliamo il pendio seguendo un percorso a zigzag: questo vuol dire che non percorriamo i tratti più ripidi, ma anche che siamo costantemente inclinati. Ciononostante, man mano che ci avviciniamo alla vetta della collina, comincio ad accusare la pendenza e mi stacco di qualche metro dal corridore che mi precede. Questo divario aumenta con il passare dei metri, e decido che siccome si tratta della prima corsa in Etiopia forse è il caso di prendermela più comoda e di continuare alla mia andatura: proseguo dritto mentre gli altri effettuano l’ennesima svolta.
Prima che me ne renda conto, la fila di runner mi affianca e qualcuno mi afferra per un polso riportandomi al mio posto nelle retrovie. «Corriamo insieme», mi dice. Mi rassegno a seguire il gruppo e il pifferaio magico in calzamaglia viola, come meglio posso. Ogni volta che quest’ultimo vede una roccia o una grossa radice sul terreno schiocca le dita dietro la schiena per avvisare l’atleta alle sue spalle, che a sua volta fa lo stesso con l’atleta che segue, e così via fino a quello che mi precede. Questa successione di schiocchi è l’unica comunicazione all’interno del gruppo finché non incrociamo un podista che va nella direzione opposta. Ha uno stile di corsa insolito – corre piegato in avanti – e il runner in calzamaglia viola gli dice qualcosa che fa ridere tutti. «Che ha detto?» chiedo al ragazzo davanti a me il cui nome, scoprirò dopo, è Tilahun. «Ha detto: “Hai perso qualcosa?”», risponde lui, prima di piegarsi in avanti in modo esagerato. «Perché corre sempre così!»
Nel frattempo abbiamo raggiunto un terreno più aperto in cima alla collina e continuiamo a correre sui campi coltivati e attraverso alberi di eucalipto più radi. Le falcate degli atleti che mi precedono aumentano man mano che il paesaggio si apre, e mi accorgo che perdo sempre più terreno a ogni svolta e io sono costretto ad anticiparle per recuperare il ritardo. Mi accorgo però che mi sto divertendo molto, era tanto tempo che non mi allenavo in gruppo. Quando la fila mi passa accanto nella direzione opposta, gli atleti mi gridano: «Ayzoh!», che significa qualcosa tipo “Animo!” o “Su con la vita!”. È un’espressione tanto di solidarietà quanto di incoraggiamento, e me la sentirò rivolgere spesso durante il mio soggiorno in Etiopia mentre provo a tenere il passo degli atleti locali.
Dopo aver accelerato l’andatura fino a uno sprint, con i primi divari che hanno cominciato a intaccare la precisione quasi militaresca della fila, la corsa si interrompe. È durata un’ora, esatta. Ci raggruppiamo e raggiungiamo a passo leggero la chiesa più a valle, dove formiamo un cerchio e facciamo un po’ di stretching. Tilahun ha alcune domande per me: da dove vengo, cosa ci faccio in Etiopia e in quanto tempo corro dieci chilometri. Poi mi chiede: «Perché volevi correre da solo?» Gli spiego che ero stanco, che non volevo rallentarli e che preferivo andare alla mia andatura.
«Ti alleni da solo per motivi di salute», ribatte lui. «Per migliorare devi correre con gli altri, devi adattarti alla loro andatura, non correre da solo». Queste parole mi resteranno scolpite nella mente nei mesi successivi. Correre in proprio – come mangiare o anche soltanto sedere da soli – è considerato un comportamento antisociale e al limite del sospetto in Etiopia. Mentre facciamo stretching imitando i movimenti dell’atleta in calzamaglia viola vediamo una coppia di americani un po’ sovrappeso in pantaloncini, t-shirt e scarpe da ginnastica. «Mi sa che sono turisti», dice Tilahun. «Loro corrono per la salute e per l’aria buona, noi per i risultati. Pensiamo di continuo a come modificare i nostri tempi». Si afferra la fronte fingendo angoscia. «Come posso modificarli? Come? Ecco perché a volte corriamo fino a svenire». Scoppia a ridere. «Se tu corri solo per la salute, non hai nulla di cui preoccuparti!»
Non sono ancora le otto quando scendiamo a valle, ma le temperature si stanno già alzando. Tilahun mi domanda dove andrò ad allenarmi domani. «Tornerò alla foresta, non mi sembra male», rispondo. Lui aggrotta le sopracciglia e scuote la testa. «Devi sfruttare al massimo i diversi posti, l’ambiente può insegnarti molto.» Mi dice che andrà a fare una corsetta a Entoto per trarre beneficio dall’“aria speciale” della montagna, e aggiunge che per avere successo è importante adattarsi ai vari luoghi intorno alla città e alle differenti condizioni dell’aria, e sfruttare al meglio tutte le superfici e le pendenze disponibili per correre.
«L’atletica è uno sport collettivo», ribadisce. «Devi sfruttare l’ambiente, devi correre in salita e in discesa». Indica la collina alle sue spalle. «Se resti qui e ti alleni con noi e sfrutti tutti i posti intorno a Addis avrai successo». Ci salutiamo dandoci appuntamento di lì a un paio di giorni. Per me un’ora di corsa è ancora soltanto un’ora di corsa. Non mi importa molto dove corro e al momento non me la sento di svegliarmi alle cinque per attraversare tutta la città. Mentre torno a casa, però, penso a ciò che Tilahun mi ha detto sul lavorare con l’ambiente e con gli altri, temi che diventeranno sempre più importanti nel prosieguo del soggiorno etiope.
La mia routine quotidiana durante le prime settimane comincia alle sei del mattino, quando raggiungo la foresta per correre con Tilahun o qualche altro runner che nel frattempo ho conosciuto. All’inizio l’orario è motivo di una certa confusione, perché per gli etiopi le sei del mattino sono le “dodici”, le sette l’“una”, le otto le “due” e così via. Ai tempi della Bibbia era consuetudine misurare la giornata partendo dalle sei del mattino, e la maggior parte degli etiopi ancora oggi fa così. Dal momento che l’Etiopia si trova all’equatore ha senso cominciare a contare le ore allo spuntare del sole, e anche per un runner sembra intuitivo misurare il tempo in questo modo, valutarlo cioè in termini di prima opportunità di correre alla luce del giorno. Questa non è l’unica idiosincrasia temporale dell’Etiopia. L’anno etiopico ha un tredicesimo mese – pagume – e il calendario (in ritardo di sette, otto anni rispetto al nostro, perché i cristiani ortodossi non concordano sull’anno di nascita di Gesù) inizia a settembre anziché a gennaio. Qui, dunque, non sono solo i corridori ad avere un rapporto diverso con il tempo.
Di ritorno dall’allenamento, passo il resto della mattina a prendere appunti e a leggere, di solito con Cléophée addormentato sulle mie ginocchia, il gatto di Benoit, che ha avuto la grande fortuna di passare da un appartamento parigino a un vasto territorio in un Paese con la fauna avicola più diversificata del pianeta. Correre e scrivere è una combinazione che funziona abbastanza bene per me. Norman Mailer, riflettendo sul tentativo di fare jogging con Muhammad Ali, riteneva che scrivere e correre fossero attività incompatibili. «Chi desiderava che la vivacità della mente si scaricasse attraverso le caviglie?», si chiedeva.2 Io trovo invece che la piacevole sensazione di stanchezza successiva alla corsa mi renda più propenso a concentrarmi sulla scrittura e meno incline a soccombere ad altre distrazioni. Il pomeriggio prendo un paio di “taxi” – di solito minibus Toyota da dodici posti con una ventina di passeggeri stipati al loro interno – fino a un caffè ad Arat Kilo, un quartiere dall’altra parte della città, per le mie lezioni di amarico con Mimmi Demissie, un’insegnante consigliatami dal mio buon amico Diego Malara, un antropologo che ha trascorso due anni a Addis Abeba per studiare il cristianesimo ortodosso locale.
Anche queste lezioni si sono trasformate subito in prove di resistenza. Se chiedo una pausa, Mimmi dice: «Diego farebbe due ore filate, poi fumerebbe cinque sigarette, e proseguirebbe per altre due ore. Devi impegnarti di più». Faccio del mio meglio per restare concentrato per tre ore, alimentato da infinite tazze di caffè che la cameriera di turno mi versa dalla tradizionale jabenna, prima di tornare a casa in taxi. L’amarico è una lingua dal suono meraviglioso con un interessante alfabeto composto da trentatré caratteri che possono essere scritti ciascuno in sette modi diversi. È dotato di una grammatica complessa, con singole parole che racchiudono intere costruzioni sintattiche. Mediante l’aggiunta di un prefisso, di un suffisso o di qualcosa chiamato infisso – un fonema o una sillaba inserita all’interno della radice di una parola – un unico termine amarico può sintetizzare una frase intera. In Etiopia il saluto più comune è “Tena yistiligne”, letteralmente “Possa egli [Dio] donarti salute da parte mia”. Tena significa salute, mentre yistiligne racchiude le restanti sei parole. Al termine delle lezioni con Mimmi ho spesso mal di testa.
Quando rincaso, spero che Valerie, Solal e Flore – la moglie e le figlie di Benoit – abbiano voglia di parlare in inglese per risparmiare a me stesso – e a loro – il mio francese arrugginito e ormai sovraccarico di caffeina. Mi rendo via via conto che nel cervello ho spazio solo per una lingua straniera e che le parole amariche stanno soppiantando quelle francesi. In serata io e Benoit – che sembra felice di chiacchierare anche in un misto di francese e amarico – sediamo sul balcone del suo appartamento, da cui si gode una delle migliori viste su Addis Abeba, ci facciamo una St George – una birra meglio nota come Giorgis – e discutiamo di corsa e scienze sociali.
Spesso l’Occidente ha una visione idealizzata dei podisti etiopi e kenioti – bambini che vanno a scuola a piedi nudi attraversando altipiani in quota e uomini o donne che “fuggono dalla povertà” –, ma Benoit ci tiene a sottolineare che in Etiopia non sono i più poveri tra i poveri a dedicarsi alla corsa.
«I runner devono es...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- Una nota sui tempi e sulle scarpe
- Aria speciale
- Sarei potuto diventare un suonatore di mesinko
- Seguire i piedi degli altri
- Tutto bene, finora
- Campo dei sogni
- Zigzagando fino in cima
- Matto è buono
- Vincere a Roma sarebbe come vincere mille volte
- Perché ha senso correre su e giù per una collina alle tre del mattino
- Da dove viene l’energia
- Il gioco vale la candela
- Prendere l’aria
- Certo che stanno cercando di ammazzarsi a vicenda
- Correre è vita
- Ringraziamenti