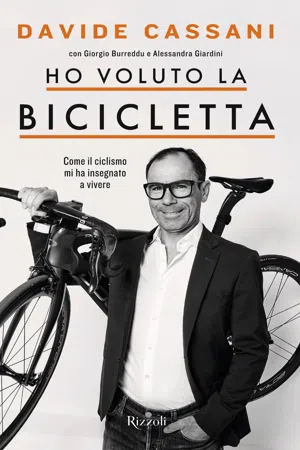«Davide, quante volte te lo devo dire, vai piano!»
Mia madre non aveva ancora finito di pronunciare la frase che io ero già arrivato in fondo alla carraia, e avevo sollevato così tanta polvere che da casa non avrebbero potuto vedermi comunque. Senza che nessuno se ne accorgesse mi ero infilato la maglia della Carrozzeria Spada di Solarolo, la mia prima squadra. Correvo con gli amatori perché il babbo era stato chiaro: niente ciclismo vero fino ai quattordici anni. E io ne avevo ancora tredici. Ma quello era un giorno importante, quello della mia prima gara.
Ero partito presto per evitare che, vedendomi ciondolare con le mani in mano nel cortile, a qualcuno venisse in mente di farmi fare qualche lavoretto. Non volevo rischiare di arrivare tardi alla partenza di Voltana, un paesino a venti chilometri da casa. Ma ero decisamente in anticipo: mancavano ancora quattro ore al via, e avevo deciso di fare un giro per scaldarmi con la mia Valla. Era bellissima. Grigia, con il cambio Campagnolo, la sella nera, i freni Universal, il manubrio basso, due moltipliche e cinque ingranaggi dietro. A essere sincero, non era proprio mia: l’avevo ereditata da mio fratello Fabio, che aveva quattro anni più di me. Quando ne aveva compiuti quattordici, il babbo una sera gli aveva portato a casa la bici e il giorno dopo lo aveva iscritto alla Solarolese.
Il nostro era un paese piccolo, ma la Solarolese la conoscevano tutti perché era stata la squadra di Pipàza Minardi, che aveva vinto sei tappe al Giro d’Italia, oltre a un Giro del Piemonte e a uno di Lombardia, e aveva indossato anche la maglia rosa. Anch’io da grande sarei stato un corridore, e un giorno sarei andato ai Mondiali. L’avevo deciso molto tempo prima…
Eravamo a tavola, e ci eravamo sorpresi quando il babbo si era messo a parlare. Lui di solito preferiva ascoltare.
«Domani andiamo a Imola a vedere Gimondi.»
Quelle poche parole ci avevano aperto di colpo le porte del mondo. Sapevamo che quel primo settembre del ’68 era la domenica dei Mondiali di ciclismo, ma non avevamo mai osato pensare di poterci essere anche noi. La sera avevo fatto fatica a prendere sonno: in testa mi immaginavo tutto quello che avrei trovato là fuori: un universo grande, colorato e rumoroso che io non avevo mai visto. Non ero mai stato a Imola, veramente non ero mai stato da nessuna parte. Ascoltavo il respiro ritmato di mio fratello, e mi chiedevo come facesse a dormire. Quella non era una notte come le altre. Io resistevo, ostinato: avevo paura che se i miei ci avessero trovati addormentati, magari avrebbero cambiato idea, e addio campionato del mondo. Ma a forza di sognare a occhi aperti ero crollato. Quando erano venuti a svegliarci, fuori era buio fondo, non si vedeva neanche la casa dei nonni alla fine dei campi. Avevamo caricato sulla Millecento la sporta che la mamma aveva preparato con una pagnotta, il salame, un po’ di frutta, l’acqua e due cioccolatine per me e per Fabio. Noi due ci eravamo incastrati sul sedile di dietro.
«Babbo, ma Gimondi vince oggi?»
Lo avevo domandato almeno tre volte nei quindici chilometri che separavano casa nostra, a San Mauro, dal circuito iridato. Mio padre non mi aveva risposto, ma quello era normale. Tutto il resto invece era stupefacente. Il babbo aveva rallentato, dopo un po’ aveva trovato un posto dove lasciare la Millecento, e noi ci eravamo piazzati in cima al terz’ultimo strappo, dalla parte opposta vedevo la discesa del Ghiandolino. Giusto il tempo di ambientarmi e avevo cominciato a tormentare un’altra volta mio padre.
«Babbo, ma quando arriva Gimondi?»
Lo aspettavo, Gimondi, anche se non potevo dire di sapere esattamente che cosa facesse. Però al mio babbo piaceva, lo nominava spesso, quindi anch’io ero tifoso di Gimondi. Di Gimondi e del Bologna, perché nel pallone i preferiti del babbo erano Pascutti e Bulgarelli. Infatti erano anche i miei preferiti.
«Babbo, ma dov’è Gimondi?»
Il campionato del mondo era partito ma io avevo visto soltanto passare un turbine di corridori, così velocemente che non ero riuscito a distinguerne neanche uno. Attaccato ai pantaloni di mio padre, non smettevo di fare la stessa domanda, come un’ossessione.
«Qual è Gimondi? Qual è Gimondi?»
Ci avevo messo tre giri prima di vederlo, e da quel momento era stato per sempre il mio campione. Alto, le gambe lunghissime, i capelli tutti tirati all’indietro, la faccia seria, sembrava arrabbiato, e si voltava indietro, si guardava attorno. In un lampo avevo registrato tutti i dettagli. L’azzurro della maglia, i gomiti piegati, l’ansia disegnata sulla faccia tesa. Quel giorno non aveva vinto Gimondi: aveva vinto un altro italiano, Adorni, che si chiamava Vittorio come il mio babbo. Era stato proprio in quel momento che avevo deciso: nella vita sarei stato un corridore, e un giorno avrei vestito anch’io la maglia azzurra al campionato del mondo.
Ma questo era stato sei anni prima. Ormai ero grande, avevo la mia bicicletta. Avevo fatto i conti precisi per non arrivare alla partenza troppo presto e ovviamente neanche troppo tardi. A forza di deviare e di allontanarmi, di prendere uno sterrato e provare una nuova scorciatoia, quando mi ero presentato al via della mia prima corsa avevo già nelle gambe ottanta, forse novanta chilometri. C’eravamo proprio tutti, così tante biciclette non le avevo mai neppure immaginate. C’erano quelli che ci dormivano, con la bicicletta, la sera se la mettevano di fianco al letto. Io non ne avevo bisogno, l’unica cosa che non mancava in campagna era lo spazio, la bici me la facevano tenere nella camaràza, dove i miei conservavano il vino e l’olio, al freddo. Continuavo a guardarmi attorno, eravamo tantissimi, non mi ero mai sentito così grande in vita mia. Neanche quando il babbo la domenica mattina mi mandava fuori a lavare le ruote del camion, che erano tantissime, sedici, e prima di essere arrivato in fondo mi si erano gelate le mani.
Mi incantavo a guardare tutte quelle biciclette, a indovinare le piccole differenze fra una e l’altra, ammiravo i colori, li vedevo luccicare sotto i raggi del sole. Sapevo per istinto che questo sarebbe stato il mio mondo, la mia vita. Una vita meravigliosa. Come quella del babbo che guidava il camion, e qualche volta, d’estate, quando non c’era la scuola, mi prendeva su. Quando eravamo in viaggio da un tempo che mi sembrava sufficientemente lungo, cominciavo a dargli il tormento perché volevo che si fermasse alla prima edicola: dovevo assolutamente prendere le figurine Panini perché ero sicuro che lontano da casa avrei trovato dei giocatori diversi da quelli che vendeva il giornalaio di Solarolo.
Fare il corridore doveva essere bello almeno come guidare il camion: mentre lavori, puoi vedere il mondo che ti scorre veloce accanto. Sì, questa sarebbe stata la mia vita.
Avevo dato un’occhiata ai premi che qualcuno aveva preparato sul palco per i primi tre classificati e mi ero chiesto che effetto avrebbe fatto sentirsi chiamare e ringraziare, magari ci sarebbe stato anche qualcuno a battere le mani.
Mentre ero perso nel mio mondo fantastico, la mia prima corsa era partita, e improvvisamente mi sembrava di volare, tutti andavano fortissimo. Cercavo di orientarmi mentre avversari molto più grandi di me cominciavano a scattare avanti e indietro. Io non ne lasciavo scappare neanche uno. Appena uno aumentava il ritmo, ricucivo lo strappo.
Non avevo mai dimenticato quella volta che col babbo eravamo andati ad aspettare i corridori sulla Pergola. Era il ’71, un giorno di primavera, il giorno della prima gara di mio fratello con la Solarolese. Erano partiti da Traversara, dovevano fare due giri sui Monti Coralli e poi tornare al punto di partenza. Noi avevamo riempito le borracce e le avevamo caricate sulla Millecento. Avevamo deciso di aspettare Fabio sulla salita. Per prime erano passate le staffette, e avevo sentito quella fitta di impazienza che accompagna sempre l’attesa dei ciclisti. Erano arrivati i primi.
«C’è una fuga.»
Poi era toccato al gruppo.
«Si sarà fatto staccare.»
Erano passati anche gli ultimi, ma mio fratello non si era visto. Eravamo tornati verso la macchina con le nostre borracce, e avevamo preso la strada di casa. Avevo provato a indovinare la faccia di mio padre, e voltandomi verso di lui lo avevo visto triste, dispiaciuto. Però non diceva niente. Allora avevo parlato io.
«Babbo, stai tranquillo. Quando correrò io queste figuracce non le farò.»
Quella era stata l’unica corsa della carriera di Fabio, o dovrei dire mezza corsa: si era ritirato, e non ci aveva più riprovato.
Io invece in quella prima corsa della mia vita ci provavo tutte le volte che qualcuno scattava: lo rincorrevo per stargli a ruota. E così mi ero sfinito. Quando avevo visto il traguardo là davanti non avevo più un grammo di forza da tirare fuori per la volata finale: sulla linea bianca mi ero visto passare davanti tutto il gruppo, compresa una ragazza. Non ero rimasto neanche ad aspettare la premiazione, anche perché avevo ancora più di venti chilometri prima di tornare a casa. In bicicletta, naturalmente.
Non avevo più cambiato idea. Neanche quando mia madre insisteva perché studiassi e prendessi un diploma. Il mio obiettivo era sempre e solo quello: fare il corridore, diventare un professionista. L’idea di libertà che ti regala stare in sella a una bici è qualcosa di impagabile, quando non senti più la fatica del vento sulla faccia, il sudore, e continui a macinare pedalate andando avanti solo con il cuore. Perché già allora capii che non si trattava solo di uno sport, era qualcosa di più. Oggi posso dire che il ciclismo è una visione del mondo. Così tutto il resto lo liquidavo nel più breve tempo possibile: la scuola, i compiti. Anche quando d’estate mi mandavano a lavorare perché non rimanessi tutto il giorno senza fare niente, il mio unico pensiero era finire abbastanza in fretta per poter uscire con la bicicletta che avevo ereditato da mio fratello.
Scoprire presto la mia passione è stata la mia grande fortuna. Capire in anticipo qual è il tuo sogno, che cosa ti fa sentire meglio, ti fa sentire vivo, libero, ti dà forza. Ti permette di non perdere tempo in cose che non sono così importanti e di superare tutti gli ostacoli, piccoli e grandi, che trovi sulla tua strada.
La bici è stata il mio chiodo fisso. Non ho mai mollato, ho sempre continuato a inseguire, a correre, a faticare. L’ostinazione e la tenacia sono state forse le mie qualità migliori. Sono nato sotto il segno del Capricorno, come mio padre e mio nonno Mario. Noi Cassani abbiamo la testa dura, è una dote che serve, soprattutto per la mia passione. Il ciclismo è uno sport di fatica, e ti insegna subito che devi sempre mettercela tutta. Con gli altri il confronto è immediato, feroce: se uno ti stacca vuol dire che tu vai più piano. Ma non per questo devi mollare.
Da piccolo non riuscivo a stare fermo. Anche le vacanze le vivevo come una tortura, perché non potevo portarmi dietro la bicicletta: non vedevo l’ora di tornare a casa e di pedalare dove volevo. Quella era la libertà. Mia madre si arrabbiava, mi rincorreva con il metro da sarta, ma io andavo più veloce: prima che mi prendesse ero già scappato a casa dei nonni. Io e lei avevamo idee diverse. Mi mandava a scuola con i pantaloni corti, e io mi vergognavo perché i miei compagni avevano già i calzoni lunghi. E d’estate mi mandava a letto tutti i pomeriggi, diceva che era troppo caldo per starmene in giro: così facevo finta di dormire, aspettavo che lei crollasse e scappavo. Una volta è andata a finire male: ero uscito in bicicletta con Giuseppe, che abitava di fronte a casa mia. Correvamo verso la chiesa, e io ero andato a sbattere contro un albero: quando mi ero tirato su avevo visto il sangue, mi ero fatto un taglio enorme sulla fronte, e la mia preoccupazione era come spiegarlo a mia madre. Ero corso da mia zia, che mi aveva portato al pronto soccorso: me l’ero cavata con cinque punti. Ma il peggio doveva ancora arrivare: sapevo che a casa avrei preso una punizione.
Mentre aspettavo di essere abbastanza grande per fare il corridore, suonavo il sax nella banda del paese e giocavo a pallone. Ero un attaccante, ero bravino, facevo gol. Il Solarolo calcio mi aveva ceduto al Castelbolognese. E il mio nuovo allenatore, Zanetti, spesso mi teneva in panchina, il posto più triste del campo di calcio. Mentre ero lì seduto, sconsolato, pensavo alla mia Valla grigia, sui pedali nessuno mi avrebbe detto dove stare. Una domenica mattina di novembre ero tornato a casa e avevo abbandonato la borsa del Castelbolognese in un angolo. Mancavano meno di due mesi al mio quattordicesimo compleanno, quel giorno il babbo mi avrebbe tesserato per la Solarolese, dove mi aspettava il mio amico Davide De Palma, che correva già con loro da un paio d’anni.
La bicicletta non mi ha mai deluso: quando ho cominciato ad allenarmi ero io a decidere con chi uscire, che strade fare, che montagne scalare. Quando tornavo a casa pulivo la bicicletta come avrebbe fatto un pittore con i suoi pennelli: usavo lo shampoo per il telaio, la nafta per la catena e le calze rotte di mia madre per lucidarla senza lasciare pelucchi. Poi andavo a letto con un cuscino sotto i piedi, come mi aveva consigliato il mio primo direttore sportivo.
«Le gambe devono stare alte, altrimenti si gonfiano.»
Si chiamava Ernesto Montevecchi e di mestiere faceva il cantiniere. La nostra ammiraglia era la sua Fiat 128, con il portabiciclette sopra. Era lui a dirci come correre, cosa mangiare, persino cosa leggere.
La bici è sempre stata il mio unico vizio. I miei amici mi prendevano in giro perché non volevo fare tardi, non andavo in discoteca il sabato sera, non fumavo e avevo bevuto soltanto una volta in vita mia. Era successo quando avevo tre anni: avevo trovato una bottiglia sulla tavola e me l’ero scolata tutta. Ero stato così male che non c’era mai stata una seconda volta.
Quando ho compiuto sedici anni mio padre aveva deciso di regalarmi una bicicletta nuova e mi aveva portato a Faenza, nella bottega di Vito Ortelli. Ortelli lo conoscevo, lo conoscevano tutti: era una leggenda, aveva vinto anche contro Fausto Coppi. Guardavo le bici che costruiva su misura e mi sembrava di essere in paradiso. Quel giorno mi aveva preso le misure, e aveva detto che sarebbe stata pronta in un mese. Mi ricordo ancora il prezzo: 330.000 lire, il doppio di uno stipendio di un operaio. Una pazzia.
In poco tempo Ortelli era diventato un’abitudine. Andavo nella sua bottega e lui stava lì a raccontarmi per ore di quando faceva il professionista, di quando aveva vinto il campionato italiano Allievi, e di quella volta che aveva mangiato venticinque uova in un Giro di Toscana. E poi c’era quella famosa storia di Coppi, quando Vito lo aveva battuto sulla pista del Vigorelli. Mi incantavo ad ascoltarlo, e sognavo quello che sarebbe successo a me. Non potevo sapere che un giorno anche mia madre era stata lì, aveva chiesto a Ortelli di convincermi a lasciar perdere il ciclismo. E lui ovviamente non l’aveva fatto.
«Mamma, questa è la mia vita e decido io cosa farne. Tu hai scelto la tua, la mia lasciala scegliere a me.»
L’avevo convinta con la promessa che non avrei abbandonato la scuola senza prendere il diploma. Ma la mia passione non era fare il ragioniere, questo ormai lo sapevo da un pezzo.
A diciassette anni il ciclismo riempiva le mie giornate. Quel 19 maggio del 1978 lo aspettavo da mesi, da quando avevo saputo che una tappa del Giro d’Italia sarebbe arrivata sul Trebbio, una delle mie salite del cuore. Ero andato ad aspettare la corsa, e dieci anni dopo il mio campione era ancora quello della prima volta. Gimondi non era più il capitano della Bianchi, la maglia rosa ce l’aveva un suo compagno di squadra, Johan De Muynck. Ero andato sul Trebbio in bicicletta, ma ancora una volta troppo in anticipo: e allora ero sceso, ero tornato su, ero sceso di nuovo. Tormentavo la radio, e tutte le volte che vedevo passare una macchina con le insegne della corsa sbirciavo dentro il finestrino. Alla fine mi ero p...